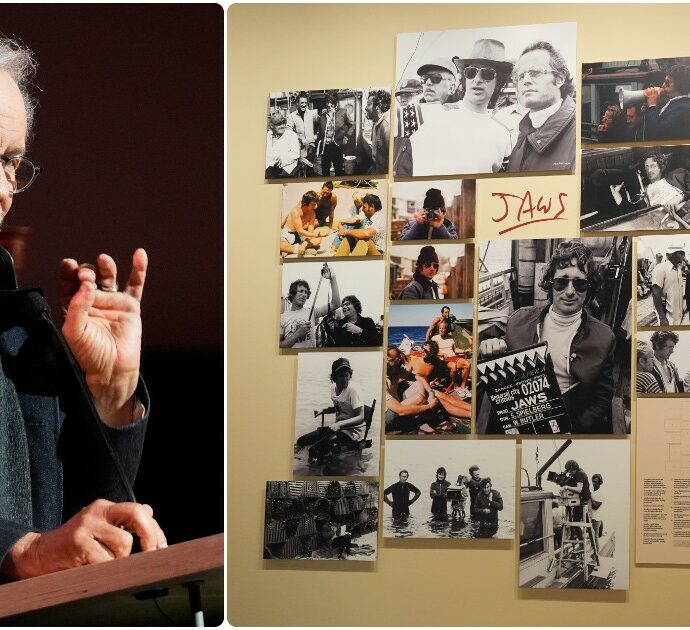“I nostri padri e le nostre madri hanno combattuto per qualcosa che non morirà”. Difficile è scegliere fra le tante frasi-manifesto esibite in Star Wars – L’ascesa di Skywalker, altrimenti detto Episodio IX, ovvero la chiusura della trilogia “sequel” ma anche – verosimilmente – quella definitiva dell’intera saga ideata da George Lucas nel 1977.
E tale “gran finale” faceva temere gli eserciti di fan planetari del franchise cinematografico più lungo della storia del cinema, benché con il timone saldamente tornato nelle mani di J. J. Abrams le paure potevano attenuarsi. Il vate di Lost, che già s’era incaricato (anche produttivamente) del primo episodio dei sequel (Il risveglio della forza, 2015) lasciando invece al collega Rian Johnson il secondo (Gli ultimi Jedi, 2017) ha capito che l’unica via per uscirne indenni era (tentare di) ridestare la dimensione epica. Che, diciamolo subito, emerge in pompa magna nelle parti conclusive dell’opera.
Dando dunque per acquisiti e scontati gli strombazzamenti acustici, le peripezie visive e l’immancabile commento musicale dell’eterno John Williams (l’unico vero eroe della Resistenza galattica..) in 142’ senza di pause ferire, Episodio IX (ri)trova tuttavia la sua identità nell’empireo di Guerre Stellari solo grazie ai fantasmi di quei “padri e madri” combattenti di cui sopra. Il che può apparire paradossale alla luce dei giovani rampanti che si agitano tra fanta-deserti e spazi siderali, ma non lo è nel momento in cui si comprende che il “senso del tutto” pertiene all’origine dell’epopea. Tornare alla sorgente primigenia per chiudere il cerchio, classicissima operazione narrativa di ogni franchise monstre, era fondamentale per ripristinare la Leggenda, rendendola il più possibile intellegibile alle nuove generazioni, immuni dalla catarsi totalizzante del mitico Episodio IV.
E allora ecco risorgere i morti. Perché “i morti parlano”, come da dichiarazione scritta subito sull’immutato cartello ascendente fra gli astri dopo l’immancabile “In una galassia lontana lontana..” Quei morti, si sa, sono sempre loro: la compianta Carrie Fisher (le cui apparizioni nel film – si raccomandano a precisare i produttori – non nascono da rigenerazione in CGI bensì dal montaggio di scene tagliate dei precedenti episodi e sapientemente inserite nel nuovo lungometraggio), Luke Skywalker e Han Solo, rispettivamente gli alive & kicking Mark Hamill e Harrison Ford.
Garanti della Memoria del pubblico, sono i veri ispiratori e “respiratori” del film di Abrams, coloro che detengono il sacro carisma di un vintage evergreen, qualità (purtroppo per loro) assente nei pur volenterosi personaggi “giovani” e nei loro interpreti. Non basta la bellezza da Diana cacciatrice della Jedi junior Rey (Daisy Ridley ), l’intensità tragica di Kylo Ren (Adam Driver, l’unico vero “divo” nuovo della saga) e la spavalderia espressa dal duo combattente Poe (Oscar Isaac) e Finn (John Boyega): solo quando riappaiono i “vecchi” le platee si infiammano, la musica s’innalza melodica e il Mito risorge. Con loro, e come loro, gli altri collanti col passato – ma sul versante comico-tenero – sono scimmioni, androidi e robottini: Chewbecca, C-3PO, R2D2 (copia del leggendario C1-P8) a cui si è aggiunto il simpatico e “tuttotondo” BB-8.
Fantasmi e robot, alla fine, sono coloro che tengono la Forza contro il suo lato Oscuro che – in termini cinematografici – si chiama noia: essa compare, purtroppo, anche in questo meta-finalone della saga delle saghe, tenuta in piedi soprattutto nei momenti in cui nessuno combatte e i personaggi – magicamente – si guardano, si abbracciano, respirano… I giochi ormai sono fatti e la guerra (senza spoiler) sarà vinta al botteghino, ma una provocazione appare lecita: Star Wars doveva chiudere, ovviamente, e ci si chiede fino a che punto fosse necessario spremerlo (e rovistarne parentele, affiliazioni e quant’altro..) fino ad esaurimento conclamato. Il film è nelle sale da oggi.