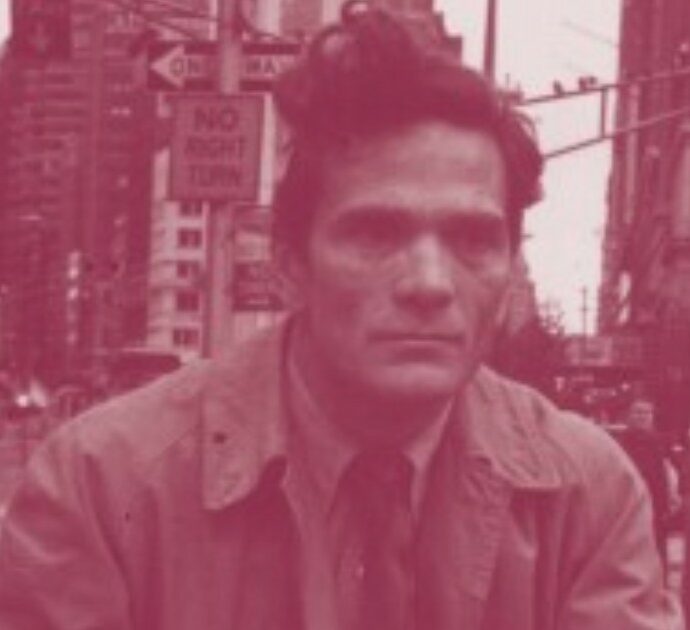Sandro Veronesi deve essere stato uno di quegli studenti che per scrivere il tema d’italiano utilizzava sempre quattro fogli protocollo tra lo stupore della classe. “Veronesi lei è bravo – gli diceva la prof – ma le stesse cose le più raccontare con un foglio o due”. Impenitente il nostro, da allora non fa altro che corroborare l’assunto (inventato). Il colibrì (La Nave di Teseo) ne è la cosiddetta pistola fumante. Perduto e felice nel gorgo del prisma Nathan Zuckerman di Roth, l’autore toscano inventa Marco Carrera, oculista benestante, genitori architetti fiorentini, fratelli e sorelle inquiete (la dedica iniziale, che storia), l’amico che porta iella, la figlia con il filo sulla schiena, corna scoperte all’improvviso, ma anche corna più o meno volontariamente rifatte alla moglie indietro e da tempo. Lettera su lettera, ricordo su ricordo, salto temporale su salto temporale, la saga familiare che si erge attorno alla figura di Carrera è qualcosa di così sublime (e subliminale), di incredibile (e credibilissimo), di denso (e stratificato) da lasciare naso e occhi appiccicati sulle 355 pagine (più silloge di citazioni fino a 366) per quelle due/tre ore filate sopra il divano. Nonostante i continui strappi dolorosi la trama è briosa, il tono è spiritoso, il linguaggio che si macchia e ingloba sempre questa volgarità terminologica alta (“quella bellezza era stata lo sputo che aveva tenuto insieme suo padre e sua madre”) semplicemente incanta. Finisci la lettura e non sai più quale sia l’apice del racconto (noi votiamo le pagine in cui Adele (!), la figlia di Carrera, partorisce) per quanti l’autore ne abbia disseminati a(ma)bilmente nel testo. Non fateci il solito film, please. Lasciatelo vivere, Il colibrì, con le sue alette eternamente battenti, nella meraviglia della poesia sulla carta e nell’immaginazione del lettore. Voto 9
Sandro Veronesi deve essere stato uno di quegli studenti che per scrivere il tema d’italiano utilizzava sempre quattro fogli protocollo tra lo stupore della classe. “Veronesi lei è bravo – gli diceva la prof – ma le stesse cose le più raccontare con un foglio o due”. Impenitente il nostro, da allora non fa altro che corroborare l’assunto (inventato). Il colibrì (La Nave di Teseo) ne è la cosiddetta pistola fumante. Perduto e felice nel gorgo del prisma Nathan Zuckerman di Roth, l’autore toscano inventa Marco Carrera, oculista benestante, genitori architetti fiorentini, fratelli e sorelle inquiete (la dedica iniziale, che storia), l’amico che porta iella, la figlia con il filo sulla schiena, corna scoperte all’improvviso, ma anche corna più o meno volontariamente rifatte alla moglie indietro e da tempo. Lettera su lettera, ricordo su ricordo, salto temporale su salto temporale, la saga familiare che si erge attorno alla figura di Carrera è qualcosa di così sublime (e subliminale), di incredibile (e credibilissimo), di denso (e stratificato) da lasciare naso e occhi appiccicati sulle 355 pagine (più silloge di citazioni fino a 366) per quelle due/tre ore filate sopra il divano. Nonostante i continui strappi dolorosi la trama è briosa, il tono è spiritoso, il linguaggio che si macchia e ingloba sempre questa volgarità terminologica alta (“quella bellezza era stata lo sputo che aveva tenuto insieme suo padre e sua madre”) semplicemente incanta. Finisci la lettura e non sai più quale sia l’apice del racconto (noi votiamo le pagine in cui Adele (!), la figlia di Carrera, partorisce) per quanti l’autore ne abbia disseminati a(ma)bilmente nel testo. Non fateci il solito film, please. Lasciatelo vivere, Il colibrì, con le sue alette eternamente battenti, nella meraviglia della poesia sulla carta e nell’immaginazione del lettore. Voto 9
Cultura
Lo scaffale dei libri, la nostra rubrica settimanale: diamo i voti, da Veronesi a McEwan