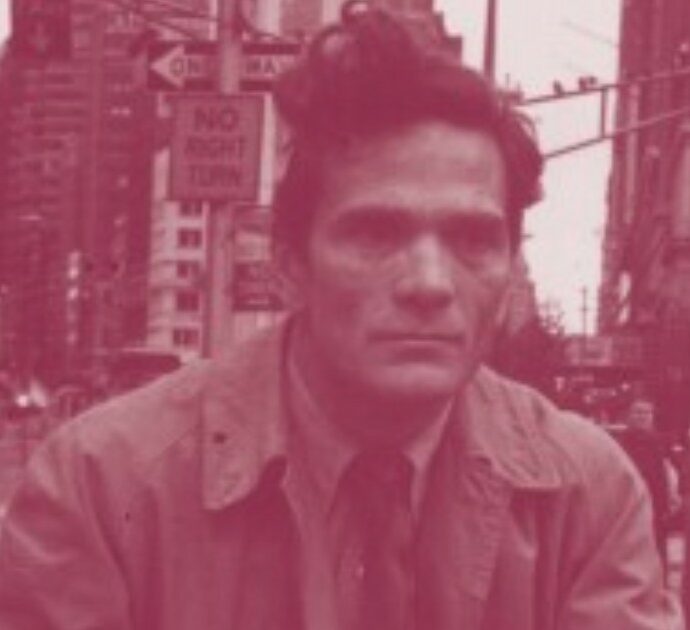I giorni del giudizio - 2/4
 C’è un duplice omicidio in una ricca villa della provincia lucchese. C’è un vecchietto in un ospizio che osserva una strana figura di donna nuda correre nella notte. C’è una giovane proprietaria di una boutique ex attrice che assieme ad un’altra mezza dozzina di concittadini qualunque viene convocata per vestire i panni di giudice in un processo in Corte d’Assise. I giorni del giudizio di Giampaolo Simi (Sellerio) è un divertissment in punta di penna, stringato, in certi momenti perfino macchiettistico, dove detection di provincia e meccanismo giudiziari nazionali si mimetizzano tra le pieghe di un’umanità sparsa e infinitesimale, colorata sempre di uno humor a dire il vero più conficcato cinematograficamente nei dialoghi che nelle situazioni. I giudici improvvisati, più banda del buco che parola ai giurati, scoppiettano ma poi alla lunga allappano, proprio come le Frizzy Pazzy alla terza bustina. E nonostante Simi sia scrittore talentuoso, dal fraseggio rapido, secco, descrittivo, paratassi puntuta alla Lucarelli tv, è affetto da uno strano morbo (e non è il solo oggi in Italia): quello che potremmo chiamare dell’ “attualizzazione politica forzata”. Una specie di patologia letteraria che è un desiderio di continua conferma verso il lettore, notevolmente destrutturato e destrutturante rispetto alla distanza che il racconto avrebbe di per sé, sorta di elastico di senso tra finzione e realtà. Un esempio? Ospizio di vecchietti. Gli anziani parlano tra di loro dell’omicidio in villa e uno, due di loro, confermano che sono stati gli slavi, gli albanesi (“ti entrano in casa per rubare e se trovano qualcuno”…) D’accordo, è la riduzione farsesca del pensiero conservatore rozzo, volgare, ecc.. ma perché deve invadere il racconto? Il lettore non ha bisogno di conferme del suo verbo quotidiano. Vive, sempre e comunque, di fabula (Pennac e Il paradiso degli orchi, per stare da quelle parti). Voto: 6
C’è un duplice omicidio in una ricca villa della provincia lucchese. C’è un vecchietto in un ospizio che osserva una strana figura di donna nuda correre nella notte. C’è una giovane proprietaria di una boutique ex attrice che assieme ad un’altra mezza dozzina di concittadini qualunque viene convocata per vestire i panni di giudice in un processo in Corte d’Assise. I giorni del giudizio di Giampaolo Simi (Sellerio) è un divertissment in punta di penna, stringato, in certi momenti perfino macchiettistico, dove detection di provincia e meccanismo giudiziari nazionali si mimetizzano tra le pieghe di un’umanità sparsa e infinitesimale, colorata sempre di uno humor a dire il vero più conficcato cinematograficamente nei dialoghi che nelle situazioni. I giudici improvvisati, più banda del buco che parola ai giurati, scoppiettano ma poi alla lunga allappano, proprio come le Frizzy Pazzy alla terza bustina. E nonostante Simi sia scrittore talentuoso, dal fraseggio rapido, secco, descrittivo, paratassi puntuta alla Lucarelli tv, è affetto da uno strano morbo (e non è il solo oggi in Italia): quello che potremmo chiamare dell’ “attualizzazione politica forzata”. Una specie di patologia letteraria che è un desiderio di continua conferma verso il lettore, notevolmente destrutturato e destrutturante rispetto alla distanza che il racconto avrebbe di per sé, sorta di elastico di senso tra finzione e realtà. Un esempio? Ospizio di vecchietti. Gli anziani parlano tra di loro dell’omicidio in villa e uno, due di loro, confermano che sono stati gli slavi, gli albanesi (“ti entrano in casa per rubare e se trovano qualcuno”…) D’accordo, è la riduzione farsesca del pensiero conservatore rozzo, volgare, ecc.. ma perché deve invadere il racconto? Il lettore non ha bisogno di conferme del suo verbo quotidiano. Vive, sempre e comunque, di fabula (Pennac e Il paradiso degli orchi, per stare da quelle parti). Voto: 6