Chissà se sono uno smart worker, che tradurrei con lavoratore intelligente. Se sono intelligente, invero, lo giudicheranno i miei studenti, i revisori delle riviste scientifiche, i lettori dei libri divulgativi che mi ostino a scrivere. Per certo, da tre mesi sono un lavoratore a distanza, un remote worker. E mai come ora – da quando galleggio nel tempo sospeso di questa pandemia – rispetto scrupolosamente gli orari, gli impegni, gli adempimenti burocratici.
La sollecitazione trasmessa via internet è assai più immediata e indilazionabile – urgente anche quando non lo sarebbe – di qualunque istanza che studenti, colleghi, amministrazione possano indirizzare a un vecchio professore in presenza; e ogni eventuale rimbrotto è più rosicante.
Smart working è un neologismo affatto italiano. Da tempo gli italiani inventano neologismi un po’ surreali, talvolta veri e propri ossimori: rischio idrogeologico, bomba d’acqua, convergenze parallele; senz’altro poetici: immoto andare. Finora usavano la lingua di Dante, con ovvio imbarazzo dei traduttori. Ora, volendo evitare siffatti imbarazzi, si sono allargati al globish, la lingua low-cost che possiamo parlare tutti.
E con smart working, termine quasi sconosciuto nel mondo, gli italiani chiamano molte cose, anche diverse: il telelavoro da casa propria, il lavoro mobile, quello flessibile, quello a obiettivi, privo dai vincoli spaziali e temporali. Tutte attività apparentemente legate ai nuovi modelli del XIX secolo, battezzate tre anni fa dalla legislazione lavoro agile, intelligente o stupido che sia.
Se il legislatore voleva incrementare la competitività e conciliare tempi di vita e di lavoro, ha fallito. La società ha sonnecchiato a lungo, esiliando il lavoro agile tra gli scenari di un futuro magico piuttosto che tentare di praticarlo nel presente. Ma la pandemia ha cambiato tutto. Il dramma del Covid-19 ha catapultato il paese nell’era telematica che la maggior parte degli italiani viveva già, ma un po’ distrattamente, azionando sempre e comunque la protesi dello smartphone senza conoscerne la potenza.
Molti italiani lavorano a distanza con le pantofole ai piedi e la colazione sul tavolo, usando laptop, tablet o perfino smartphone. Per riuscirci, hanno modificato la routine casalinga, rivoluzionato casa propria, imposto orari rigidi a se stessi e ai familiari. E ce l’hanno fatta, ricavandone una sensazione piacevole, uno stile esistenziale al quale sarà difficile rinunciare. E sono proprio i più giovani ad apprezzare questo stile di vita, anche se temono la ridotta o perlomeno diversa socialità associata a questo stile.
La velocità della rete è importante, ma senza esagerare. Nel 2018, il 65% delle famiglie statunitensi aveva una connessione Internet con 100 o più Mbps, ma ha scoperto che la velocità di banda non è così importante: per la maggior parte delle persone non ci sono grandi differenze tra 50, 100 e 1.000 Mbps. Nello stesso anno, il 74% delle famiglie italiane era connesso ad almeno 30 Megabit al secondo. Estendere questa capacità dovrebbe essere il primo obiettivo, perché ci sono province dove solo il 50% delle famiglie è allacciato a una rete siffatta. E non parliamo di Siracusa (dove il 90% lo è) ma di Alessandria, Pavia, Rovigo.
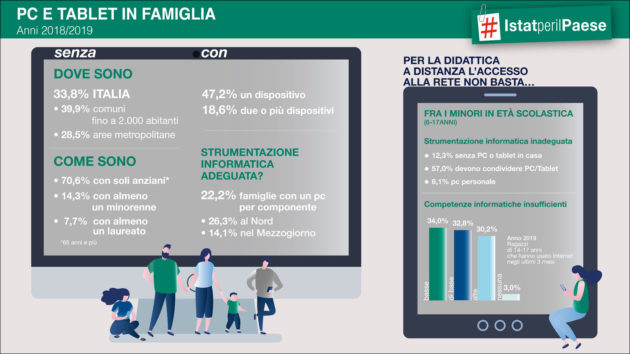
Confinamento “virale” e telelavoro hanno modificato il senso e il valore del nostro tempo. Secondo molte indagini, la produttività non diminuisce, bensì aumenta nell’ambito della impresa privata, siano grandi o piccole aziende; e la nota positiva comprende il freelance che lavora così da molto tempo. Secondo Forbes, lavorare da casa sta innalzando la produttività, ma si lavora anche di più: anche qui non bisogna esagerare. E lavorare a distanza è molto più produttivo quando questa modalità ha anche migliorato la qualità e l’efficacia del lavoro, trasformando in smart anche attività che erano un po’ stupid.
Al contrario di quanto accade nel Regno Unito, dove la produttività della Pubblica amministrazione è aumentata e il governo intende prolungare indefinitamente il lavoro remoto, l’esperienza pubblica italiana è stata finora deludente. Una indagine di Promo P.A. svela che la Pubblica Amministrazione, chiamata alla prova dello smart working, sta registrando un gap di produttività del 30% in meno rispetto al lavoro in presenza.
Lo stesso studio suggerisce due interventi per migliorare l’utilizzo del lavoro a distanza:
1. l’attivazione di un piano di investimenti in digitalizzazione e tecnologie;
2. l’avvio di un percorso formativo dei dipendenti, finalizzato a nuovi metodi di lavoro, basati su collaborazione orizzontale, uso costante della tecnologia, obiettivi condivisi. Suggerimenti del tutto condivisibili, ma destinati a migliorare le cose soltanto marginalmente, se il paese non abbandona il Burocracene, l’era funesta che l’Italia ha inaugurato da almeno 30 anni.
Come ho scritto in un saggio sull’università, pubblicato sia in italiano sia in globish, “non è l’informatica che può semplificare la vita collettiva, lavorativa e sociale, ma l’applicazione della logica. E, soprattutto, del buon senso. Applicando regole borboniche con spirito asburgico, la dematerializzazione si traduce in uno strumento di puro controllo, frutto della ‘metamorfosi dello Stato da macchina amministrativa a macchina cibernetico-governamentale’. Nessun webmaster è in grado di rendere intelligenti regole stupide. Senza cancellare le norme assurde e contraddittorie e gli esercizi labirintici, la dematerializzazione è solo l’anello al naso imposto dal Grande Fratello”.
Anche disponendo di tecnologie digitali avanzatissime e una rete internet iper-veloce, il lavoro remoto dei dipendenti pubblici non potrà mai essere smart, se deve applicare norme, regolamenti e pratiche affatto stupid.
Articolo Precedente
Ilva, Mittal prolunga la cassa integrazione di 5 settimane alla vigilia della presentazione del nuovo piano: potrà usarla per 8.173 operai

Articolo Successivo
Coronavirus, Anpal: “Nel 2020 si perderanno 500mila posti di lavoro. Recuperati nel 2023”







