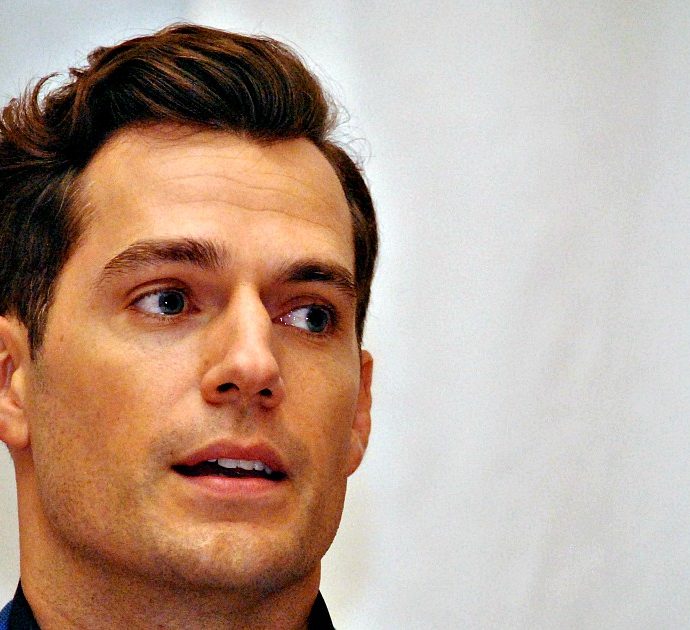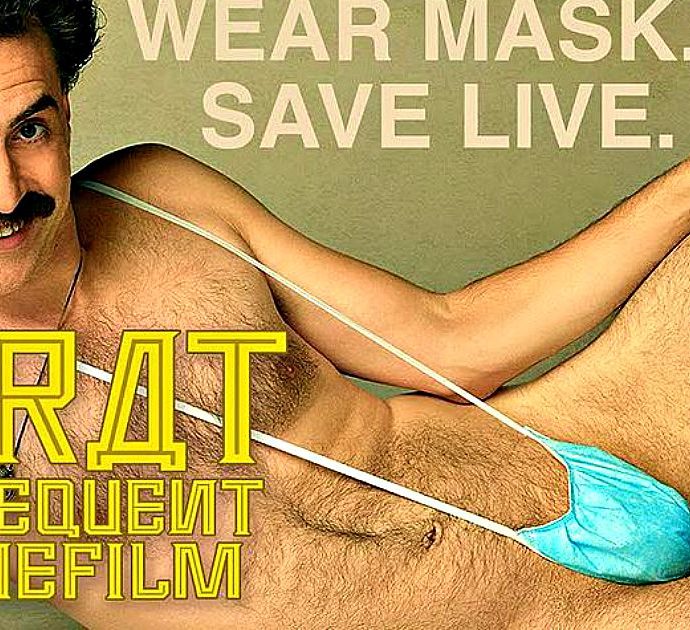Ci sono film che ribaltano ogni certezza. Specie se riferita al senso del vedere, estremizzando la relatività del tempo. I’m Thinking of Ending Things (“Sto pensando di finirla qui”) di Charlie Kaufman è uno di questi. Poco stupore, si potrebbe obiettare, di fronte a uno degli sceneggiatori (in primis) e registi (in seguito) che ha fatto della sovversione e frattura spazio-temporale la cifra del proprio cinema, ma nel caso di questo suo terzo film alla regia e ottavo alla sceneggiatura sembra avvertirsi il raggiungimento di una maturità e una complessità cinematografiche oltre le aspettative. Anche oltre il cult Se mi lasci ti cancello che Kaufman scrisse nel 2004 per Michel Gondry e con cui vinse il suo primo Oscar.
Disponibile dal 4 settembre su Netflix, il film è tratto dall’omonimo romanzo del sorprendente esordiente canadese Iain Reid e mette in scena un quartetto di solidi attori (Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette e David Thewlis) perfettamente adattati ai personaggi in funzione dell’enigma narrativo in cui sono racchiusi. La trama, se così possiamo definire uno script di Kaufman, appare semplice: Jake (Plemons) e Lucy (Buckley) sono promettenti fisici e stanno insieme da poco tempo, ma Jake ritiene sia il momento che la ragazza conosca i suoi genitori (Collette e Thewlis) che abitano in una fattoria sperduta nella provincia americana.
È pieno inverno, la neve cade incessante, nel percorso la coppia dialoga dei massimi sistemi, spesso mutuando citazioni altrui, dalle liriche di Wordsworth (non a caso le Lucy Poems) ai brani del musical Oklahoma!, al dialogo si sovrappone la voice over di Lucy come monologo interiore che trama l’ipotesi di lasciarlo (il titolo “I’m Thinking of Ending Things”, cioé “Sto pensando di finirla qui” si riferisce in prima istanza a questo). Il viaggio si dilata nel contesto della durata del film, la macchina da presa li inquadra da varie angolazioni, nervosamente. Il punto di vista è quello di Lucy. Una volta raggiunta la fattoria e conosciuti i genitori di Jake il ritmo cambia, è lo spazio a dilatarsi mentre il tempo impazzisce e i corpi diventano mutanti.
Si passa da un’affinità cinematografica con John Cassavetes (non a caso è citato Una moglie, 1974) a una con David Lynch, comprendendo nello scorrere dell’anti-narrazione che il flusso di coscienza ha cambiato di segno (sostanzialmente il punto di vista) e che a vincere alla fine è il cinema, quello puro potente e straordinariamente visionario, cioè capace di lavorare sulla propria quintessenza, la dialettica visibile e invisibile. Non siamo in uno di quei film di Chris Nolan in cui la testa silenzia il sentimento, al contrario I’m Thinking of Ending Things porta alle estreme conseguenze il sentire, il patire, il rimosso quale motore principe della dissociazione fra realtà e fantasia, l’incubo presente che distorce il passato per non affrontare il futuro.
Kaufman, che dice di aver seguito gli spunti del romanzo, compie rispetto alla parola scritta ciò che qualunque regista dovrebbe fare, portare lo spettatore sulla vetta di una montagna e farlo precipitare senza paracadute chiedendogli un atto di fede nel cinema, quello maiuscolo. Il collage di generi che adotta l’artista newyorkese non contempla la contaminazione bensì la giustapposizione, vera e tangibile: si passa dal dramma intimista al family grottesco, dall’horror al musical ripassando al road movie per chiudersi con il melo nostalgico. Se la scrittura dallo sguardo visionario di Kaufman è il diamante del film, la punta del gioiello è affidata alle lenti sapienti del polacco Łukasz Żal, già premio Oscar per lo struggente Ida di Pawel Pawlikowski e di cui ha illuminato anche il bellissimo Cold War. Charlie Kaufman ha realizzato un’opera sull’essere umano e sulla sua fragile esistenza nel tempo trasformandola nella celebrazione di un “Eternal Sunshine” per gli occhi, le orecchie e il cuore.