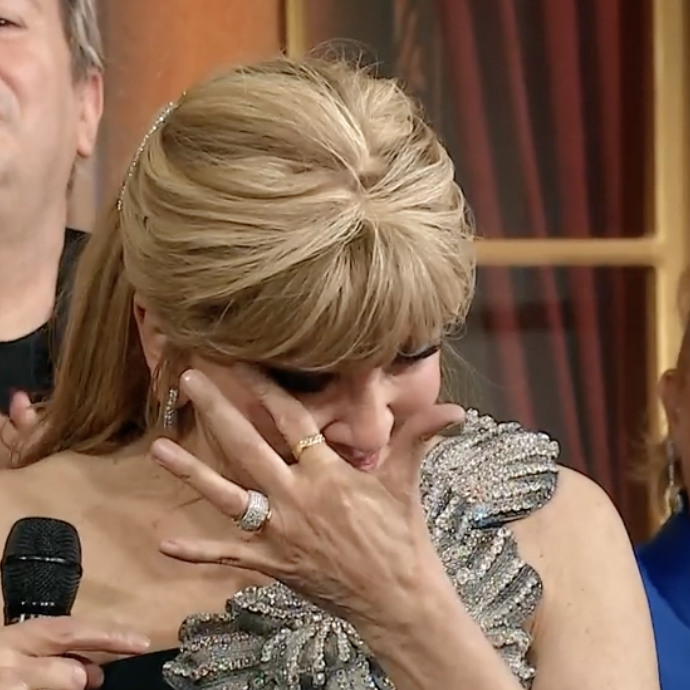La Royal Family si ribella a The Crown 4? Dunque che Dio salvi l’Icona e non la Regina. Perché è grazie ad essa che Sua Maestà & famiglia tuttora sopravvivono. La storia dell’Arte ne ha riempito volumi di ribellioni di nobili modelli rispetto ai loro ritratti, incapaci di cogliere quanto il genio creativo guardi oltre il volto, laddove l’artista è grande se sa cogliere l’essenza, il segno nella sua dimensione simbolica. E qui giace il cuore di The Crown, la rappresentazione del simbolo che si eleva dal semplice biopic per restare in eterno. Peter Morgan è il Michelangelo che ha fatto della difettosa famiglia dei Windsor la sua Cappella Sistina, motivata dall’unica eccezionalità incarnata nella figura – straordinaria – di Elisabetta II, l’ultima vera Regina.
Il valore assoluto della quarta stagione di The Crown, forse la più rischiosa delle stagioni finora concepite della premiata serie Netflix perché coinvolge contemporanee memorie, è già tutto compreso nella prima inquadratura delle scene che precedono la sigla di apertura. Elisabetta (Olivia Colman, impeccabile) procede verso il centro dell’inquadratura, sembra guardare in macchina – sfidando persino le regole del cinema – con uno sguardo obliquo, complesso e con quel tanto di ambiguità che sembra chiedere istantaneamente e istintivamente due gesti da parte del pubblico, specchiato nei suoi sudditi: il rispetto per il suo ruolo, il perdono per quanto questo la obbliga a compiere come essere umano. Da qui, ancor più che nelle precedenti stagioni, si evince quanto l’innaturale scissione persona/ruolo sia destinata a esplodere in tragedia e parossismo. Ma del resto anche la geniale sigla contenente i titoli di testa racchiude il significato dell’intera operazione di The Crown: la meticolosa forgia dell’ornamento che fa la differenza tra esseri umani per folle volontà della Storia. Dunque non Elisabetta II ma la Sua Corona. Non la vicenda di una famiglia in quanto tale, ma della sua performance nel mondo (e sopra un popolo) per misterioso “diritto divino”. Un ruolo che non sta bene ai rivoluzionari irlandesi presi a sintomo dei tempi che devono cambiare, ma che non sta bene neppure a loro stessi, i figlioli Windsor, empatici con tutto tranne che con l’idea di un trono le cui spade hanno il sapore di lacrime e rinunce.
Per questo lasciano il tempo che trovano le entusiastiche breaking news dei gossippari sagaci rivelatori del Royal disappunto di fronte alla scrittura regale di Morgan che, da non dimenticare, sceneggiò anche il magnifico The Queendiretto dal repubblicano Stephen Frears: francamente chissenefrega delle inesattezze, delle ambiguità, delle volute critiche comportamentali che anche la Storia ha ammesso, quando il risultato di narrazione e drammaturgia portate alla perfezione traslano la mimesi datata verso il paradigma che trascende spazio e tempo. Il circolo, semmai, è virtuoso: la Corona non è (più) una cosa seria, specie di quel Regno Unito che contiene in sé tutti i vizi e la virtù della contraddizione, culla primigenia del teatro moderno, ovvero l’arte pop del travestimento per eccellenza. Dunque devono solo gioire i cari Windsor che la penna dorata di Peter Morgan si sia posata su di loro, fornendo loro uno strumento di preziosa psicoterapia. Così è se vi pare, o anche Sei personaggi in cerca d’autore, scriveva il più geniale dei drammaturghi italiani: la monarchia si nutre da sempre dei racconti che le vengono tributati, siano pure triviali, volgari o fiabeschi. Il loro autore, i Windsor, l’hanno trovato in questo signore nato a Wimbledon 57 anni fa, ma che nella sua biografia registra i segni di una famiglia mezza tedesca ebrea e mezza polacca cattolica, la prima sfuggita alle persecuzioni naziste, la seconda a quelle sovietiche. Un paradosso? Forse, ma è proprio “il” paradosso che spesso rivela la Verità nascosta, scrutando nei segreti di prìncipi sbagliati e principesse tristi, e si trova a definire l’eternità di una seconda Queen dal nomen omen iscritto nel Mito.