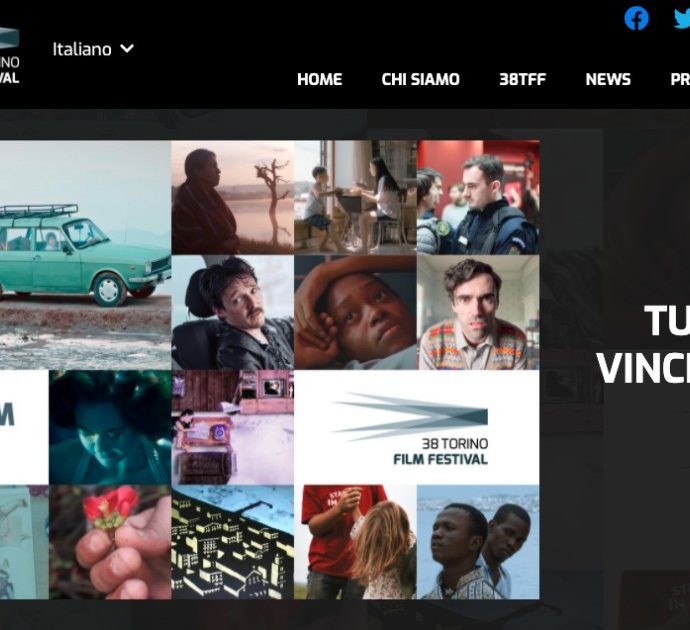Chissà perché questa storia dell’Isola delle Rose se la contendono tutti. Finisce su libri, film, documentari. Oramai è più abusata dei sampietrini del maggio francese, del rapimento Moro, dell’attentato alle Torri Gemelle. L’aspetto più curioso, poi, è che ognuno ripropone a suo modo la vicenda storica che di base avrebbe precisi connotati politici, ideologici, culturali, soprattutto nel tratteggiare il protagonista, l’ingegner Giorgio Rosa. Un signore che proprio nella sua città, Bologna, più che sognatore utopista ribelle rivoluzionario o chissà quale altra dicitura genericamente finto liberal, l’avranno definito amorevolmente un gran spaccamaroni che non aveva prima di tutto voglia di pagare tasse, imposte e balzelli allo stato.

Rosa, che abbiamo conosciuto personalmente, è morto nel 2017 a 92 anni. Tra l’inverno e la primavera del 1968 costruì una piattaforma/palafitta di 400 metri quadrati a undici chilometri e mezzo dal porto di Rimini, a circa 500 metri oltre il confine delle acque territoriali italiane. Una micronazione che si aut proclamò indipendente, insomma, e che per circa due mesi stampò pure francobolli e parlò in esperanto, fino a quando la Marina italiana proclamò in armi il game over. Nel film L’isole delle rose, diretto da Sydney Sibilia (Smetto quando voglio), prodotto da Groenlandia di Matteo Rovere (Il primo re, Veloce come il vento) in partnership nientemeno che con Netflix, un po’ come nel libro di Walter Veltroni (L’isole e le rose – titolo più laburista con la e congiunzione tanto per gradire – Rizzoli), l’ingegner Rosa è un simpatico mattacchione (interpretato con sempre notevole vis comica da Elio Germano), un tantino spregiudicato, cocciuto nel tirar su l’isolotto che spiegò lui, sia a noi di persona, ma c’è anche testimonianza video su Youtube che voleva rifarsi a “San Marino e Montecarlo”. Insomma, un paradisino fiscale così all’impronta. Registro del discorso: combriccola della goliardia.
Ma ecco che la trasformazione in una generica epica utopica della storia, prima effettuata dal Walter (la Barbara D’Urso del documentario ricordiamolo che nel suo romanzo ha stipato la palafitta dell’ingegnere con un protagonista tormentatissimo dentro a un fellinismo deteriorato), poi da Sibilia, è servita. Intendiamoci L’isola delle rose, il film, ha un obiettivo preciso ad ogni cambio scena: far ridere, far divertire, far passare in allegria un paio d’ore allo spettatore. E ci riesce. Ci dovremmo quindi fermare qui. E spiegare che il cinema italiano sta produttivamente recuperando posizioni internazionali incredibili proprio grazie al coraggio di Rovere&Co qui, dicevamo, in tandem con Netflix.

Solo che Netflix quando distribuisce, e Paramount/Dreamworks producono, ad esempio I 7 di Chicago, tra i sette protagonisti che protestano alla convention democratica di Chicago proprio nel ’68 mica sostituisce un Abbie Hoffman o un Tom Hayden con un sostenitore qualsiasi di Richard Nixon. E se ne vedrebbe bene di farlo. Già perché Giorgio Rosa, oltre ad essere stato fugacemente un sodale repubblichino, si è spesso spinto a giudicare i partigiani che combatterono i nazifascisti, sia in un’intervista pubblica nel 2013 con noi presenti ad intervistarlo stupefatti, sia attraverso le parole del figlio, dei “terroristi”: nella fattispecie Rosa definì “assassino” l’onorevole Paolo Emilio Taviani, tra i capi storici del CLN ligure. Ecco, insomma, va bene che la creatività non ha limiti e non va assolutamente censurata, ma santa miseria, il carpiato di Veltroni Sibilia e la sceneggiatrice Francesca Manieri se lo sono bevuto tutto, trascinando il concept Isola delle rose nel terreno di un buffo anticonformismo, con l’isolotto al largo di Rimini trasformato in un happy hour colorato e spiritoso.
Il film di Sibilia inizia nel giugno ’68, addirittura a Strasburgo, al Consiglio d’Europa (non Consiglio Europeo, mi raccomando), dove il caso Isola delle Rose giunge con il suo carico di dirompente nuova giurisprudenza. Poi di nuovo da capo, alla laurea di Rosa, qualche anno prima in una graziosa Bologna d’epoca, con l’ingegnere che comincia a fare lo spaccamaroni utilizzando in centro un prototipo di auto antesignana miserrima della DeLorean senza targa che fa andare su tutte le furie i carabinieri. Lì fa la sua comparsa con rigoroso cappotto sotto al ginocchio la Gabriella (Matilda De Angelis, tanto promettente quanto ferma a quel bel ruolo a tuttotondo datole proprio da Rovere in Veloce come il vento), di cui il Giorgio si innamora e che abbandonerà perfino l’altare per seguire l’ingegnere appena prima che il ministro dell’interno Restivo metta fine al paradisino fiscale dell’isolotto. Fino qui, diceva un film francese, tutto bene. Anzi benissimo.

L’isola delle rose di Sibilia, al netto di un Rosa rossastro più che neretto come fu in realtà, è spassoso. Si adagia sinuoso su uno script scoppiettante, su una produzione tecnica tra scenografia e comparto VFX di livello altissimo (hanno girato a Malta in una specie di piscina con una vera piattaforma ndr), su un piatto di comprimari che pur in un gramelot dialettale bologneseromagnolizzato un po’ dozzinale rendono spiritoso chiunque sfiori l’isola e gli “isolani”. La piccola comunità attorno a Rosa, ad esempio, è formata dall’amico Maurizio (Leonardo Lidi in gran spolvero), figlio di papà che sovvenzionerà parecchi lavori di costruzione; Pietro, il personaggio muto e di passaggio che poi rimane lì tutto il tempo (nella realtà quando arrivò la Marina a far sgomberare, c’era solo lui sull’isola mentre qui ci sono addirittura le donne modello Enrico Toti); la minorenne Franca che dell’isola sarà la barista; e l’imprenditore tedesco Rudy Wolfgang Neumann che le cronache dell’epoca danno proprietario di un grosso albergo, ma che qui diventa un simpatico libertino e libertario coi baffi a manubrio. Una storia “ispirata e non tratta da”, ha spiegato in conferenza stampa Sibilia. E, appunto, chissà perché, di questa storia piace l’idea generale ma non i dettagli che vengono continuamente cancellati, rimescolati, edulcorati.
Particolari come quello della fine dell’isola delle Rose che nel film assume i connotati della farsa con il ministro dell’Interno Franco Restivo (Fabrizio Bentivoglio che quasi si diverte più lui nel sovrabbondare la sua maschera democristiana) e il presidente del consiglio Leone (Zingaretti di cui si vede il naso finto in almeno tre scene) che spediscono un cacciatorpediniere e gli fanno persino sparare bombe di avvertimento, quando in realtà l’isolotto fu circondato da una decina di pilotine di Marina, Polizia e Capitaneria di porto. Certo, capiamo benissimo il senso del paradosso, la deformazione comica dell’assurdo. Ci abbiamo anche riso e consigliamo il film proprio per la riuscita di questo effetto. Ma quando il Restivo sputacchiante di Bentivoglio sbraita al telefono contro Rosa dicendogli che lui ha scritto la Costituzione, si cerca l’iperbole sguaiata che sfocia in farsa con il potere ridicolizzato, ma dall’altra parte non c’è il sempre iperbolico Germano ma un tizio più simile a Briatore che a Che Guevara. Democristiani antidiluviani e bigotti sì, ma farsi dare dei coglioni da un ex repubblichino è un servizio alla storia del nostro paese non proprio edificante. Su Netflix dal 9 dicembre e se non c’era il Covid era prevista anche l’uscita in sala.