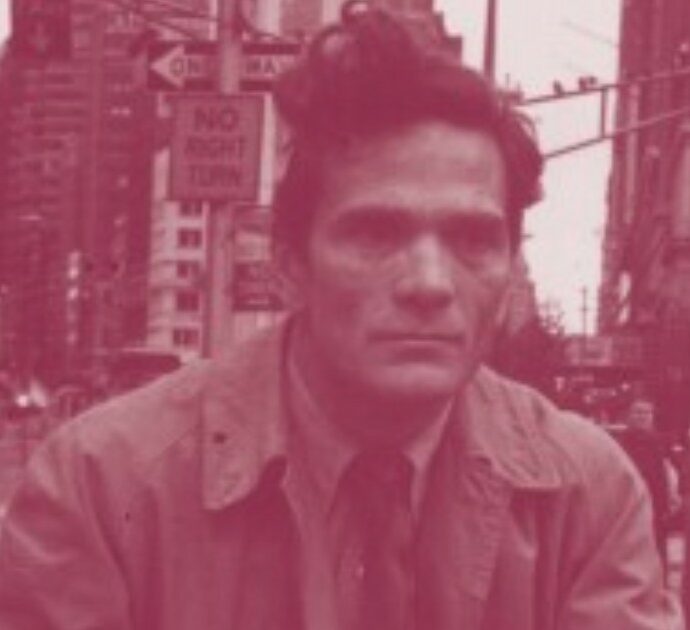LA CITTA' DEI VIVI - 2/3
 Intanto, giusto per spoilerare, ma poi si sapeva, La città dei vivi di Nicola Lagioia (Einaudi) è un romanzo-reportage sui generis sull’omicidio Varani che non dà risposte al caso giudiziario in esame. Bensì è un lungo e articolato inseguimento rispetto a qualcosa che sfugge. Un tentativo di circumnavigazione letteraria composto dalla ricucitura dei fatti, dalle confessioni degli assassini, dalle testimonianze apparentemente secondarie e dagli interrogativi etico-morali dell’autore in prima persona, volto ad afferrare possibili spiegazioni, motivazioni e senso di un gesto, anzi di martellate e coltellate inferte da Marco Prato e Manuel Foffo a Luca Varani, la notte tra venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016 a Roma, nell’appartamento di Foffo, dopo quasi due giorni di pippate di coca e sesso. Sospeso tra il continuo riverberarsi dello stupore di fronte all’impensabile e una curiosità antropologica irriducibile (si vedano le due pagine sul colonnello Donnarumma e il concetto di diabolico), Lagioia gioca la carta della mimetizzazione autobiografica (il tentativo di prostituirsi o il caso dell’uccidere) diffusa e dissolta nei risvolti a posteriori dell’efferato omicidio, in modo che invece di un Truman Capote spudoratamente “a sangue freddo” sbuchi l’eco più caldo di un descrittività contigua alla Emmanuel Carrère. Suddiviso in sei parti/capitoli consequenziali a livello temporale, ulteriormente segmentati in diversi punti di vista/piste narrative (un po’ io, loro, gli altri, quell’altro ancora), il romanzo numero cinque dell’autore barese non prevede imponenti brame stilistiche, ma offre una scrittura dall’incedere deciso, serrato, teso, insinuante, in cui a Prato, Foffo e Varani viene offerta eguale misura di pagine e spazi. La tensione è verso l’origine del male, verso le azioni indecifrabili degli assassini, ma soprattutto verso un azzeramento gerarchico narrativo tra vittima/carnefice che tende ad un’omogeneizzazione del contesto socio-culturale osservato e ha, a suo modo, del provocatorio: “Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell’incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?”. Lo sguardo indagatore e stupefatto che Lagioia rivolge attorno a sé, fulminante ed organico verso le classi socio-economiche dei protagonisti (si veda il ribaltamento di ruoli tra gli assassini benestanti, con Prato anche intellettualmente colto, contrapposti alla vittima povera e di periferia), infastidito e attratto dalla città di Roma che ti fa sentire “sprofondare” (dove la gente piscia in strada, i topi corrono e si schiantano ovunque e tutto sembra sciogliersi in una putrefazione ipocrita e fasulla), rendono La città dei vivi un seducente e decadente sussurrio dove l’autore addirittura si perde, si lascia andare, non conclude l’opera, si fa superare definitivamente dalla cronaca. Lasciando in sospeso lettore, etica, interi rotocalchi scandalistici della tv, sul precipizio di una vicenda violenta e incomprensibile che non potrà mai trovare requie. Voto (da Salone del Libro): 7/8
Intanto, giusto per spoilerare, ma poi si sapeva, La città dei vivi di Nicola Lagioia (Einaudi) è un romanzo-reportage sui generis sull’omicidio Varani che non dà risposte al caso giudiziario in esame. Bensì è un lungo e articolato inseguimento rispetto a qualcosa che sfugge. Un tentativo di circumnavigazione letteraria composto dalla ricucitura dei fatti, dalle confessioni degli assassini, dalle testimonianze apparentemente secondarie e dagli interrogativi etico-morali dell’autore in prima persona, volto ad afferrare possibili spiegazioni, motivazioni e senso di un gesto, anzi di martellate e coltellate inferte da Marco Prato e Manuel Foffo a Luca Varani, la notte tra venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016 a Roma, nell’appartamento di Foffo, dopo quasi due giorni di pippate di coca e sesso. Sospeso tra il continuo riverberarsi dello stupore di fronte all’impensabile e una curiosità antropologica irriducibile (si vedano le due pagine sul colonnello Donnarumma e il concetto di diabolico), Lagioia gioca la carta della mimetizzazione autobiografica (il tentativo di prostituirsi o il caso dell’uccidere) diffusa e dissolta nei risvolti a posteriori dell’efferato omicidio, in modo che invece di un Truman Capote spudoratamente “a sangue freddo” sbuchi l’eco più caldo di un descrittività contigua alla Emmanuel Carrère. Suddiviso in sei parti/capitoli consequenziali a livello temporale, ulteriormente segmentati in diversi punti di vista/piste narrative (un po’ io, loro, gli altri, quell’altro ancora), il romanzo numero cinque dell’autore barese non prevede imponenti brame stilistiche, ma offre una scrittura dall’incedere deciso, serrato, teso, insinuante, in cui a Prato, Foffo e Varani viene offerta eguale misura di pagine e spazi. La tensione è verso l’origine del male, verso le azioni indecifrabili degli assassini, ma soprattutto verso un azzeramento gerarchico narrativo tra vittima/carnefice che tende ad un’omogeneizzazione del contesto socio-culturale osservato e ha, a suo modo, del provocatorio: “Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell’incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?”. Lo sguardo indagatore e stupefatto che Lagioia rivolge attorno a sé, fulminante ed organico verso le classi socio-economiche dei protagonisti (si veda il ribaltamento di ruoli tra gli assassini benestanti, con Prato anche intellettualmente colto, contrapposti alla vittima povera e di periferia), infastidito e attratto dalla città di Roma che ti fa sentire “sprofondare” (dove la gente piscia in strada, i topi corrono e si schiantano ovunque e tutto sembra sciogliersi in una putrefazione ipocrita e fasulla), rendono La città dei vivi un seducente e decadente sussurrio dove l’autore addirittura si perde, si lascia andare, non conclude l’opera, si fa superare definitivamente dalla cronaca. Lasciando in sospeso lettore, etica, interi rotocalchi scandalistici della tv, sul precipizio di una vicenda violenta e incomprensibile che non potrà mai trovare requie. Voto (da Salone del Libro): 7/8