Respiro a fondo. Mi guardo attorno. Sono al centro del paese, al centro del buio d’un luogo antigeografico, al centro di una nebbia che sale dall’asfalto e dai tombini e dai pochi fossi di terra dura. Gli alberi lanciano il loro grido muto verso un cielo che nemmeno si vede più, un cielo alto, colorato di niente. Li osservo, sono tutti alberi secchi, diritti e rigidi come scheletri, e mi chiedo quante cose hanno visto, sentito, da quante mani sono stati sfiorati, quanti segreti possiedono, quanto dolore hanno assorbito. Vorrei farmi albero anch’io, ma è anche questo l’ennesimo impossibile desiderio. Abbasso gl’occhi. In fondo alla strada una luce tenue e stanca indica l’entrata del cimitero, l’entrata della casa dei morti, l’entrata dell’ultima casa dell’umanità.
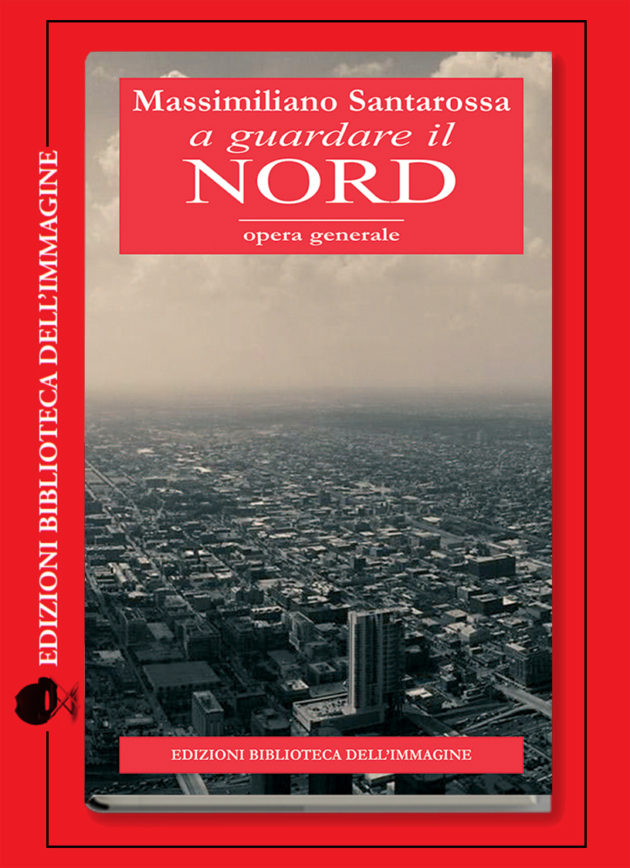 A guardare il Nord, di Massimiliano Santarossa (Biblioteca dell’Immagine) è un lungo viaggio letterario e umano che parte dagli anni Ottanta e arriva ai giorni nostri, che si incunea tra le false illusioni della televisione a spot, gli orrori della crescita post-industriale e il quotidiano nonsense dell’epoca contemporanea. Una completa operazione antologica che cerca di mettere su carta una quotidianità popolare d’antan, trasformata con il passare del tempo storico in una bolla borghese e, infine, in un’esplosione distopica capace di trasportare ovunque gli schizzi delle classi sociali, in attesa di evaporare sotto un sole tossico.
A guardare il Nord, di Massimiliano Santarossa (Biblioteca dell’Immagine) è un lungo viaggio letterario e umano che parte dagli anni Ottanta e arriva ai giorni nostri, che si incunea tra le false illusioni della televisione a spot, gli orrori della crescita post-industriale e il quotidiano nonsense dell’epoca contemporanea. Una completa operazione antologica che cerca di mettere su carta una quotidianità popolare d’antan, trasformata con il passare del tempo storico in una bolla borghese e, infine, in un’esplosione distopica capace di trasportare ovunque gli schizzi delle classi sociali, in attesa di evaporare sotto un sole tossico.
Dolce, semplice, ricco di un profondo vigore umano e puntale e profondo osservatore del mondo, Santarossa, in quest’opera, non si lascia mai inquinare dall’ambiguità della violenza sociale di cui spesso narra. Così come la sua indagine letteraria non si compiace in un linguaggio forzato, ma trasporta il lettore nel parlato di tutti i giorni.
A tratti la scrittura può ricordare quella di quel piccolo capolavoro rustico che fu Zebio Còtal, di Guido Cavani. In questo romanzo l’analisi è sul mondo povero dell’Appennino tosco-emiliano, in A guardare il Nord l’analisi è soprattutto sul nordest dei metalmezzadri e dei loro figli, per esondare su un nord che diviene l’Occidente tutto.
A scuola, noi ragazzini venuti dalla periferia, eravamo poveri e brutti. Chi con la pancia in fuori, altri con la schiena curva, tre erano solo pelle e ossa, due davvero troppo grassi. E il maestro che sbraitava ogni mattina: Dovete stare diritti, dovete stare composti, tirate in dentro quelle pance, state diritti con quelle schiene, dovete fare più ginnastica, cristosantissimo! Ripeteva sempre, urla su urla. Ma noi non ci siamo mai mossi. Non abbiamo mai voluto essere diversi da come eravamo. Siamo rimasti amici per venti anni: mi sono allontanato anche da loro, uno dopo l’altro, inevitabilmente dopo la solita raccomandazione che chi ci è amico si sente di fare, di scaricarci addosso: Devi stare bene, Devi essere contento, Devi essere felice, hai scritto romanzi, hai una famiglia, e noi ti siamo vicini. Dobbiamo qualcosa a qualcuno, o peggio a noi stessi? No. Non dobbiamo nulla, mai, a nessuno, soprattutto a noi, né al corpo né all’anima, per chi ne ha ancora di anima. Dobbiamo solo camminare, e sorridere a chi resta”.
A guardare il Nord è una miscelanea di verismo, realismo e originale presa di posizione dell’autore dettata in una lingua diversa da ciò da cui, presumibilmente, trae origine. Un’ulteriore evoluzione della scrittura di uno dei più coraggiosi scrittori italiani contemporanei. Un’evoluzione trasparente, chiara, diretta.
Articolo Precedente
‘Riaprire i sipari’ sì, ma come? Le proposte degli esperti per la ripartenza della cultura

Articolo Successivo
David di Michelangelo a Dubai: così in 48 ore è nato il gemello (identico fino alle imperfezioni). High-tech e studio: la storia di un lavoro unico al mondo









