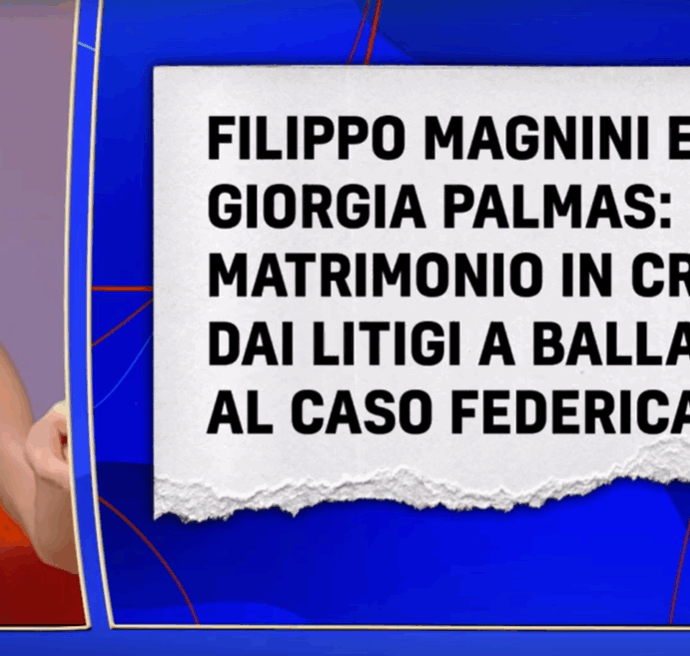Daniele Liotti è uno di quei personaggi abituati a giocare di sottrazione. Orgogliosamente orso, detesta il gossip, dribbla la mondanità ma non fare morettiano – al «mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?» preferisce direttamente il «nun me va» – e lascia che a parlare sia il suo lavoro. Come il successo di Un passo dal cielo 6-I guardiani, su Rai1, cresciuta negli ascolti rispetto alla passata stagione, tanto che la settima serie pare scontata. «Ma ci sono diverse cose che bollono in pentola e che potrebbero accadere anche con Netflix», anticipa Liotti a FQMagazine, raccontandosi in maniera inedita e rivelando di essere in un momento di passaggio della sua carriera, che tocca quest’anno i ventisei anni trascorsi tra il set e il palcoscenico.
Dopo sei stagioni, gli ascolti di Un passo dal cielo non solo reggono ma sono cresciuti rispetto alla passata edizione. Come se l’è spiegato?
Dipende da molti fattori. La serie precedente andò in onda a settembre e forse fu un po’ penalizzata: a ottobre inoltrato mi scrivevano dicendomi «è iniziata, non lo sapevo». E poi c’entra la scrittura e l’evoluzione dei protagonisti.
Il suo Francesco Neri come si è evoluto?
La storia di Francesco era più cupa e drammatica. Quest’anno ha uno sguardo più sereno, ha lasciato la Forestale, la speranza domina nonostante il lutto pensante che ha subito. Ha meno fantasmi. Ci abbiamo lavorato sul suo cambiamento e questo ha pagato.
A proposito di ascolti: lei è tra quelli che la mattina li attende con ansia?
Diffido di quelli che fanno il mio lavoro e dicono: «No, io gli ascolti non li guardo nemmeno». Sono un indicatore importante, ci dicono molto dei gusti del pubblico. E poi spesso innescano la legge del moltiplicatore: se una stagione va bene, è più facile che ce ne sia un’altra.
Dunque Un passo dal cielo 7 ci sarà?
Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che LuxVide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla.
Le riprese le avete terminate a dicembre: come si riesce a tenere la concentrazione sul set con tutti gli accorgimenti e i protocolli anti Covid?
Ci vuole uno sforzo di concentrazione in più, forse, ma non influenza la forza espressiva. Poi venivamo dal lockdown e l’entusiasmo di tornare a lavorare è stato superiore a tutto. In più lavorare molto in esterna e con dei protocolli ben strutturati, ha offuscato la preoccupazione.
Questa è la sua terza stagione da protagonista di Un passo dal cielo. Quando le hanno proposto la staffetta con Terence Hill, cos’ha pensato?
«Ma sono matti?». Scherzi a parte, ho percepito da subito la responsabilità sulle spalle, perché sapevo che avrebbero fatto paragoni e che non era facile eguagliare il successo di Terence. Per me lui è un mito assoluto, sono cresciuto con i suoi film e lo ammiro molto, anche umanamente. L’idea di entrare in un progetto che lui aveva contribuito a portare al successo, mi piaceva. Anche se qualche remora restava.
Cosa la convinse?
Il personaggio. Francesco è totalmente diverso dal suo, va a cavallo, ha a cuore i temi ambientali. E poi è un uomo dal passato ingombrate, costretto a fare i conti con il senso di colpa e un dolore enorme. Per un attore è una sfida interessante.
L’investitura ufficiale se la ricorda?
Incontrai Terence su un set fotografico, dove avremmo scattato delle foto per un servizio. Ci siamo conosciuti lì. Mi passò il testimone in modo asciutto, perché non è di molte parole, ma riconobbi subito nei suoi occhi la sincerità e una certa somiglianza nell’essere laconici e un po’ orsi.
Non l’ha smussata nemmeno a 50 anni questa sua “orsaggine”?
(ride) No, anzi, semmai è cresciuta. È sempre stata una mia caratteristica. Non sono un misantropo, sia chiaro, ma mi piace avere una dimensione mia, stare in famiglia, mi piace leggere, cucinare, passare del tempo con i miei figli. Ma ero così anche da giovane: sono diventato papà per la prima volta a 27 anni, sono praticamente cresciuto con Francesco, mi sono ritagliato molto tempo per stare da solo con lui. Nella mia vita e con i miei affetti ci sto bene, motivo per cui non ho mai troppo frequentato l’ambiente del cinema.
Però il cliché del «frequenta i salotti giusti e le feste perché lì scattano le occasioni», nel suo ambiente resiste.
È vero, spesso contano le coincidenze e vale la regola del trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Ma ognuno ha la sua storia e il suo destino e sono convinto che esista soprattutto una meritocrazia predefinita: se un attore ha un valore, viene fuori anche senza le per e le frequentazioni. Io ad alcune feste ci sono pure andato ma tornando a casa prevaleva il «nun me va». Mia madre me lo dice sempre: «Ti devi far vedere di più in giro», ma la mia indole alla fine è un’altra.
Detesta di più il gossip o i social?
È una dura lotta. (ride)
Una pagina Instagram ce l’ha da un anno: alla fine ha ceduto.
Partecipo ai social in maniera asciutta. Mi piace la possibilità di dialogo, meno l’idea di dover raccattare follower per diventare influenti: secondo me è l’ultima delle cose che hanno a che fare con un artista. Alla fine credo di aver trovato un compromesso. Ci sto il giusto, ma ci sto. E in questo modo magari le persone smettono di seguire i profili falsi che hanno aperto con il mio nome: si spacciano per me, alcuni vendendo persino delle crociere, e la cosa sta diventando antipatica, tanto che potrei sporgere querela.
Il paradosso però è che la sua fan page ha il doppio dei suoi follower.
E pensi che da quando è cominciato Un passo dal cielo 6 il mio profilo è cresciuto ma meno rispetto ad alcuni di quelli finti che hanno triplicato i numeri.
Il gossip invece cos’è per lei?
Una perdita di tempo. Sarà anacronistico ma non mi appassiona. E al tempo stesso penso: «Ma che vuoi che glie ne freghi alla gente se sto mangiando un gelato al parco con mia figlia?». Ho una visione del mio lavoro come di un lavoro qualunque, solo con più visibilità. Questo però non deve consentire a chiunque di poter invadere la mia vita privata: so che sono le regole del gioco ma m’infastidiscono.
Si è mai sentito invaso nel privato?
No, però non mi piace venire paparazzato.
Scontri con i paparazzi?
Al massimo un battibecco. Una mattina, verso le sei, ero sotto casa mia a Trastevere che caricavo la macchina per partire in vacanza. «A Daniè, te stanno a fa le foto», mi disse un ragazzo che passava da lì. Ho perso la calma, ho avvicinato il fotografo e gli ho urlato come un pazzo di cancellare le foto. Poi un minuto dopo mi sono calmato e gli ho chiesto scusa perché so che era lì solo per fare il suo lavoro. Divento burbero poi mi pento in un secondo.
Cos’è che la fa arrabbiare?
La falsità.
Si piace quando si rivede in tv o al cinema?
Mi detesto. Perché l’ho fatto in quel modo? Avrei dovuto farlo così. Non sono mai soddisfatto.
C’è un no professionale di cui si è pentito?
Mi chiesero di fare Distretto di polizia e dissi no perché non mi piaceva il personaggio del commissario tutto di un pezzo. Lo stesso capitò con Squadra antimafia: rifiutai perché mi sembrava un ruolo simile a quello che avevo fatto ne Il capo dei capi. Entrambe erano serie molto ben fatte, ma non mi piace rimanere ancorato ai cliché. Non ho rammarichi.
Lei ha detto: «Non sognavo di fare questo mestiere. Le circostanze mi hanno portato a farlo». Da piccolo qual era il suo sogno?
Non avevo le idee chiare. Fino ai 16 anni ho giocato a calcio e avevo davanti una carriera promettente. Poi m’infortunai a un ginocchio e lì ho perso il treno: era un ambiente competitivo, ci voleva una determinazione che forse non m’interessava dimostrare. Avevo toccato con mano l’ambizione smodata, anche quella dei genitori dei ragazzi, e non ho lottato per tornare in campo.
Si arrese?
No, ci provai a tornare a giocare ma alla fine capii che non m’interessava fino in fondo. Fu una delusione ma ci misi un punto ed ero pacificato con me stesso.
Dal calcio passò alle pubblicità.
Ero iscritto a Giurisprudenza e tra un esame e l’altro lavoricchiavo per togliermi qualche sfizio e l’idea di fare l’attore non mi passava nemmeno per la testa. Ero timido e riservatissimo ma feci diversi provini per alcune pubblicità: alla fine venivo sempre scelto pur non capendo bene il perché.
Tutto cambiò con uno spot della Barilla. Cosa accadde?
Quello che è capitato a molti. Accompagnai un amico a fare il provino e chiesero anche a me di farlo. Mi ritrovai in una grande stanza con decine di attori e modelli e quando compilai la scheda, scoprii che l’audizione sarebbe stata in inglese. Pochi giorni dopo mi telefonarono a casa: «Guarda che ti cercano», mi disse mia madre. Sbiancai quando mi comunicarono che ero stato scelto.
Il primo giorno sul set?
Arrivai a Porto Venere per girare e mi trovai su un set enorme con una grande troupe americana. Ero sbalordito. Ma sono rimasto nel mio: non ho mai sognato in grande eppure meno cercavo una cosa, più arrivava.
Poco dopo si ritrovò a girare il suo primo film.
Mollai l’università perché non mi piaceva e m’iscrissi al Centro sperimentale, dove però mi presero solo come uditore, perché i sette posti a disposizione erano già occupati. Poco dopo mi chiamarono per un provino e il regista mi disse: «L’attore ci ha dato buca e tu saresti perfetto. Hai un monologo pronto?». Gli recitai un pezzo di Fuga di mezzanotte e mi scelse come co-protagonista di Bidoni assieme a Angela Finocchiaro, Giuseppe Cederna e Ottavia Piccolo.
In pratica ha cominciato entrando dalla porta principale.
Ma arrivato sul set mi resti conto che non sapevo nulla. Ricordo le urla epiche del regista, Felice Farina, quando in una scena entravo e mi dovevo fermare in un punto: invece che guardare in camera, fissavo lo scotch per terra e lui mi sgridava. Dicevo le battute ma non sapevo niente della tecnica e così mi rimisi a studiare perché a qual punto avevo capito che volevo fare l’attore: sul palco mi liberavo di pudore e timidezza e soprattutto mi divertivo e mi emozionavo.
Dal punto di vista professionale che pregio si riconosce?
Non aver mai precorso i tempi per inseguire il successo facile. Non m’interessano i ruoli ruffiani, la visibilità o la convenienza economica: le cose devo sentirle con la pancia e i ruoli li scelgo se mi emozionano e se so che posso lasciare qualcosa.
Quando ha capito che ce l’aveva fatta?
Nel 2003 girai il film Il fuggiasco, tratto dalla vera storia di Massimo Carlotto, un fatto di cronaca giudiziaria pesante. Ho conosciuto lui, ho cercato di lavorare sulle sfumature e sono entrato così tanto in quel ruolo che la malinconia mi aveva pervaso. Mi ha dato una soddisfazione enorme sentirmi dentro un personaggio tanto lontano da me: questo lavoro così introspettivo, la spinta emotiva così forte che a tratti crea paura e sgomento, regalano all’attore la sensazione di avercela fatta.
Il prossimo ruolo?
Una serie dal titolo English woman, che sarà disponibile su Acorn Tv, un servizio di streaming americano. Le riprese inizieranno a maggio, sarà tutta in inglese ed io sono il protagonista maschile: sarà un capitano dei carabinieri che aiuta una spia inglese.
Proposte da Netflix?
Ci sono diverse cose che bollono in pentola e che potrebbero accadere anche con Netflix. Ma non posso dire nulla. Negli ultimi mesi ho ricevuto tante proposte ma non me la sono sentita di accettare perché non mi hanno stimolato più di tanto. So di non essere Robert De Niro e che rischio di restare fermo per un po’ ma sono in un momento di riflessione e di formazione in cui vorrei cambiare genere, trovare altri stimoli e altri orizzonti.
Curiosità: lei googla mai il suo nome?
No, sono sincero.
Dunque non saprà che tra le chiavi di ricerca ci sono le parole malato e malattia. Un sito ha addirittura scritto che lei soffre di distrofia muscolare.
Non ne sapevo assolutamente nulla. È una fake news galattica: non sono malato e non ho disturbi di alcun genere. Quanto alla distrofia muscolare, da molti anni sono testimonial di Parent Project, un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Vorrei fare molto di più e mi piacerebbe coinvolgere anche alcuni colleghi e amici in qualche iniziativa di raccolta fondi.