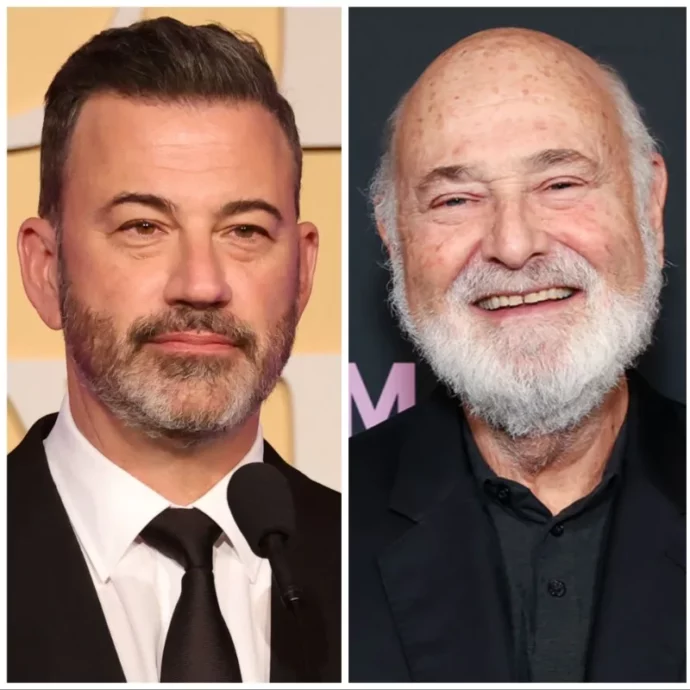Fuga da Kabul. Poteva essere un film, o un libro, ma è la realtà. Sarebbe bastata la misera figura delle truppe americane in Afghanistan rapidissime a fare fagotto e senza troppo preavviso lasciare dopo vent’anni il paese per fondare un nuovo filone di cinema di guerra al contrario. Ovvero: dove agli eroi sparatutto succedono i barbuti e ciabattati talebani con orologio d’oro al polso.
Invece, per ora, le cronache dal fronte afgano segnano il ritorno del cinema documentario, en plein air. La regista 38enne Sahraa Karimi, che per grazia ricevuta da Allah, unica (e ultima?) donna, ha presieduto dal 2012 l’Afghan Film, è fuggita rocambolescamente da Kabul dopo aver documentato sui social il suo dramma, il suo scoramento, la sua rabbia. Odio sia verso il ritorno dei talebani al potere, sia contro l’esercito statunitense (“shame on you”) che all’aeroporto della capitale per tenere lontano la popolazione afgana desiderosa di fuggire fuori dal paese ha mostrato i muscoli in una sconcertante difesa fatta di spari in aria e minacce di lanci di granate. Karimi aveva portato nel 2019 al Festival di Venezia il film Hava, Maryam, Ayesha – la storia di tre donne di tre classi sociali differenti a Kabul e la loro difficoltà a sopravvivere autonome e dipendente in un mondo patriarcale. Nata in Iran ma con genitori di origine afgana, da presidente dell’Afghan Film Karimi aveva tentato di ricucire lo strappo già avvenuto nella memoria laica del suo paese acquisito tanto che durante il suo mandato erano stati girati i documentari A flickering truth (2015) e The forbidden reel (2019) sui tentativi di recupero degli archivi del cinema afgano andati in fumo negli anni della dominazione talebana.
La sua collega 31enne Shahrbanoo Sadat, anch’essa nata in Iran ma vissuta in terra afgana, alla Quinzaine di Cannes nel 2016 e 2019 con Wolf and sheep (girato nel villaggio rurale dove ha vissuto da bimba) e The orphanage (coming of age a fine epoca di dominazione russa), ha raccontato a Variety l’incubo vissuto sulla sua pelle nelle scorse ore: scene di fine chilometriche agli sportelli bancari quando i talebani sono improvvisamente stati scorti dietro l’angolo e l’impossibilità di superare posti blocco verso l’aeroporto e avere un volo già prenotato per poter accedervi. “Se sopravvivrò a tutto ciò, il mio cinema cambierà per sempre. Sto come osservando un’ingiustizia orribile. Spero di essere in grado di rielaborare quello che sta accadendo per poi condividerlo col mondo”. “Gli Stati Uniti hanno un obbligo morale. Accolgano quanti più rifugiati afgani possibili”.
Nemmeno Khaled Hosseini, il celebre autore dei romanzi Il cacciatore di aquiloni e Mille splendidi soli, ha usato mezze misure contro la scelta americana. Forse il più popolare cantore della società afgana degli ultimi 40 anni ha seguito passo passo il ritiro Usa e il ritorno dei talebani nella Kabul natia dove passò la sua infanzia e di cui descrisse aspetti ampiamente autobiografici con il suo inatteso bestseller (in italiano edito da Piemme). Tra l’altro parliamo del romanzo più venduto negli Stati Uniti nell’anno 2005 diventando anche un film (piuttosto didascalico, ma comunque trascinante) diretto da Marc Forster e rinfocolando una polemica non da poco tra le due principali etnie dell’Afghanistan, quella pashtun e quella hazara. Hosseini, da residente oramai da decenni nella California del Nord, ha rincarato la dose, verso quello che considera, oltretutto, il suo presidente, Joe Biden: “Il presidente Biden non è riuscito a rispondere alla domanda fondamentale. Cosa farà l’America per l’incombente crisi umanitaria in Afghanistan? Chi proteggerà gli uomini, le donne e i bambini lasciati indietro?”. Là dove nemmeno più l’iperbole poetica (erano i cattivi talebani, ricordiamolo, una volta saliti al potere sul finire degli anni novanta a vietare il volo degli aquiloni) sembra fornire una scappatoia alla cruda realtà di improvvisa e rinata oppressione di fondamentalismo religioso, ecco che tornano alla mente le immagini di decine di film che hanno caratterizzato l’interregno “democratico” post 2001 con a capo gli Stati Uniti.
Tutti film di guerra, di minuzioso e infernale stillicidio del fante a stelle e strisce caduto nella trappola afgana. Vedi Lone survivor (2013) diretto da Peter Berg, dove è una tribù pashtun a far sopravvivere un Navy SEAL(Mark Whalberg) braccato ed errabondo andato a caccia di talebani. Due i documentari embedded che hanno provocato non poche polemiche addirittura nel pubblico occidentale. Il primo è Restrepo del 2013, storia vera di un giornalista statunitense e un fotoreporter britannico volutamente al seguito di un plotone dell’US Army nella pericolosa valle afgana del Korangal. I due vollero rappresentare “l’esperienza della guerra”, quindi la quotidianità dei soldati al seguito, scelta narrativa leggibile anche come mancata presa di posizione etica sull’assurdità di una guerra maledetta, mai digerita del tutto dalle presidente, repubblicane e democratiche, succeduto a quella di Bush jr.
Singolare, infatti, è il documentario danese, Armadillo, passato anche a Cannes. Qui la truppa militare seguita dal regista Janus Metz è proprio di soldati danesi (e britannici) sulla direttrice della base operativa della provincia di Helmand. Descritto da diversi critici come una sorta di Apocalypse Now documentario, Armadillo non è altro che un’angolazione insolita (il soldato danese e non americano) con tutto il corollario umano e verista di una fettina lillipuziana di occidente che militarizza un lontano oriente: civili in fuga, crani fracassati, bombe che esplodono, addii casalinghi, abbracci, pacche sulle spalle tra commilitoni e quell’aria di guerra vista in tanti film hollywoodiani che poi qui sul terreno reale è identica. Di quello che è accaduto in Afghanistan negli ultimi vent’anni sappiate comunque che si può anche amaramente sorridere. È il caso di Whisky Tango Foxtrot (2016), una commedia tratta dalle memorie della giornalista Kim Baker, nel film interpretata dalla stand up comedian, Tina Fey, e della sua improvvisa accelerata nella vita professionale tra burqa, arti spappolati, e la meschina arte dello scoop giornalistico. Un modo per dire che anche nel “raccontare” l’Afghanistan c’è stato qualche problema, come dire, comunicativo e culturale.