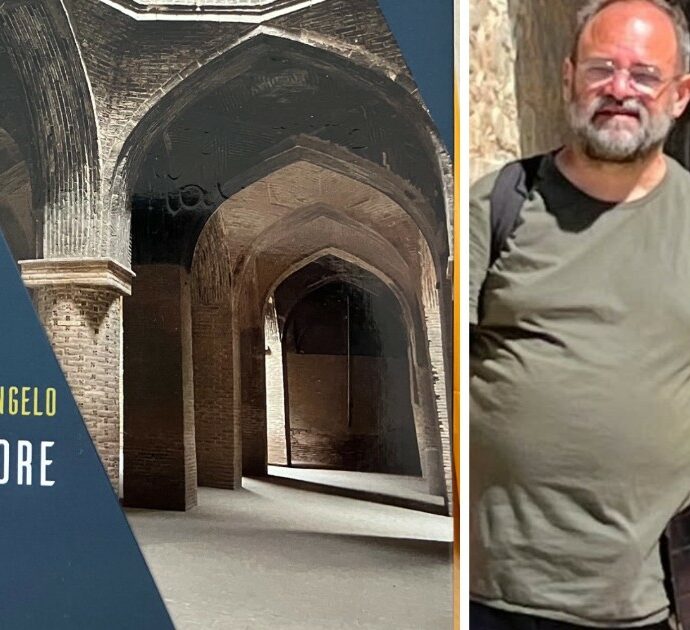Pubblichiamo in anteprima le pagine iniziali de Il Cielo Sbagliato, il nuovo romanzo di Silvia Truzzi, edito da Longanesi e in libreria dal 27 gennaio. “Dalle Giornate Rosse del 1919 all’arrivo dei bambini di Vienna, dalla visita di Vittorio Emanuele III al bombardamento del giorno di San Valentino, dal clamoroso caso dell’avvelenatrice di Mantova allo scandalo che seguì l’uscita del film La cena delle beffe nel ‘41, Il cielo sbagliato racconta trent’anni cruciali di provincia italiana attraverso gli occhi di due donne che ne incarnano lo spirito più profondo“.
Pubblichiamo in anteprima le pagine iniziali de Il Cielo Sbagliato, il nuovo romanzo di Silvia Truzzi, edito da Longanesi e in libreria dal 27 gennaio. “Dalle Giornate Rosse del 1919 all’arrivo dei bambini di Vienna, dalla visita di Vittorio Emanuele III al bombardamento del giorno di San Valentino, dal clamoroso caso dell’avvelenatrice di Mantova allo scandalo che seguì l’uscita del film La cena delle beffe nel ‘41, Il cielo sbagliato racconta trent’anni cruciali di provincia italiana attraverso gli occhi di due donne che ne incarnano lo spirito più profondo“.
Mantova, 11 novembre 1918
Nella baracca di vicolo Barche il freddo della notte è feroce, si arrampica sui muri scrostati, odora di chiuso e di umido: è il profumo della povertà, a cui gli inverni del Nord portano in dono, oltre alla fame, un gelo assassino. La stanza è spoglia: al centro un tavolo con tre sedie, su un lato il giaciglio, su un altro una credenza priva di un’anta. L’unica luce è una finestra alta, con la serratura malferma che trema e fischia ogni volta che il vento la attraversa per entrare senza invito. In fondo c’è un camino, ma è solo un buco vuoto. Né legna né carbone. Nemmeno cenere: l’ultima volta che è stato acceso era ancora il 1917. Nonostante il freddo la giovane donna stesa nel letto suda da ore. Geme invocando aiuto, mani malferme si muovono sul ventre rigonfio. Margherita Bassi nata Casadei era riuscita a nascondere la gravidanza per sei mesi, tanto poco si vedeva la pancia. Poi un giorno mentre mangiavano in silenzio, Regina, sua madre, le aveva detto: “Sei ingrassata. O qualcuno ti dà da mangiare e in cambio gli allarghi le gambe, oppure hai allargato le gambe una volta e ci sei rimasta. In ogni caso, sei una puttana”. La donna aveva pronunciato queste parole senza urlare, la voce fredda e distante. Rita aveva sgranato gli occhi e rinunciato a qualunque spiegazione: “Nascerà in dicembre”.
Invece questo bimbo ha fretta e sta arrivando.
Regina osserva con disprezzo i segni della sofferenza sul viso quasi sfigurato di Rita: i figli del peccato vengono al mondo con dolore, le sussurra, come una maledizione. Di meglio non ci si può aspettare. In fin dei conti è giusto così: per i propri peccati bisogna pagare.
“Ci dovevi pensare prima di rovinarti”, ripete mentre si scalda le mani dentro uno straccio di lana, senza fare nulla per alleviare le sofferenze della sua unica figlia rimasta in vita. Rita per fortuna non sente. O forse cerca di non ascoltare le parole crudeli di quella madre che non capisce come si è meritata. Anche adesso, nel mezzo del travaglio, ricorda solo le botte. “Io no. Io ti darò tante carezze”, pensa parlando al suo piccolo che non vuole saperne di nascere. Lui non avrà schiaffi, non avrà punizioni, non piangerà per colpa sua. Rita si accarezza la pancia mormorando frasi dolci come se lui, da dentro, potesse sentirla.
Poi un grido disperato sveglia Regina, assopita su una sedia.
“Piantala di lamentarti. Io ho partorito da sola in un fienile e il giorno dopo sono andata a lavorare nei campi. Tutte e due le volte”. Si avvicina al letto zoppicando per la poliomielite che ha avuto da piccola. Non ha dolcezza negli occhi grigi, nemmeno nei ricordi. Le rughe sul viso un tempo grazioso sono profonde: le hanno scolpite la miseria e la durezza. Ha solo cinquantasette anni, ma ne dimostra quindici di più.
Il telegramma indirizzato al Comune di Mantova dal ministero della Guerra le era stato recapitato da un messo municipale in una calda mattina d’inizio estate, un anno prima.
Si compie il doloroso dovere di partecipare la S. V. che il giorno 19 maggio durante la battaglia nella Valle dell’Isonzo è caduto CASADEI GIOVANNI.
Di quanto precede pregasi informare,
con i riguardi che il caso esige,
la rispettiva famiglia.
Riguardi non ce n’erano stati, l’uomo le aveva messo in mano la carta e Regina, che non sapeva leggere, si era girata verso la figlia con gli occhi stravolti dalla paura: “Se è morto non dire una parola, non lo voglio sentire”. Giovanni era stato la grande gioia della sua vita. Giovannino, il figlio maschio, il miracolo che aveva convinto Aldo a sposarla. Quando era nata la primogenita le aveva detto: “Per una femmina io non ti sposo, le figlie non servono a niente”. Regina aveva scelto di dare via la bambina e di continuare a vedere il padre. Era la sua unica occasione. Due anni dopo, però, l’arrivo di Giovannino aveva cambiato tutto: Aldo l’aveva sposata, finalmente, e solo allora la piccola era andata a vivere con i genitori: ci voleva un maschio per rendere una figlia femmina degna di essere nata. “Meglio nascere conigli, che femmine”, diceva un proverbio che Rita sentiva spesso in casa.
Per cinque anni Regina aveva avuto una casa, la pancia piena e notti di sonno tranquillo. Erano stati anni di buoni raccolti, e dunque di serenità. C’era sempre da mangiare sulla tavola, e non solo la polenta. Le galline davano le uova, le due mucche il latte. La verdura la coltivava lei, dietro casa. Lavorava dall’alba al tramonto, ma non si lamentava perché il suo stomaco non era mai stato così quieto. Poi all’improvviso Aldo era morto di febbre. E quello che le aveva lasciato le era bastato per poco, nonostante avesse centellinato il denaro con sempre maggiore parsimonia, giorno dopo giorno. Così si era trovata di nuovo al punto di partenza. Fame e lavoro da cercare, ma tre bocche al posto di una. Allora era andata in città e mai, mai, aveva ceduto alla tentazione di prendere una scorciatoia da donnaccia. La rispettabilità se l’era sudata a lungo e con tanti patimenti che non ci pensava proprio a mandare tutto all’aria.
“Aiutami, mamma. Ti prego, mi sento morire. Chiama un dottore”.
“E con cosa lo pago il dottore? I dottori non vengono a casa della gente come noi. E di certo non aiutano quelle come te a far venire al mondo i bastardi, hanno di meglio da fare. Cosa dirai a tuo marito, quando torna dalla guerra? Che hai tenuto suo figlio in pancia per tre anni? Ci butterà in mezzo a una strada. E tutto perché sei una puttana che non riesce a controllarsi. Ti ho maledetto il giorno che sei venuta al mondo. Mi serviva un figlio maschio, a me. Una femmina poteva portarmi solo guai”. Regina non aveva mai pensato di aver sbagliato quando era rimasta incinta prima del matrimonio. A letto con Aldo lei ci era stata perché intravedeva la possibilità di una vita migliore, non per la fregola. Era furbo e un gran lavoratore, le dava sicurezza. Non era mai stata con nessun altro, né prima né dopo. Anche dopo che era nata Rita aveva continuato ad andarci a letto per tenacia, perché non voleva rassegnarsi: sperava in un miracolo. E poi una zoppa chi la poteva prendere? Sua figlia l’aveva fatta sposare appena aveva capito che aveva simpatia per un ragazzo, per tenerla al riparo dalla vergogna e dalla miseria. Mario era partito soldato quasi subito, la ragazza ovviamente l’aveva delusa: non era stata fedele né al marito, né alle sue speranze. E dire che lo sapeva quale sorte toccava ai bastardi, lei che sulla ruota c’era stata, lei che per i primi anni di vita era stata affidata alla pubblica carità.
Rita respira con affanno. A un certo punto, tra una fitta e l’altra, le sfugge qualcosa che somiglia a un sorriso: pensa a quel giorno di otto mesi prima, quando ha visto per l’ultima volta suo marito Mario. Era marzo, ma per una settimana aveva fatto caldo come in giugno. E loro avevano fatto l’amore sul prato, felici e spensierati come se attorno non ci fossero stati solo fame e guerra, morti e desolazione. Come due ragazzi innamorati. Come se lui poco prima non le avesse raccontato di tutto il sangue, della paura, di quella volta che in trincea si era pisciato addosso per il terrore. Aveva visto corpi dilaniati, pezzi di carne dei suoi compagni gli erano volati addosso. Viveva nel terrore del gas, e sempre con un fazzoletto sul viso, il pane bagnato in bocca. Dopo la disfatta di Caporetto era scappato a piedi, da solo. Era tornata nel suo nascondiglio ancora diverse volte, dopo quel pomeriggio d’amore, inventando scuse che avevano insospettito sua madre, ma di lui non c’era traccia.
Da allora non ha più avuto sue notizie, nemmeno un biglietto. Rita si mette a pregare Gesù, perché non le è rimasto niente altro da fare. Chiede una vita diversa per il suo piccolo, senza fame e soprattutto senza botte. “Vivrai a lungo, amore mio, e sarai felice”. Spera che Mario torni, che si prenda cura di lei e del loro piccolino, spera di non lasciarlo solo con quella donna che conosce soltanto il rancore. Rita sa che sarà un bambino, non può essere una femmina. Non deve. No, non un’altra creatura che subisca l’umiliazione della ruota, dell’abbandono. Suo figlio non vedrà quegli stanzoni enormi, quelle notti di solitudine gelata, senza carezze, senza una parola affettuosa. Deve essere un maschio. Se le dovesse capitare qualcosa, un maschio sua madre lo terrà da conto. In attesa di Mario lo tratterà bene. Adesso che la guerra è finita lui tornerà a casa e tutto si metterà a posto. Mentre cerca di scacciare i cattivi pensieri, una contrazione violentissima la lascia senza forze.
Spunta un giorno grigio mentre il piccolo viene al mondo tra le urla e le imprecazioni di sua madre. Regina lo avvolge in un panno cencioso, comincia a pulirlo per istinto, come ha visto fare mille volte. Toglie il sangue dal corpicino tremante, taglia il cordone ombelicale con un coltellaccio arrugginito. Rita però di sangue ne perde ancora tantissimo ed è sempre più pallida.
“L’è na putina, hai messo al mondo una femmina”, dice la nonna con un lamento sprezzante. Ma Rita non può sentirla, ha smesso di rantolare e di pregare. E’ l’alba dell’Armistizio, un giorno che cambia il mondo.
——
L’11 novembre a mezzogiorno Palazzo Cavriani è attraversato da un viavai di cameriere, domestici e medici. Nonostante il freddo la marchesa ha provato a scendere per fare due passi nel giardino decorato dai busti di Baldassarre Castiglioni e Teofilo Folengo. E’ rimasta solo una manciata di minuti, poi è tornata di sopra e si e` messa a letto. E’ alla sua quarta gravidanza, ormai sa cosa deve aspettarsi quando aspetta. Il dottor Lupi è stato chiamato di prima mattina, l’ha visitata e ha stabilito che tutto va bene: ci vorrà ancora qualche ora. E’ nella sala da pranzo, a consumare uno spuntino con il padrone di casa, quando lo chiamano: “La signora dice che è arrivato il momento”. Il marchese si alza, sbuffa, si agita in cerca di un sigaro: gli uomini non sanno mai che fare quando non possono fare nulla. La marchesa invece è tranquilla, come se potesse dettare lei i tempi di quell’evento. Non ha paura, non ha fretta. Non ha nemmeno molto dolore. Succede tutto rapidamente e senza intoppi: in poco meno di due ore viene alla luce una bambina. Finalmente! Dopo tre maschi, una piccola Cavriani da viziare e coccolare con vestiti di pizzo e lezioni di francese. La marchesa sorride, i capelli castani sparsi sul cuscino ricamato. La bimba si addormenta subito. Gliela portano, lei la accarezza con cautela e orgoglio. E’ minuscola, non come gli altri figli che appena nati pesavano come un vitellino. Ha pianto poco e si è messa subito a dormire. Fragile e mite: tutta il contrario di sua madre. E’ sul fare di quel pensiero che la marchesa prende una decisione: “Ti chiamerò Elda come la mia formidabile nonna. E sposerai un principe, anzi un re“. Per adesso la bimba non è proprio bella. Ma nessun neonato lo è davvero.
Al marchese sembra che la nascita di sua figlia il giorno dell’Armistizio non sia una coincidenza. E’ soddisfatto: ha già tre maschi, un erede più due riserve, casomai capitasse una disgrazia. E’ stata proprio brava sua moglie, ha fatto tutti i figli nell’ordine giusto. Come Dio vuole. La piccolina – è l’ultima, il marchese ne e` certo – sarà un piacevole diversivo per le loro giornate. Sale dalla moglie per conoscere la nuova arrivata mentre pensa a quanto la sorte è stata benevola con la sua famiglia. “La voglio chiamare Irene, che in greco vuol dire pace”, spiega solennemente arricciando i baffi in un gran sorriso alla vista della piccola. La marchesa pensa di ribattere che no, la vuol chiamare come sua nonna Elda che era una donna forte e bellissima e aveva fatto un gran matrimonio. Ma all’improvviso la stanchezza del parto prende il sopravvento, non trova più le forze, accarezza la testa della bimba, guarda il marito e sa solo arrendersi: “Va bene, caro. E’ un bel nome Irene. E poi ce ne sono poche. Si distinguerà”. La donna cerca di con- vincersi di aver fatto bene. No, non è un nome di cui vergognarsi. Eppure tiene il capo chino e gli occhi bassi. Dentro di sé sa che non vuole chiamarla Irene. Vuole Elda! Alza gli occhi per dire qualcosa. Il marito nota un bagliore nello sguardo: “Che c’è? Stai male? O non ti piace il nome?”.
“No, no. Va tutto bene. E’ un nome bellissimo Irene. E’ degno del nostro lignaggio”, dice recuperando la superbia che la fatica del parto le aveva temporaneamente portato via. Vorrebbe rispondere che lei preferisce Elda, che i nomi dei tre figli maschi li ha decisi lui. Che è stata lei a mettere al mondo quattro figli sani nell’ordine giusto e quindi ha diritto di scegliere almeno il nome dell’ultima. Dopotutto, che gli importa? E’ solo una femmina. Ma anche lei è femmina, ed è abituata a obbedire. E allora non dice niente. La bambina si chiamerà come vuole il padre. La prima rinuncia della sua vita Irene la porta nel nome, impressa come un marchio.
—
Il vento che soffia dal lago è gelido. Regina tiene stretto il fagotto dentro il cappotto liso mentre copre la poca distanza che separa vicolo Barche da piazza Ferrante Aporti. Sale al secondo piano di una casetta che le pare una reggia: ha perfino le tende alle finestre. “Regina, come posso aiutarti?”, dice la padrona di casa mentre la fa accomodare. C’è molta luce nell’appartamento e un fuoco scoppiettante riscalda il soggiorno che odora di pane, ma alla vecchia quell’improvviso calore fa male alle ossa, tanto è abituata all’umido del suo tugurio a piano terra.
Non ci gira intorno.
“Rita è morta qualche ora fa”, spiega con calma mentre deposita la bambina su una poltrona. “E’una femmina”.
Luisa impallidisce, si lascia cadere su una sedia. Gli occhi le si velano di lacrime. “Povera Rita”, mormora.
“Doveva pensarci prima, prima di…” Regina vorrebbe finire la frase ma non ci riesce. Le si strozza la voce, capisce che non può insultare sua figlia davanti a Luisa, soprattutto ora che le deve chiedere un grande favore. E non sa ancora se potrà contare sull’aiuto dell’unica amica che Rita ha avuto, la bella napoletana che sua figlia definiva “la creatura più buona che c’è al mondo”.
“Regina”, Luisa le si avvicina e le circonda le spalle con un braccio. “Rita non ha fatto niente di male”. Nei suoi occhi dolci compare una supplica.
“Niente di male? Niente di male? Ha fatto un figlio con chissà chi mentre suo marito è a combattere! Come ha potuto? Proprio lei, come ha potuto?”. La donna trema di stanchezza, rabbia e dolore.
“Regina, siediti. Ti devo confessare un segreto, una cosa che nessuno sa. Mario ha disertato l’anno scorso, è tornato qui per qualche giorno. Stava male, aveva smesso di dormire e diceva che usciva pazzo se restava in trincea. E’ tornato qui, me l’ha detto Rita. Mi devi credere. Ero l’unica a cui lo aveva confidato, perché era terrorizzata che lo arrestassero. E me l’ha detto prima di sapere che aspettava un bambino. Devi credermi, Regina. Rita non ha fatto nulla di male”.
All’improvviso si sente un vagito. E’ il piccolo Antonio, il figlio di Luisa. Il suo terzo. Ha nove mesi, sua madre lo prende in braccio per cullarlo, aspettando una parola gentile di Regina, che non arriva.
“Non ci credo. Adesso non ho tempo per queste fole. La bambina è nata sana. Ma io non ho niente, non la posso mantenere, e adesso non c’è più nemmeno sua madre che porta a casa i soldi. La balia costa dieci lire al mese! Sono venuta a chiederti se puoi darle tu il latte, almeno per un po’. Sennò la metto sulla ruota, come ho fatto con sua madre”. Regina scandisce le parole con fermezza, senza indecisioni. Luisa sbircia verso il fagotto appoggiato sulla poltrona: da quando è entrata, la bimba non ha fatto un fiato anche se è sveglia, muove gli occhi e agita le manine. Sembra che sappia che non deve dare fastidio. Un raggio di sole entra nella stanza. “Certo che le darò il mio latte”, dice Luisa sorridendo, e si avvicina alla poltrona per prendere in braccio la piccola.
“Tuo marito non brontolerà?”, chiede Regina diffidente, mentre si avvicina ancora di più al camino attratta dal fuoco.
“Ci penso io a lui. Ma non penso che si arrabbia. Dopotutto il latte è mio”, risponde la donna arrossendo un poco. E poi, illuminandosi: “Ma come l’hai chiamata?”.
“Non l’ho chiamata in nessun modo. Scegli tu, non m’importa, basta che non è Rita: per me lei non è mai esistita. Io ho avuto un figlio solo, Giovannino. E la guerra me l’ha portato via”.
“Regina”, Luisa le posa una mano sul braccio. Vorrebbe dirle qualcosa, ma resta paralizzata dal suo sguardo feroce. Ha paura, anche se non sa di cosa. Vuole solo che quella donna se ne vada.
“Va bene. Finché avrò latte ci penso io. Mia mamma si chiamava Dora, era una donna buonissima: ti piace?”, chiede mentre la bimba finalmente fa sentire la sua voce con un gridolino quando viene depositata su una poltrona dai braccioli alti e dal tessuto liso.
“Dora o Cora, fai come vuoi. Non me ne importa nulla. Grazie”. A malincuore Regina se ne torna a casa sua, dove farà un freddo del diavolo. Almeno ha sistemato quella seccatura per un po’ e non sarà lei a doversene occupare. Adesso deve pensare a come sopravvivere. Quando la porta si chiude, Luisa si avvicina al fagottino di stracci, spoglia la bimba e le infila un vestitino bianco immacolato di Antonio. Poi si slaccia la camicetta e le porge un seno: la piccola si attacca al capezzolo, succhia voracemente.
Una lacrima scivola sulla guancia di Luisa. Quel gesto le sembra il più naturale del mondo, eppure non riesce a dimenticare il sorriso triste di Rita, che aveva sempre gli occhi sulle punte delle scarpe e parlava pochissimo. Si ammazzava di fatica per portare a casa due soldi e dopo una giornata passata a fare la sguattera, o la lavandaia, la sera si consumava la vista con i lavori di cucito che racimolava qua e là. Un’altra lacrima, ancora un’altra. Un pianto silenzioso mentre Dora continua a succhiare. Finalmente la piccolina riceve una carezza sulla testa, la prima della sua vita: non lo sa ancora, ma sarà la cosa di cui più sentirà la mancanza.