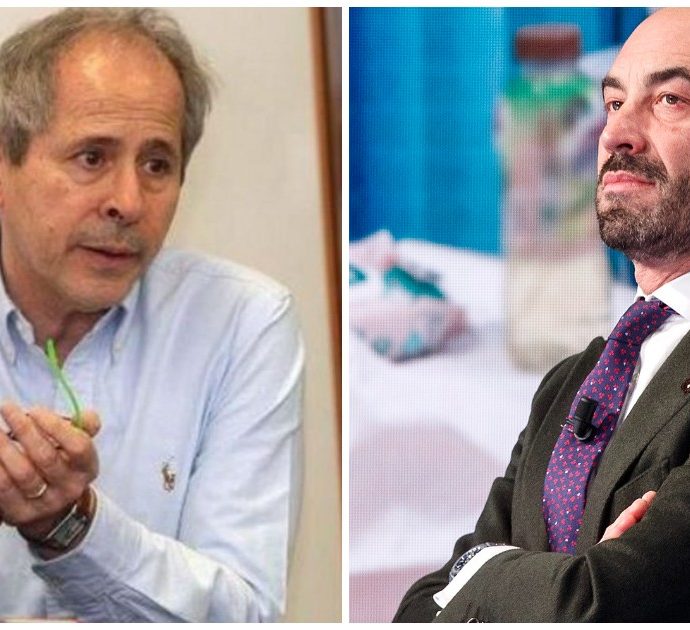Han spergiurato per una vita che li avrebbero regalati. Un po’ come Totò con la Fontana di Trevi, visto che non sono mai stati loro. Ma alla fine l’han fatto davvero. I Savoia hanno citato lo Stato per riavere i famosi gioielli che sono in Banca d’Italia dal 1946, consegnati allo Stato dallo stesso Re Umberto II prima di lasciare l’Italia. La prima udienza si terrà il 7 di giugno e sarà uno scontro storico, nel senso che i legali della real casa scodelleranno pergamene, regi decreti, registri, diari e quant’altro. Detto che, come vedremo, il valore del “tesoro” è alquanto incerto. Detto che, come vedremo, i Savoia in passato han cercato più volte di barattarlo in cambio della loro agibilità da esiliati, ecco un breve ripasso dal fondo della storia alla sua evoluzione grottesca. Reggetevi forte.
Per attribuire la proprietà del cofanetto si fa un salto indietro di 75 anni. E’ il 5 giugno 1946, giorno in cui il ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, lo consegnò all’allora governatore della banca nazionale con un verbale di deposito che recita: “L’avvocato Lucifero dichiara di aver ricevuto incarico da Sua Maestà di affidare in custodia alla Banca d’Italia le gioie in dotazione della Corona del Regno d’Italia per essere tenute a disposizione di chi ne avrà diritto”. Ecco, sulle ultime quattro parole si gioca gran parte della linea dei legali dei Savoia, perché la formulazione appare sufficientemente ambigua da accampare pretese. Se non bastasse, si appelleranno a tre righe che il governatore Luigi Einaudi scrisse in proposito nel suo diario (a pagina 657): “la mia impressione è (…) che potrebbe ritenersi che spettano non al demanio dello Stato, ma alla famiglia reale”.
Ma quei gioielli, ,e non è un’impressione, sono sempre stati dello Stato. Lo sancisce una legge dell’allora Regno di Sardegna. La ripubblichiamo, a scanso di equivoci. E’ il 1850, legge reale n.1004, in attuazione dello Statuto albertino di due anni prima che era “legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia sabauda”. Dunque non una qualsiasi, e con tanto di firma del Re. Precede tutte le altre carte, bollate o meno, su perle, diademi e dintorni. E che diceva? Serviva a stabilire la “dotazione” (che non è la proprietà) di cui il Re d’Italia godrà durante il suo Regno. Dopo i beni immobili, palazzi, scuderie e quant’altro l’art. 3 indica i beni mobili e cita espressamente: “La dotazione riguarderà le gioie, perle, pietre preziose”. Le gioie saranno poi inventariate nel 1850, 1868, 1886 e 1913.
Chi, come i Savoia, ha vissuto tanto all’estero può non avere dimestichezza coi termini. A chiare cosa sia la “dotazione”, per fortuna, arriva il capo quarto dell’articolato che riguarda i soldi, la moneta universale che per definizione capiscono tutti. Trattasi dell’ammontare “dell’assegnazione d’un’annua somma sovra le Finanze”. La somma è stabilita in quattro milioni di lire, “da ripartire per dodicesimi e anticipare di mese in mese al delegato dal Re”. In sostanza palazzi, soldi e gioielli sono forniti dallo Stato ai reali, perché ne godano durante il loro Regno. Non erano e non sono mai stati di loro proprietà.
Bella scoperta, vien da dire. Perché in realtà tutta questa storia è stata già scritta 46 anni fa. Nel giugno del 1976 il sostituto procuratore Antonio Scopelliti si è trovato davanti lo stesso problema. Sono arrivate denunce un po’ fumose circa la manomissione della famosa custodia marcata da dodici sigilli in ceralacca e la sparizione di alcuni “pezzi”. Per venirne a capo il pm dovette districarsi tra la stessa impolverata giurisprudenza in materia, incappando proprio nelle definizioni della legge del 1850. E alla fine decise: quei gioielli appartengono allo Stato.
L’iniziativa giudiziaria avviata ora dai discendenti di casa Savoia, tanto intempestiva da coincidere con l’elezione del Presidente della Repubblica, è dunque il remake di un film già visto. Gli sceneggiatori reali, per carità di Patria, hanno solo stralciato alcune parti dal copione della stessa commedia. Ad esempio quella del valore del “tesoro”, mai peritato, che potrebbe anche riservare brutte sorprese ai pretendenti. Per alcuni sarebbe inestimabile, per altri no. Per inciso: Gianni Bulgari nell’ispezione del ’76 sopra ricordata aveva molti dubbi. Sui quali grava anche il tema della conservazione: il 2 marzo 2003 lo stesso Vittorio Emanuele, intervistato da La Stampa, ipotizzò che le perle chiuse nel caveau, probabilmente, fossero ormai plastificate.
C’è poi tutto il capitolo in cui sono i Savoia stessi a rinnegare i gioielli (che non possiedono) per a usarli come merce di scambio per la loro ritrovata agibilità. Gli stessi per cui oggi invece sono disposti a ricorrere alla Corte europea (Emanuele Filiberto dixit). Ed è una storia che, non a caso, si colloca a partire dagli anni duemila, quando cioè traballa il muro che li trattiene fuori dall’Italia. Sono gli anni in cui s’intensifica la campagna per mettere fine all’esilio e cancellare il plebiscito del 2 giugno 1946 che sancì la fine della monarchia in Italia.
I Savoia si rivolgono a Strasburgo (che li rimbalza) ma trovano soccorsi in Parlamento, dove approda la proposta di legge costituzionale confezionata per loro, che decapita il primo e secondo comma della XIII disposizione della Carta che vietava ai discendenti maschi l’ingresso e il soggiorno in Italia. Si scatenano polemiche furibonde: c’è chi chiede che prima di rientrare gli eredi della stirpe risarciscano gli italiani per i danni della guerra, chi di approfittarne per cambiare nomi alle piazze. L’11 luglio del 2002 la Camera dei Deputati vota la resa, senza condizioni, con un articolo di una sola riga: avanti Savoia. Fatto il ripasso, che c’entrano i gioielli?
Nella primavera del 2003 il rientro è ormai imminente, è tutto un ragionare di calendario, di tappe, incontri. Temendo forse di non trovare solo tappeti rossi, Vittorio Emanuele torna a parlare dei gioielli e alla Stampa solennemente proclama: “I nostri beni sono dell’Italia, non chiediamo niente indietro, basta diffamarci”. Insomma, se lo dice lui. Tre anni dopo lo conferma, che non si dica che i reali batton cassa. E’ il 2006, il Piemonte è in da Olimpiadi e il deputato di Forza Italia Raffaele Costa ha la brillante idea di esporre i gioielli in una mostra per impreziosire l’evento, briga in tutti i modi per riuscirci. Seguono le solite polemiche, qualcuno insinua che il solo concederli in esposizione avrebbe indotto i Savoia a rivendicarne la proprietà.
Il deputato torinese, da galantuomo, scrive un’accorata lettera al ministro Tremonti, ci mette la faccia: “Vittorio Emanuele e Emanuele Filiberto hanno già espresso chiaramente la loro intenzione di non rivendicare alcunché“. Per togliere ogni dubbio, il rampollo – che all’epoca aveva un piede nella finanza svizzera e uno nella politica italiana (si è candidato nel 2008 e 2009), il 24 febbraio 2006 giura a Libero: “Regalo all’Italia gli antichi gioielli di casa Savoia”. Un po’ come Totò alla Fontana di Trevi. Non sarà eletto, non farà quel regalo all’Italia. Non era neppure suo.
I reali di oggi, si dirà, non sono quelli d’una volta, che firmano armistizi e scappano di notte, sono di parola. E infatti se nel 2006 spergiurano di non volere niente dall’Italia nel 2007 chiedono 260 milioni di euro. Bussano alle porte del governo per rivendicare un mega-risarcimento per i 54 anni d’esilio: 170 per papà (Vittorio Emanuele), 90 per il figlio (Emanuele Filiberto). Oltre agli interessi maturati sulle cifre, oltre la restituzione dei beni confiscati dallo Stato al momento della nascita della Repubblica (gioielli compresi, ça va sans dire). Il tutto con una letterina di sette pagine mandata a Napolitano e Prodi. Toccò a Carlo Malinconico, all’epoca potente segretario della Presidenza del Consiglio, rispedirla al mittente e anzi ringhiare alla pretesa, ventilando una contro-richiesta di danni all’ex famiglia reale “per le sue responsabilità nella storia italiana”. Alla fine? Nessuno ha pagato nessuno. I reali di casa Savoia ora ci riprovano. Poveretti, ormai è tradizione di famiglia. E povero principe, sbarca il lunario ballando sotto le stelle.