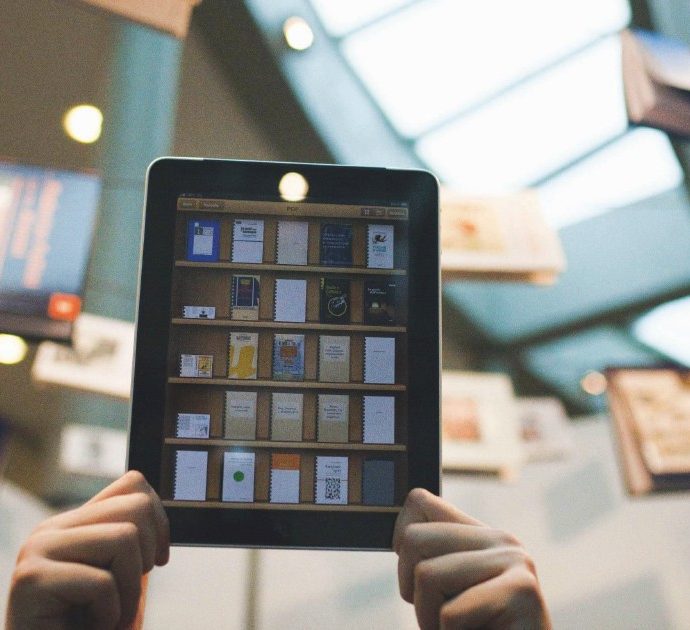Non c’è melodramma senza scena. Da sole, parole e musica non bastano. All’opera si va per il teatro, l’azione, il gesto, i movimenti. Nell’Ottocento nacquero le “disposizioni sceniche”, appositi opuscoli che fissavano per iscritto lo spettacolo, un po’ come il libretto fissa il testo, e la partitura la musica. L’esigenza di conservare traccia della messinscena nacque all’Opéra di Parigi, dove certi spettacoli rimanevano in repertorio anche per mezzo secolo: il Livret de mise en scène consentiva di trasmettere ai tecnici e alle maestranze delle generazioni successive quel che occorreva sapere per allestire opere complesse come il Guglielmo Tell di Gioachino Rossini o Gli Ugonotti di Giacomo Meyerbeer.
In Italia fu l’editore Ricordi a introdurre le disposizioni sceniche, per certe opere di successo, Giuseppe Verdi in primis. L’esigenza era qui un po’ diversa: il sistema operistico italiano non era incentrato su un teatro preminente come l’Opéra, bensì su una rete teatrale diffusa. Le disposizioni davano dunque un orientamento a chi riprendeva un dato melodramma in un diverso teatro e rispondevano a un interesse commerciale: insieme col noleggio della partitura, l’editore distribuiva questi testi ai teatri per additare un modello scenico che assicurasse una visione complessiva coerente. Il successo delle riprese alimentava lo smercio. Disposizioni sceniche memorabili uscirono per Aida (1872), Simon Boccanegra (1881), Otello (1887): oltre la descrizione verbale dei costumi e dei cambi di scena, vi figurano schemi e diagrammi che dettagliano minutamente la posizione e i movimenti dei personaggi.
Nel 1893 Giulio Ricordi compilò di suo pugno la disposizione di Manon Lescaut, opera ambiziosa e travagliata del giovane Giacomo Puccini, che l’editore volle lanciare alla grande. Dal 2012 il Centro studi Puccini di Lucca, con EDT di Torino, ha avviato una collana apposita dell’Edizione nazionale delle opere di Puccini per le disposizioni superstiti. Dopo il volume dedicato alla messinscena parigina di Madama Butterfly (1906), curato da Michele Girardi, nel 2021 è toccato appunto alla Manon Lescaut, a cura di Maria Ida Biggi, direttrice dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Sono lavori di grande perizia e acribia, essenziali per la miglior comprensione storica del teatro pucciniano.
L’uso delle disposizioni sceniche decade nel primo Novecento. Negli stessi decenni affiora il concetto di “regìa“, grazie a pionieri come Adolphe Appia, Konstantin Stanislavskij, Edward G. Craig, Max Reinhardt. Prima d’allora il regista non esisteva: c’era il “direttore di scena”, uomo esperto dei segreti del teatro, responsabile del buon funzionamento della macchina complessiva secondo una collaudata routine. L’idea della regìa segna una svolta epocale: la messinscena assurge a interpretazione specifica, di volta in volta diversa e originale, dell’opera d’arte teatrale. A modo suo il regista si erge al rango di un coautore, che imprime alla realizzazione scenica del dramma o del melodramma un’impronta tutta sua.
Conosciamo lo stato odierno delle cose. Certi spettatori accettano volentieri modifiche anche sostanziali – in particolare l’“attualizzazione” dell’intreccio, ossia la trasposizione in contesti contemporanei, o comunque alieni al progetto drammatico originario –, altri invece deplorano la rinuncia all’ambientazione prescritta. Chi ha ragione? Chi torto? Nessuno. Dipende. Ci sono attualizzazioni ammirevoli, e ci sono noiosissime fedeltà alla tradizione. Ma c’è anche l’inverso: attualizzazioni cervellotiche, e accattivanti ricostruzioni meticolose. Una cosa importa su tutte: il lavoro del regista non deve tradire il senso profondo dell’opera.
Damiano Michieletto, regista geniale e controverso, ha allestito ad Amsterdam nel 2015 Il viaggio a Reims: lo ha ambientato non già in un albergo della provincia francese coeva bensì in una galleria d’arte, dove i dipinti in mostra e in vendita vanno e vengono, con momenti di vero brio. Certo, questa di Rossini è quasi una “cantata scenica”, poca azione, scena unica: ci si può inventare di tutto. Molto dipende però dalla finezza del regista. L’apparizione delle Tre Grazie di Antonio Canova (oggi all’Ermitage) diventa in Michieletto un attimo di assoluta, siderale bellezza. Tradizionalissimo, e in buona parte ispirato alla “disposizione” originale, fu il fulgido Simon Boccanegra allestito da Sylvano Bussotti a Torino (1979): il grande artista – scomparso nel settembre scorso – diceva che il regista deve intervenire pochissimo. Di certo, il mare di Genova che sovrasta la vicenda del corsaro Simone è, nella creazione di Sylvano, indimenticabile.
Che dire del Macbeth di Davide Livermore dato alla Prima della Scala? L’invenzione di un’avveniristica distopia, sfavillante e angosciosa, può benissimo surrogare la Scozia del secolo XI. Ma per Verdi “i ruoli di quest’opera sono tre: Lady Macbeth, Macbeth, le streghe“; e la tragedia, in Verdi come Shakespeare, è tutta giocata sul rapporto fra umano e sovrannaturale. Bastano le poche pose grottesche che Livermore ha dettato alle coriste-streghe, schierate sul proscenio, per dare teatrale evidenza a questo nevralgico terzo “ruolo”?