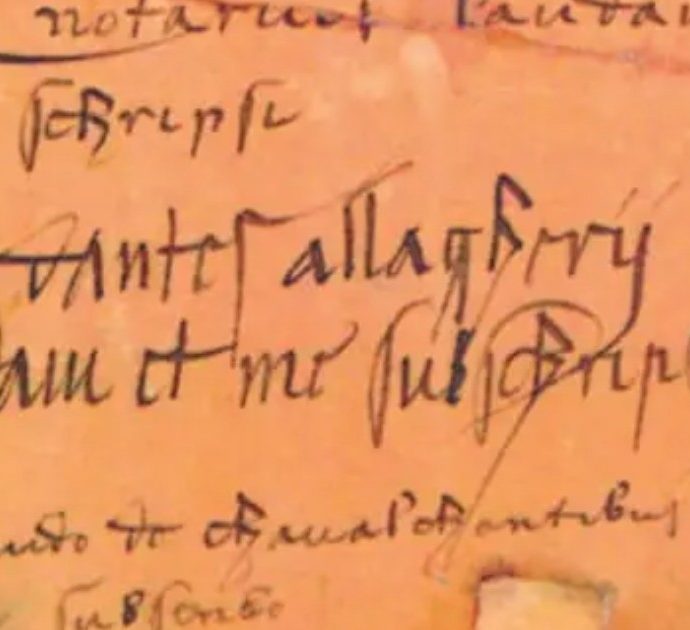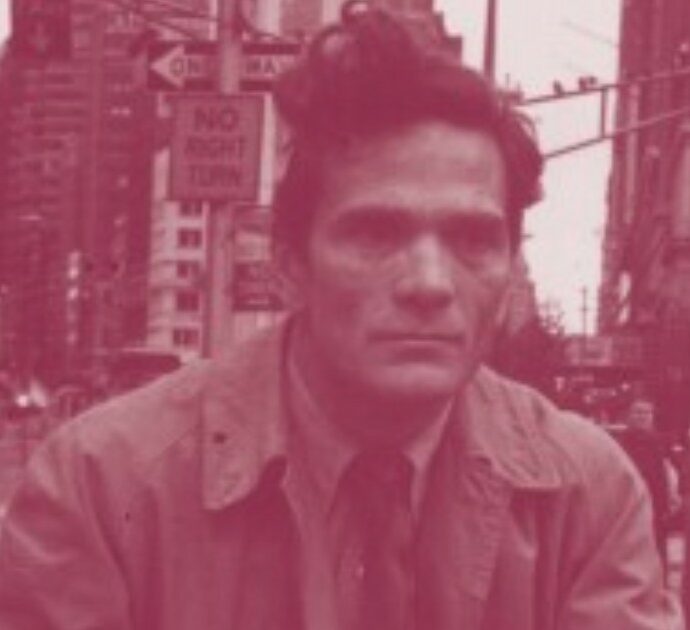Sono passati quasi settant’anni dal giorno dell’incoronazione – la prima trasmessa in diretta televisiva – sotto le magnifiche volte dell’abbazia londinese di Westminster, e da quel 2 giugno la fama e la popolarità di Elisabetta II non hanno fatto che aumentare. Nel suo ruolo pubblico ha vissuto in prima persona cambiamenti storici epocali, attraversando guerre mondiali e  tempeste politiche; come capo della famiglia Windsor ha dovuto affrontare scandali e tragedie, divorzi e rappacificazioni. La ferma compostezza con cui è rimasta al centro della scena per tutti questi anni l’ha trasformata in un mito che nel libro Elisabetta – La regina infinita (Garzanti, 336 pp, 16 euro) il giornalista e scrittore Alberto Mattioli e il cultore Marco Ubezio celebrano con pura passione e divertita riverenza.
tempeste politiche; come capo della famiglia Windsor ha dovuto affrontare scandali e tragedie, divorzi e rappacificazioni. La ferma compostezza con cui è rimasta al centro della scena per tutti questi anni l’ha trasformata in un mito che nel libro Elisabetta – La regina infinita (Garzanti, 336 pp, 16 euro) il giornalista e scrittore Alberto Mattioli e il cultore Marco Ubezio celebrano con pura passione e divertita riverenza.
Alberto Mattioli è giornalista della Stampa. Esperto d’opera, ha collaborato con molti teatri e riviste italiani e internazionali. Ha scritto sei libri, tre libretti d’opera, molti saggi e qualche migliaio di articoli. Con Garzanti ha pubblicato Meno grigi più Verdi (2018), Il Gattolico praticante (2019), Pazzo per l’opera (2020) e Un italiano a Parigi (2021).
Marco Ubezio è un avvocato con la passione per la monarchia inglese. Ha partecipato alla trasmissione televisiva Rischiatutto scegliendo come tema proprio la regina Elisabetta II, alla quale ha anche dedicato una pagina Facebook di grande successo.
Muovendosi lontano dai profili biografici fatti di gossip e di veri o presunti scoop, ma distillando con humour il senso profondo di una vita straordinaria, i due autori raccontano la favola di una regina che sembra aver sfidato le leggi del tempo e di cui tutti continuiamo a subire l’infinito fascino.
Ilfattoquotidiano.it, grazie alla gentile concessione di Garzanti, pubblica l’anticipazione di un brano del libro.
***
Quel 2 giugno 1953 sarebbe potuto essere un giorno di metà novembre o forse di febbraio, umido, freddo e sferzato da un vento tagliente. Nonostante un tempo inclemente anche per gli standard britannici, fin dalla notte precedente una folla mai vista si era raccolta lungo l’itinerario del corteo. Si calcola che fossero non meno di un milione di sudditi di sua maestà ma anche quarantamila americani, tra i pochi al mondo che in quel tempo potevano darsi al turismo internazionale.
Tra questi, anche la brillante reporter del «Washington Times Herald», tale Jacqueline Bouvier, che da first lady avrebbe visitato la Regina a Buckingham Palace una decina di anni più tardi. Come aveva sagacemente annotato nel suo reportage la futura signora Kennedy, gran parte delle deposte teste coronate, la quota più numerosa tra gli invitati di sangue blu, aveva preso soggiorno al Claridge’s dove la sveglia mattutina era in realtà avvenuta in piena notte. Alle 3.30 le signore avevano l’appuntamento con il parrucchiere, in tempo utile per essere sedute, insieme ai loro detronizzati consorti, a Westminster alle 6.30, nelle non proprio comodissime tribune allestite per aumentare la capienza dell’abbazia. Nell’attesa, ai presenti era stata garantita la distribuzione di sandwich e bevande alcoliche, indispensabili, almeno le seconde, per riscaldare gli animi e le viscere dentro la ghiacciaia in cui si era tramutata Westminster quella mattina. Si battevano letteralmente i denti per il freddo, come aveva candidamente confessato la contessa di Huntington ai lettori della rivista di sinistra «The New Stateman». In considerazione della congiuntura economica, ai pari del regno, che avrebbero dovuto indossare mantello cerimoniale e corona araldica, di foggia diversa a seconda del loro titolo, fu consentito di sostituire l’ermellino con un più abbordabile coniglio. In compenso, per mantenere il decoro, ai presenti di sesso maschile era stato chiesto di nascondere i sandwich dentro le corone.










La parata partì alle nove: includeva ventinove bande e ventisette carrozze, e qualcosa come tredicimila soldati in alta uniforme, in rappresentanza di cinquanta Paesi del Commonwealth. Non passò inosservata la giunonica e sorridente Regina Salote di Tonga, a bordo di una carrozza scoperta nonostante la pioggia, avvolta in un mantello di seta rosso sul quale era appuntato l’ordine di San Michele e San Giorgio ricevuto da Giorgio VI. Lei elargiva larghi sorrisi al pubblico, che in gran parte ignorava persino l’esistenza del Paese da cui proveniva la serafica Regina, che divenne comunque uno dei personaggi più popolari della giornata.
La carrozza dorata della Regina, un ensemble barocco di statue e pannelli dipinti risalente al XVIII secolo e trainato da otto cavali bigi, uscì da Buckingham Palace esattamente alle 10.26, l’orario calcolato al millimetro nei giorni precedenti per permettere alla Regina di entrare a Westminster alle undici in punto. Il vestito, confezionato dal solito Hartnell, era in satin con fili d’oro, perline e pietre preziose. Sulla gonna erano ricamati i simboli del Regno Unito e degli altri reami del Commonwealth. Filippo indossava la divisa di ammiraglio della flotta, che sarebbe poi stata parzialmente nascosta dal mantello bordato d’ermellino di pari del regno. Le otto damigelle, ragazze nubili delle più importanti famiglie, indossavano un vestito di stile e colore identici a quello della Regina e, per essere simili anche nella figura, avevano indossato scarpe con tacchi di altezze diverse. All’arrivo della Regina davanti alla facciata gotica di Westminster una delle damigelle, mentre le srotolava l’imponente strascico del mantello di Stato, le aveva chiesto sussurrando se si sentisse nervosa. «Certamente, lo sono», fu la secca risposta di Elisabetta, che aggiunse: «Anche se penso che Aureole vincerà il Derby». Si riferiva al cavallo della sua scuderia che pochi giorni dopo avrebbe corso a Epsom, senza per la verità arrivare primo.
Con lo stesso sprint di un purosangue ai blocchi di partenza, la Regina iniziò allora la processione verso l’ingresso, non prima però di aver lanciato una rapida occhiata alle damigelle e di averle richiamate all’ordine con parole che parevano prese a prestito da una corsa di cavalli: «Pronte, ragazze?». Il corteo che procedeva lento lungo la navata centrale di Westminster appariva non poco variegato. Tra i capi di Stato e i membri del corpo diplomatico figuravano un dignitario africano vestito di pelle di leopardo con un cappello piumato ma anche un chierico musulmano in tunica nera e perfino una donna in abito monacale grigio, che poi altri non era che la principessa Alice, mamma di Filippo.
Mentre la Regina si avvicinava all’altare la sua pesante gonna aveva iniziato a dondolare, in un movimento quasi ritmico, nello stile dei balli di quegli anni. Fu in qualche modo una premonizione della Swinging London del decennio successivo anche se, paradossalmente, quello era stato l’unico momento della cerimonia in cui il coro di voci bianche aveva intonato un inno nell’antica lingua degli invasori romani: «Vivat Regina Elizabetha! Vivat! Vivat! Vivat!». Con la Regina ancora in piedi a fianco della Coronation Chair, il trono di quercia impiegato per tutte le incoronazioni dal 1308 in poi, l’arcivescovo di Canterbury aveva iniziato il rito del «riconoscimento» della nuova sovrana da parte dei dignitari presenti ai quattro angoli dell’abbazia.
All’intonazione, a turno, del God Save the Queen da parte di ciascuno dei quattro settori, la Regina aveva risposto chinando impercettibilmente il capo in un lento mezzo inchino, unica occasione nella sua vita in cui avrebbe ripetuto quei gesti di norma rivolti a lei. Dopo il giuramento di difendere la legge di Dio e quella del Regno Unito e degli altri reami, iniziò la parte più spirituale della cerimonia. Ancora in piedi davanti alla Coronation Chair, Elisabetta fu spogliata del mantello, dei guanti e dei gioielli per prepararsi al momento più solenne della cerimonia, l’unzione del capo, dei palmi delle mani e del petto. Per riceverla, la Regina si era accomodata sul trono di Re Edoardo, sopra il quale era stato srotolato un pesante baldacchino intessuto di seta e oro, sorretto da quattro cavalieri della Giarrettiera. A differenza di Vittoria, l’ultima donna che aveva ricevuto l’unzione prima di lei, Elisabetta aveva consentito all’arcivescovo di ungerle anche il petto, appena sopra l’attaccatura del seno. Il momento più sacro dell’incoronazione, e ciò vale ancora di più per Elisabetta che è sempre stata animata da un profondo senso religioso, va individuato proprio nell’unzione, perché rappresenta il mandato con cui Dio consacra la vita del sovrano a servizio della Nazione.
È il motivo per il quale la parola abdicazione non esiste nel vocabolario di Elisabetta: sarebbe una profanazione. Le telecamere della Bbc si riaccesero nel momento in cui Elisabetta, indossata una semplice tunica di lino, fu gradualmente rivestita di tutti i paramenti della regalità, inclusa quell’antica corona il cui peso simbolico sarebbe in qualche modo rimasto sul suo capo per tutta la vita, generando di tanto in tanto qualche spiacevole mal di testa. Bardata e incoronata, assisa sull’antico trono di legno tarlato, dallo schienale triangolare, Elisabetta assomigliava a una Madonna del Rinascimento, forse un Botticelli per la ricchezza delle vesti e l’opulenza dei dettagli. Il primo a renderle omaggio fu l’arcivescovo di Canterbury; a seguire, tutti i pari del regno, partendo da quel principe atletico con cui condivideva il talamo da oltre cinque anni. Nel palco reale, Carlo, una camicia di seta su pantaloncini corti scuri, stava in piedi tra la Regina Madre, che nella compostezza dello sguardo non nascondeva una certa malinconia, e la zia Margaret, che non mostrava propriamente entusiasmo. A un’amica avrebbe confessato tutto il suo dolore per la perdita contemporanea dell’amatissimo padre, che per lei aveva un debole e, in fondo, anche della sorella. Appoggiato alla balaustra della tribuna, con il palmo della mano destra sotto la guancia a sorreggere una testa un po’ ciondolante, Carlo pareva decisamente annoiato.
La cerimonia in effetti durò quasi cinque ore e forse il piccolo principe già presagiva un’attesa piuttosto lunga prima di prendere posto su quella stessa sedia di legno. Anche se forse non avrebbe mai immaginato che nell’attesa avrebbe maturato una quantità di rughe sul volto perfino superiore a quelle di sua madre. Dopo la comunione, anche questa preclusa alle telecamere, la Regina fu aiutata dalle sue damigelle a cambiarsi d’abito, lasciando in abbazia la corona di sant’Edoardo, che i monarchi indossano solo durante l’incoronazione: al suo posto, la più leggera corona imperiale di Stato, la stessa che porta anche oggi nella cerimonia di apertura del parlamento. Nelle nuove vesti cerimoniali, la Regina percorse a ritroso la navata centrale e prese posto, con Filippo al fianco, sul cocchio dorato che tanto sapeva di favola Disney per un percorso di oltre due ore per le strade festanti di Londra, cui il cielo aveva regalato una pioggia scrosciante.
Ennesima prova che le lacrime del cielo sono spesso presagio di buona sorte. Quel giorno, un rito vecchio di mille anni fu raccontato a un pubblico di cinquecento milioni di persone dalla voce suadente e un po’ ipnotica di sir Richard Dimbleby, l’anchorman della Bbc. Tra i telespettatori, due terzi dei cittadini britannici ma anche un terzo della popolazione degli Stati Uniti. Un po’ come accaduto per altri eventi, spesso tragici, gran parte dei sudditi di sua maestà avrebbero a lungo ricordato cosa stesse facendo il giorno dell’incoronazione, incluso un ragazzino di dodici anni di una famiglia operaia di Liverpool. «Era stato esaltante! Sono cresciuto con la Regina, quel giorno sembrava una bambina. Era bellissima e affascinante!», raccontò molti anni dopo quel ragazzo. Si chiamava Paul e insieme ad altri tre amici di Liverpool avrebbe fatto prima ballare e poi anche pensare il mondo intero.
Al suo rientro a Buckingham Palace con il naso raffreddato, Elisabetta, sfilate le scarpe come qualsiasi ragazza dopo un ballo, invitò le damigelle a buttarsi sul divano insieme a lei. «Tutto è andato bene!», fu la sua semplice constatazione. A distanza di quasi settant’anni, appare difficile darle torto. A tu per tu con la corona di sant’Edoardo, la Regina si sarebbe ritrovata solo sessantacinque anni dopo, in occasione di una rarissima intervista rilasciata alla Bbc per un documentario sull’incoronazione. Volle afferrarla di nuovo, soppesandola a due mani e ricevendo la conferma di quanto fosse pesante e del rischio che aveva corso di rompersi l’osso del collo. Con una punta di ironia, aveva constatato la presenza di «alcuni svantaggi nelle corone» sebbene, concluse, si trattasse di «cose piuttosto importanti». Alla fine, però, un pensiero speciale la Regina infinita l’aveva rivolto alle perle pendenti dal globo crucifero montato sopra la corona, che un tempo erano state gli orecchini della sua omonima antenata. «Sono creature viventi», aveva affermato, con una punta di malinconia per la solitudine delle perle, e forse non solo per la loro.
© 2022, Garzanti S.r.l., Milano