La trattativa Stato-mafia nel racconto di un infiltrato: torna in libreria “Il patto” di Biondo e Ranucci. L’estratto della nuova edizione

Pubblichiamo un brano dal nuovo saggio introduttivo firmato dal vicedirettore di Rai 3 e conduttore di Report: la nuova edizione del libro, che racconta la storia dell'infiltrato di Cosa Nostra Luigi Ilardo, arriva a trent’anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio e a pochi mesi dalla deposizione delle motivazioni della sentenza di appello del processo Stato-mafia (assolti i vertici del Ros e assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri, condannati invece in primo grado)
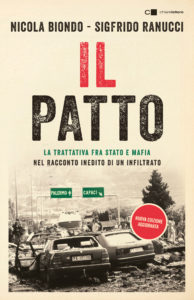
—-
Un disegno ignobile
Questo libro racconta la storia della clamorosa infiltrazione di Luigi Ilardo, nome in codice «Oriente», ex capo di un potente e strategico clan, quello della provincia di Caltanissetta, e cugino di Giuseppe «Piddu» Madonia, boss della commissione regionale di Cosa nostra. Un’infiltrazione, dunque, di primo livello la sua.
Ilardo era ben informato sulle dinamiche interne alla mafia e, nel 1993, è stato il primo boss della storia a infiltrarsi dentro la sua stessa organizzazione criminale, rivelando l’esistenza di una trattativa con lo Stato proprio mentre questa si andava svolgendo. Siamo nei primi anni Novanta del secolo scorso, anni drammatici per il paese travolto dalle stragi e da Tangentopoli, e sembra di leggere la sceneggiatura di un film, ma è tutto vero. Il racconto dell’infiltrato Ilardo fa toccare con mano il disegno ignobile del patto di cui tanto si è scritto e parlato in questi anni.
Sulla trattativa Stato-mafia sono stati istruiti due processi, di primo e secondo grado, e si sono susseguite condanne, assoluzioni e sentenze con motivazioni rivoluzionarie. La pubblicazione delle motivazioni della sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Palermo, nell’agosto del 2022, consente di leggere una verità giudiziaria e una storica sulla vicenda del patto. Gli allora vertici del Ros dei carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno sono stati assolti dal reato di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato «perché il fatto non costituisce reato»; assolto anche l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri «per non aver commesso il fatto». Confermate invece le condanne per gli uomini di Cosa nostra: ventisette anni per il boss corleonese Leoluca Bagarella e dodici anni per il medico-boss Antonino Cinà.
Tuttavia, dalle motivazioni della sentenza, emerge chiaramente che i carabinieri del Ros avrebbero «protetto» il capo di Cosa nostra Bernardo Provenzano, favorendo la sua latitanza «in modo soft».
Un dato clamoroso.
Al di là del ricorso in Cassazione presentato dalla Procura generale nell’ottobre del 2022, tra le pieghe della sentenza di assoluzione si nascondono elementi rimasti estranei all’opinione pubblica su ciò che accadde negli anni più caldi della storia repubblicana.
Emerge prima di tutto che una trattativa Stato-mafia c’è stata e ha avuto una data di inizio. Fu avviata nell’estate del 1992, dopo la morte di Salvo Lima e di Giovanni Falcone, quando i carabinieri del Ros «allacciarono» l’allora capo di Cosa nostra Totò Riina tramite l’ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, politico democristiano corleonese e mafioso, «con il dichiarato intendimento» – scrivono i giudici nelle motivazioni – «di dialogare con i vertici mafiosi, finalizzato a superare la contrapposizione frontale con lo Stato che i detti vertici mafiosi avevano deciso dopo l’esito del maxiprocesso e che era culminata già, in quel momento, con la gravissima strage di Capaci». Un invito che venne accettato da Riina. Il padrino corleonese rispose presentando allo Stato il «papello» di richieste, tra cui la cancellazione del 41-bis, la riforma della legge sui pentiti e la chiusura delle supercarceri, dettando così le sue condizioni per la «pace».
Per la Corte d’assise d’appello di Palermo, a differenza di quanto stabilito in primo grado, i carabinieri posero in essere quelle condotte per «la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale e di tutela di un interesse generale – e fondamentale – dello Stato»: il loro obiettivo, secondo la Corte, sarebbe dunque stato quello di fermare le stragi, ma i giudici non si esimono dal definire «improvvida» quell’iniziativa.
Si trattava di un contesto in cui Cosa nostra era divisa in due, poiché non tutti condividevano la strategia stragista: alla fazione più violenta, che era diretta dallo stesso Riina e vedeva tra le proprie fila boss del calibro di Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro, Giovanni Brusca e i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, si contrapponeva infatti l’ala «moderata» dell’organizzazione, contraria al disegno stragista, che trovava in Provenzano la sua voce più autorevole.
La trattativa proseguì anche dopo il gennaio del ’93, quando Totò Riina fu catturato dagli stessi carabinieri del Ros. Dopo il suo arresto, una vicenda clamorosa è stata al centro di un processo terminato con le assoluzioni dell’ex comandante del Ros Mario Mori e di Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, «perché il fatto non costituisce reato». Nella circostanza, i carabinieri avrebbero convinto la Procura a non predisporre l’irruzione nel covo di via Bernini dove si rifugiava Riina. Inoltre, deviando dalle direttive dei magistrati, gli uomini del Ros decisero di disattivare la sorveglianza dello stabile il giorno stesso della cattura del Capo dei capi. Secondo i giudici della Corte d’assise d’appello al processo sulla trattativa Stato-mafia, le «sconcertanti omissioni» che caratterizzarono quell’arresto furono dovute al fatto che i carabinieri volevano «lanciare il segnale di buona volontà e di disponibilità a proseguire sulla via del dialogo alla fazione “moderata” capeggiata da Provenzano». Sempre secondo la Corte, «il disegno» del Ros era «quello di insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente all’interno di Cosa nostra e fare leva sulle tensioni e i contrasti che covavano dietro l’apparente monolitismo dell’egemonia corleonese, per sovvertire gli assetti di potere interni all’organizzazione criminale, assicurando alle patrie galere i boss più pericolosi e favorendo indirettamente lo schieramento che, per quanto sempre criminale, appariva, ed era, meno pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’incolumità della collettività rispetto a quello artefice della linea stragista». Insomma, l’obiettivo dei carabinieri era quello di favorire una delle due fazioni della mafia palermitana, quella guidata da Provenzano, ritenuta più incline a rimanere «fedele e ligia alla strategia della sommersione», dal momento che dava segno di optare per la cura «silenziosa» dei propri affari illegali rifiutando l’appoggio alla linea stragista. «Esclusa qualsiasi ipotesi di collusione con i mafiosi, se Mori e Subranni potevano avere interesse a preservare la libertà di Provenzano, ciò ben poteva essere motivato dal convincimento che la leadership di Provenzano, meglio di qualsiasi ipotetico e improbabile patto, avrebbe di fatto garantito contro il rischio del prevalere di pulsioni stragiste o di un ritorno alla linea dura di contrapposizione violenta allo Stato.»
Secondo quanto sancito dalla Corte, infatti, «vi erano indicibili ragioni di interesse nazionale a non sconvolgere gli equilibri di potere interni a Cosa nostra che sancivano l’egemonia di Provenzano e della sua strategia dell’invisibilità o della sommersione almeno fino a che fosse stata questa la linea imposta a tutta l’organizzazione. Un superiore interesse spingeva a essere alleati del proprio nemico per contrastare un nemico ancora più pericoloso».
Ora, fatta salva la verità giudiziaria, la domanda che ci poniamo è anzitutto questa: si può considerare corretto da un punto di vista etico che importanti esponenti delle istituzioni di un paese democratico decidano di «coabitare» con una parte di un’associazione criminale di stampo mafioso perché ritenuta «meno violenta» di un’altra? A nostro giudizio no, fu una scelta ingiustificabile dal punto di vista etico. Saremmo però degli ipocriti se ci limitassimo a fare i verginelli. La seconda domanda che dobbiamo porci allora è la seguente: il risultato di questo patto, basato sulla logica del male minore, è stato raggiunto?