Alberto Asor Rosa, l’allievo di Sapegno che voleva cambiare il mondo

Per chi si immatricolò nella facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma nei primi anni Novanta del secolo scorso Alberto Asor Rosa, scomparso ieri, era uno dei fari più luminosi. Si presentava nell’affollatissima Aula 1 e si sedeva in cattedra come fosse il Frassino del Mondo della Letteratura italiana. Asciutto sempre nell’esposizione, ogni proposizione poteva essere una definizione scultorea che aveva la presenza e la scontatezza indiscutibile delle Tavole della Legge. Il tutto condito da un filo di sarcasmo nei confronti dell’istituzione universitaria e dei disagi che noi studenti subivamo per il fatto di essere una facoltà affollata in un Ateneo immenso (il più grande d’Europa, si diceva, per vanto ma quanto svantaggio comportasse si taceva).
 La fama aveva sempre preceduto il più brillante degli allievi di Natalino Sapegno, marxista non dogmatico, uomo eminentemente politico oltre che affilatissimo lettore di testi sembrava coniugare la figura di intellettuale che molti di noi avrebbero voluto emulare (l’ingenuità dei vent’anni!). Certo, si poteva restare un po’ delusi dall’Asor Rosa degli anni Novanta, già bruciato dalla delusione storica, marchiato a fuoco dalla fine del comunismo storico (sovietico). Ma avevamo già letto la nuova prefazione ad uno dei suoi libri cardine, Scrittori e Popolo, dove si faceva una palinodia dolorosa della fine dell’utopia operaista ma dove il nucleo fondativo di quello studio rimaneva essenzialmente valido, facendo infatti leva sulla contraddizione costitutiva tra scrittori populisti e popolo vero.
La fama aveva sempre preceduto il più brillante degli allievi di Natalino Sapegno, marxista non dogmatico, uomo eminentemente politico oltre che affilatissimo lettore di testi sembrava coniugare la figura di intellettuale che molti di noi avrebbero voluto emulare (l’ingenuità dei vent’anni!). Certo, si poteva restare un po’ delusi dall’Asor Rosa degli anni Novanta, già bruciato dalla delusione storica, marchiato a fuoco dalla fine del comunismo storico (sovietico). Ma avevamo già letto la nuova prefazione ad uno dei suoi libri cardine, Scrittori e Popolo, dove si faceva una palinodia dolorosa della fine dell’utopia operaista ma dove il nucleo fondativo di quello studio rimaneva essenzialmente valido, facendo infatti leva sulla contraddizione costitutiva tra scrittori populisti e popolo vero.
Ma l’Asor Rosa che avevamo imparato ad amare non era certo quello di quegli anni di riflusso e tentativo di fermare la marea montante del neoliberismo trionfante, era quello degli anni Sessanta e Settanta quello che riusciva a riunire militanza politica agguerrita all’occhio disincantato dell’analista politico e letterario, che non si faceva incantare dalla retorica comunista e che riusciva a mettere su pagina uno scritto fondamentalmente scettico ma speranzoso sulla comunanza di fini tra l’operaio di fabbrica e il mondo della produzione culturale come è Intellettuali e classe operaia.
Ma quella stagione alla fine degli anni Settanta si chiuse definitivamente e Asor Rosa stemperò i suoi interventi politici per mettere mano ad un grande progetto culturale di cui fu direttore e coordinatore: la Letteratura Italiana per l’editore Einaudi. Opera che segna un punto di svolta negli studi lettarari del nostro Paese perché è il primo vero tentativo di confronto (con intento di superamento) dell’assetto storico fondato da Francesco De Sanctis con la sua Storia della letteratura italiana.
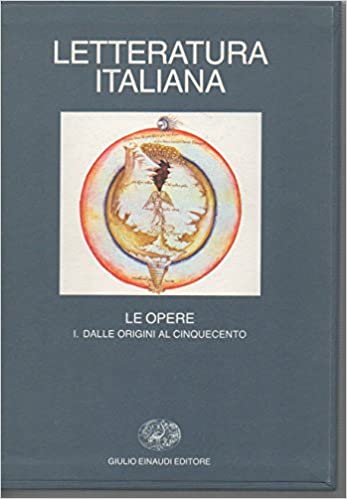
Opera enorme, la vera e propria enciclopedia letteraria quella einaudiana metteva in campo tutte le elaborazioni teoriche di decine di studiosi per far esplodere il paradigma storico e ampliarlo a ogni dimensione di campo, dalla geografia delle produzioni letterarie a quella delle forme, agli autori, alle opere. Una sapiente scomposizione che rendeva finalmente giustizia della complessità del lavorio letterario così peculiare (perché essenzialmente multicentrico ad ogni livello) del nostro Paese, parallela alla complicata stratigrafia della nostra storia politica e sociale.
Al suo attivo rimangono studi definitivi su Verga e sull’Ottocento anche minore, e la rivalutazione della letteratura controriformistica e del Seicento all’epoca secolo negletto tra gli storici italiani. Molto della produzione saggistica potrà essere caduca ma come ci ricordava T. S. Eliot non esiste nulla come il progresso nelle scienze dello spirito, ma come è normale nella storia degli studi cambieranno prospettive e modi di leggere i testi, ma alcuni capisaldi rimarranno. Ci restano i suoi libri e anche i suoi romanzi a testimoniare la passione civile di uno studioso che è stata anche cartina di tornasole di una certa parte organica della sinistra italiana, che è stata molto fertile ma che con il procedere degli anni molto ha fatto pesare la propria delusione e alla fine il proprio nichilismo.



