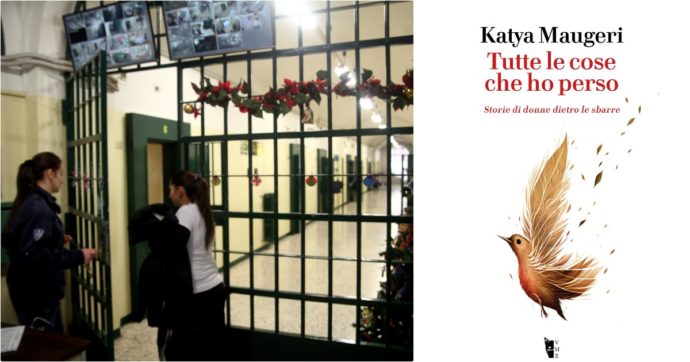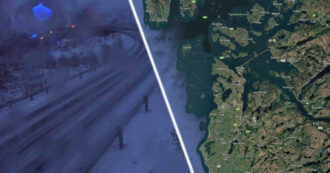Pubblichiamo un estratto del libro “Tutte le cose che ho perso. Storie di donne dietro le sbarre”, di Katya Maugeri edito da Villaggio Maori Edizioni
***
 “Il peggior rumore che si possa sentire in carcere è quello delle chiavi. Di ottone, pesanti, che tutte le mattine alle cinque e mezza e la sera alle otto senti girare per tre volte: l’ho sentito per troppo tempo. Resta l’eco in fondo al cuore e la tua testa sembra non voler più accettare nessun suono che solo possa assomigliarli.
“Il peggior rumore che si possa sentire in carcere è quello delle chiavi. Di ottone, pesanti, che tutte le mattine alle cinque e mezza e la sera alle otto senti girare per tre volte: l’ho sentito per troppo tempo. Resta l’eco in fondo al cuore e la tua testa sembra non voler più accettare nessun suono che solo possa assomigliarli.
“Dopo tanti anni trascorsi a sentire quei rumori, a respirare odori marci, vivo la mia casa ai domiciliari, con un pappagallo al quale dedicare ogni attenzione. Sarò diventata matta, chissà! Lo dovrebbero raccontare tutti che tra quelle mura il tempo smette di esistere: tornano solo gli sbagli – la notte – a prenderti a schiaffi. E che dolore! Lo stesso che ho procurato alle persone che ho amato. Una sorta di legge del contrappasso.
“Mia madre non si è mai presa cura di me, mai. Era impegnata con i suoi traffici illegali, così all’età di cinque anni vengo trasferita in un istituto. Dai cinque ai tredici anni, fino a quando mia nonna decide di portarmi con sé. Molto meglio la galera. Peggio, molto peggio di qualunque altra reclusione, vivere con mia nonna intendo. Non ricordo molto di quegli anni, solo la sua rigidità e le attenzioni ‘eccessivamente‘ affettuose di mio zio. Poi la morte di mia madre. A quel punto, in preda a un dolore lacerante, anche se in realtà io ho sempre vissuto senza di lei, tento il suicidio. Sopravvivo. In quel periodo inizia la mia dipendenza alla cocaina. L’ho iniziata troppo presto, avevo tredici anni: spacciavo la sera e il giorno studiavo e mi “facevo”. Ero brillante, nessuno avrebbe mai potuto attaccarmi. Mi sentivo invincibile, perfetta, con una vita davanti. Volevo però liberarmi dall’ombra di mio zio, dalla cattiveria di mia nonna: il matrimonio sembrava – ai tempi – l’unica via di liberazione. E invece libera, io così bella e con mille sogni da realizzare, non ci sono stata mai. Sono stata libera di scegliere, quello sì. Ma ho scelto la mia fine da subito. Una vita da tossica.
“La cocaina è nella testa, sta là e chi te la toglie più? Quell’adrenalina effimera che credi di poter gestire e invece è solo lei: una dama perfida che si insinua nei tuoi pensieri fino ad annientare tutto il resto. Diventa la priorità e tutto il resto è solo un contorno offuscato dai confini non definiti. Dove iniziavo io e dove finiva lei? Era in me come un amante che vuole sempre di più, insaziabile lei di me e io di lei. Un rapporto esclusivo che non potevo condividere con nessuno. Ero sola, con addosso troppe sconfitte per aver solo tredici anni: eppure lei – la sostanza – c’era tutte le volte che il mio corpo e la mia mente ne avevano bisogno. Lei non mi tradiva, lei mi faceva stare bene, mi soddisfaceva, cancellava seppure momentaneamente i brutti ricordi e le mie insicurezze, mi regalava attimi di eternità. La cocaina non mi aveva mai deluso: tanto compravo e tanto avevo.
“Non ero mai lucida. Non ero lucida nemmeno a casa quando mio figlio giocava, studiava. Io mi rinchiudevo in camera da letto e mi concedevo a ‘lei’. La dipendenza è una bestia feroce che si appropria del pensiero, della volontà, dell’autostima, del voler fare. Senza, mi sentivo nulla, priva di ogni forza. E, in primis, non riuscivo a fare la mamma: trascuravo i miei ruoli principali. Evitavo di accompagnare mio figlio a scuola, ai campi sportivi, volevo solo stare in camera mia. Un giorno però distrattamente la porta restò aperta e mio figlio vide tutto. La sua mamma si drogava. Invece di giocare con lui, di andare al parco con la bici, sua madre tirava cocaina. La mia condanna è iniziata in quel preciso istante. Sotto l’effetto della sostanza mi sembrava di essere abitata da un avatar, ero una spettatrice di una vita che non sentivo mia: la mia laurea, i miei sogni, le mie potenzialità diventate polvere. Una polvere bianca che mi stava uccidendo.
“Anche se adesso vivo in casa, la mia anima sembra rinchiusa ancora lì in quella cella. Non chiudo nulla a chiave, nemmeno la porta di casa. Non metto mai chiavi vicine per evitarne il contatto, quindi il rumore. Non sopporto le porte chiuse, puoi anche uscire da quelle celle ma è un ‘fuori‘ che ti fa sentire ancora sbagliata, in difetto, fuori luogo. Fuori dai canoni stabiliti.
“Il carcere è un universo parallelo, una realtà intrisa di pensieri disordinati, confusi, dove la stessa identità personale rischia di perdersi. Ho incontrato donne che, pur mantenendo legami con i propri figli all’esterno, hanno difficoltà a esercitare il ruolo di madre, hanno paura di essere dimenticate, di essere considerate come ‘coloro che hanno abbandonato il figlio’; spesso hanno difficoltà anche a mantenere un rapporto normale con lui, sia visivo sia epistolare. Anche perché gli incontri e le telefonate vengono ostacolati dalla rabbia, dal rancore. Un figlio che vede una madre drogarsi è travolto da uno smarrimento che lo conduce ovunque, ma certamente non tra le sue braccia. È una condanna dalla quale non potrò mai liberarmi.