The White paper di Satoshi Nakamoto, Timeo riporta in libreria l’inventore del Bitcoin con la postfazione del gruppo di ricerca Ippolita

Pubblichiamo “fuori dall’idios kosmos”, postfazione del gruppo di ricerca Ippolita all’edizione italiana di “The white paper” di Satoshi Nakamoto (a cura di Timeo edizioni). “Il libro bianco” è uscito nel 2008 e ha ridefinito il concetto di valore, di moneta di scambio e di sovranità, e ha consegnato al mondo una tecnologia che potrà avere moltissime altre applicazioni. Il registro pubblico, la blockchain, i blocchi di validazione: tutti concetti che fino alla pubblicazione di questo testo fondamentale non esistevano e oggi sono entrati non solo nel lessico pubblico, ma anche nella quotidianità di tutti. Un testo ancora troppo poco studiato nel suo vero funzionamento tecnico e che contiene in sé il germe del mondo a venire: a noi comprendere se si tratta di uno strumento di emancipazione o lo spettro della distopia futura.
Nell’epoca della piena automazione, l’esercizio del pensiero critico è la virtù suprema. Non credete a quanti, con discorsi fumosi il cui solo obiettivo è ergersi sopra lx altrx e guadagnare qualche frammento di narcisistica notorietà, vi dissuadono da una analisi libera e rigorosa, dicendovi che non avete capito, che i tempi sono cambiati, che l’indagine razionale è una cosa da folk politics, che la teoria è inutile e la politica superflua. Non credetegli. Nove volte su dieci è un tentativo maldestro di chi per convenienza si è fin troppo compromesso con l’oggetto della propria argomentazione.
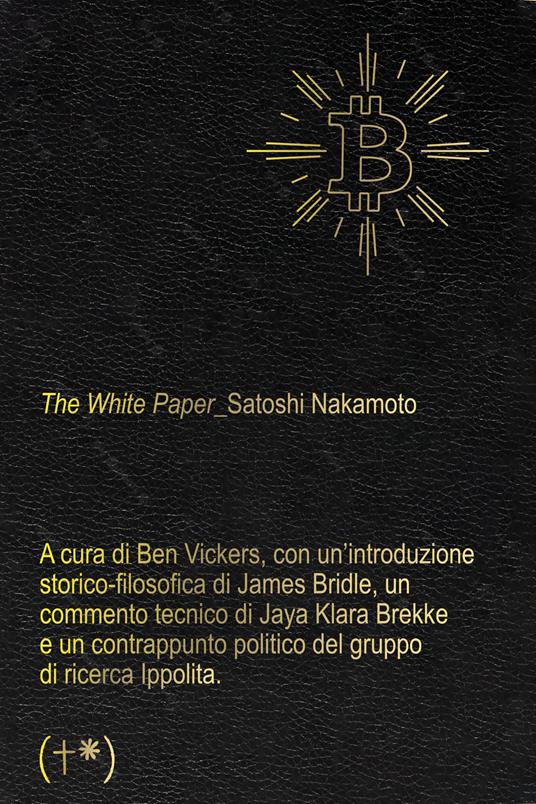 Il Bitcoin è, a volerlo osservare con occhio benevolo, la dimostrazione dell’idiozia. In senso letterale, idios kosmos: la storia di piccoli uomini, chiusi nel loro orticello privato interiore e incapaci di comprendere la complessità che li circonda. Perché? Perché «non si possono risolvere problemi politici con la crittografia», come dice un anonimo in uno dei primi commenti sulla Cryptography Mailing List all’annuncio che presentava il sistema Bitcoin. E rifugiarsi in un’architettura decentralizzata pensando che questa sia sufficiente a innescare un qualche cambiamento positivo o è un’imperdonabile ingenuità o è malafede. Sì, perché il fatto che una soluzione a un problema tecnico-informatico sia elegante e brillante non vuol dire necessariamente che sia una buona idea a livello sociale, economico, ecologico. Triste ma vero. Il metodo non basta. Non è mai bastato.
Il Bitcoin è, a volerlo osservare con occhio benevolo, la dimostrazione dell’idiozia. In senso letterale, idios kosmos: la storia di piccoli uomini, chiusi nel loro orticello privato interiore e incapaci di comprendere la complessità che li circonda. Perché? Perché «non si possono risolvere problemi politici con la crittografia», come dice un anonimo in uno dei primi commenti sulla Cryptography Mailing List all’annuncio che presentava il sistema Bitcoin. E rifugiarsi in un’architettura decentralizzata pensando che questa sia sufficiente a innescare un qualche cambiamento positivo o è un’imperdonabile ingenuità o è malafede. Sì, perché il fatto che una soluzione a un problema tecnico-informatico sia elegante e brillante non vuol dire necessariamente che sia una buona idea a livello sociale, economico, ecologico. Triste ma vero. Il metodo non basta. Non è mai bastato.
Il caso Bitcoin è emblematico: peer-to-peer, open source, decentralizzato, distribuito, disintermediato, crittografato. Spacciato per un nuovo tipo di moneta (digitale) in grado di fare a meno di banche, stati e istituzioni ma diventato ben presto solo un asset finanziario come tanti (ma forse più rischioso di altri), utile al più per fare speculazione. Teoricamente orizzontale ma inavvicinabile senza una preparazione tecnica adeguata. Estremamente oneroso da produrre/minare, sia in termini energetici che di risorse computazionali. E, per questi motivi, diventato nel giro di pochi anni un sistema pieno di attori e servizi che mediano l’esperienza dell’utente comune. Anche la blockchain non ne è uscita benissimo; salutata come una tecnologia innovativa, ci si è accorti che ha bisogno di essere riprogettata nel suo cuore perché la proof-of-work non è del tutto priva di problemi, troppo energivora e animata da una logica agonistica e competitiva forse un po’ inutile. Diciamolo pure, la proof-of-work è pura volontà di potenza informatica. Per questo sono stati studiati ed esistono altri modelli operativi che garantiscano risultati simili alla proof-of-work ma senza tutte le esternalità negative che si porta dietro. Quella che va per la maggiore ultimamente è la proof-of-stake. Tornando alla blockchain, forse l’applicazione migliore trovata finora è quella per gestire le merci del porto di Rotterdam.
Insomma, il metodo non basta. Prendendo per buoni i proclami retorici e ideologici che accompagnano la nascita di Bitcoin si cade in un soluzionismo tecnico che si rivela o un atto sconsiderato di presunzione o un’ingenuità o un imbroglio.
Nella lettura del libro bianco di Nakamoto e dei suoi apparati sono molti gli elementi che sorprendono proprio per questo mix fatale di ingenuità e arroganza. Per esempio colpisce la risposta di Satoshi al post di un utente che su Bitcointalk solleva qualche dubbio sull’efficienza energetica di Bitcoin: «L’estrazione dell’oro è uno spreco ma lo spreco è di gran lunga inferiore all’utilità di poter disporre dell’oro come mezzo di scambio». Questa sarebbe l’argomentazione principale. In un secondo momento aggiunge: «Il calore del tuo computer non è sprecato se devi scaldare casa. Se, dove vivi, hai un sistema di riscaldamento elettrico il calore del tuo computer non è uno spreco […]. Alla fine, si dovrebbe generare bitcoin dove costa di meno. Magari in qualche posto freddo in cui si usa il riscaldamento elettrico, dove la produzione sarebbe sostanzialmente gratuita». Riassumendo, sembra dire: non è importante se si spreca energia e si inquina, l’importante è ottenere l’utile (il valore economico). Fine. Anche in questo caso non pare dimostrare una grande consapevolezza sul tema. Forse non gli interessa molto.
Anche tutta la discussione se proporre Bitcoin a Wikileaks come soluzione al congelamento dei loro fondi (2010) è a dir poco paradossale e il tono della discussione e gli argomenti usati sono miserabili. Che tipo di umanità ne viene fuori? Che valori etici vengono messi in gioco e usati per prendere decisioni?
Gli assi portanti a livello ideologico, oltre alla favolistica idea di trovare un sistema per fare soldi dal nulla, sembrano essere nient’altro che la crittografia, l’eliminazione del ruolo delle banche e delle istituzioni statali e una soluzione tecnica per prevenire la doppia spesa. Gli aspetti più nobili e decantati, ossia quelli relativi al fatto di essere un sistema peer-to-peer, decentralizzato e open source sono semplicemente il miglior sistema per ottenere quel risultato, in quanto risolvono tutta una serie di problemi tecnici: un dettaglio accessorio e non l’obiettivo del progetto. O almeno, questo è quello che se ne deduce compiendo una lettura ermeneutica del white paper, dei commenti riportati e analizzando il principale ambiente culturale da cui si è sviluppato il progetto, ossia il milieu cypherpunk e la sua mailing list, lo spazio online storicamente più importante per quanto riguarda l’elaborazione del valore della crittografia e della nascita delle criptovalute.
Se si riprendono alcuni documenti fondativi come A Cypherpunk’s Manifesto di Eric Hughes, e ancor di più The Crypto Anarchist Manifesto e «Cyphernomicon» di Timothy C. May, se ne possono dedurre abbastanza agevolmente l’area politica e l’immaginario sociale.
La proprietà privata è descritta come un bene essenziale e inviolabile. La sacralizzazione della privacy e il ricorso alla crittografia, quale migliore strumento per schermarsi da qualsivoglia intrusione, hanno come obiettivo generale quello di garantire l’intoccabilità proprio della proprietà privata. Numerose occorrenze di questo tipo sono poi accompagnate da vaghi appelli contro i poteri istituiti, soprattutto contro le tasse, e a favore di un mercato senza attriti. Qualunque idea di organizzazione sociale o di giustizia sociale è del tutto assente. Una assenza, questa, che si può rinvenire anche nel white paper e negli altri materiali che lo accompagnano. Oltre a un primo livello di discussione tecnico-informatica, con qualche spruzzatina qua e là di economia generale, abbaglia la mancanza di qualsiasi riflessione sulla distribuzione della ricchezza prodotta. Come dire: puro libertarianesimo e triste realismo anarco-capitalista.
Detto in modo ancora più chiaro: privacy e crittografia non possono agire in nessun modo per risolvere problemi politici perché non sono gli strumenti migliori per farlo. Ma allora da dove viene questo reiterato appello a considerarle «armi» (sic) per conquistare nuovi spazi di libertà? Come si forma questa miscela tossica di istanze apparentemente libertarie e ultracapitalismo?
Riassumendo, tra gli anni Novanta del ventesimo secolo e i primi anni Zero si viene elaborando in modo un po’ confuso una forma di libertarianesimo, ossia di anarco-capitalismo, che trova nel digitale un ambiente fertile dove prosperare e dare vita a un’ideologia utopistica di destra, appropriandosi di tutta una serie di parole d’ordine, modalità e attitudini proprie del mondo digitale del periodo, composto da nerd e geek di diverso orientamento politico.
Ma andiamo con ordine.
Quando parliamo di anarco-capitalismo non intendiamo solo, in senso stretto, la dottrina politica di pensatori come Murray N. Rothbard, per il quale anarchismo e capitalismo sarebbero sinonimi: una posizione individualista che vede nel libero mercato la massima espressione di libertà possibile, in quanto frutto della libera azione di soggetti mossi dal proprio interesse privato di accumulo e fruizione. Intendiamo anche in generale tutte quelle posizioni e proposte che, esplicitamente o meno, esprimono una ideologia riconoscibile come libertarianesimo. Questa dottrina economico-politica è una variante del liberalismo che porta alle estreme conseguenze l’idea di una libertà concepita come assenza di restrizioni rispetto all’esercizio del diritto di proprietà, e sostiene la possibilità di una società capitalista in cui lo stato sarebbe inesistente o ridotto a una forma minimale, in quanto istituzione che limita la libertà individuale. Una teoria che non si deve confondere con le idee e le pratiche libertarie o anarchiche, così come sono intese tradizionalmente in Europa ma non solo. In queste ultime, infatti, la critica della proprietà privata e del modo di produzione capitalista si saldano con la lotta a ogni forma di dominio e sfruttamento. Il libertarianesimo invece è profondamente filocapitalista e non mette in discussione in alcun modo il principio dell’autorità, se non in maniera strumentale. In ambito economico, il riferimento principale è la Scuola economica austriaca, e le sue figure di spicco: Ludwig von Mises e Friedrich August von Hayek, ma anche Murray N. Rothbard, con il suo approccio incentrato sullo studio dei meccanismi logici dell’azione umana per dare consistenza al principio del laissez-faire liberale.
A questo punto si potrebbe pensare, per via della sua insistenza sulla proprietà, che il libertarianesimo tenda a difendere la proprietà intellettuale, ma non è così; anzi, una parte considerevole di libertariani sposa appieno la causa dell’open source o persino del software libero. Con una differenza, però: quando i libertariani attaccano con veemenza il sistema dei brevetti o il copyright non lo fanno per denunciare l’iniquità del mercato, ma per rimarcare quanto siano dannosi per la libera concorrenza. Tutta la forza del pensiero libertariano proviene dallo stupefacente paradosso su cui si fonda: predica un insieme di trasformazioni radicali che si dicono rivoluzionarie, ma sostiene al tempo stesso l’ordine del mondo. Forse il motivo del suo successo si nasconde proprio qui: aver fornito a tutti coloro che vivevano nella dimensione del realismo capitalista una nuova sfolgorante utopia, seppur reazionaria e conservatrice.
Nel corso del tempo, queste idee si sono mischiate mimeticamente con concezioni anticapitaliste e libertarie nel milieu delle controculture legate all’informatica fino al punto di renderle quasi del tutto indistinguibili.
Per questo è importante avere anche solo una vaga idea delle tesi libertariane, perché ci permette di riconoscerle e di intravvedere dove ci stanno portando: in un mondo in cui le questioni etiche suonano inutili, al capitalismo non c’è alternativa e la proprietà privata non si discute. Purtroppo tra i tanti che, ipoteticamente in buona fede, hanno contribuito all’elaborazione del Bitcoin o hanno dato spazio a questa tecnologia spacciandola come rivoluzionaria e positiva, sicuramente c’erano anche molti che non sono stati in grado di cogliere l’impostazione anarco-capitalista di cyber-libertariani alla Electronic Frontier Foundation, di seguaci della pensatrice Ayn Rand, di sostenitori di Peter Thiel, epigoni di Tim O’Reilly, accoliti di Eric S. Raymond, transumanisti e cripto-anarchici.
Di fatto la saldatura tra questi immaginari quanto mai ambigui e alcune delle punte più avanzate degli ambienti culturali legati alla crittografia avviene nei contesti come quello della già citata mailing list Cypherpunks. La crittografia sembra agire come contropotere perché salvaguardia i singoli dai poteri forti e dallo stato, ma è del tutto priva di qualunque istanza socialista. Inoltre, perché affidarsi esclusivamente ad essa? Cosa garantisce oltre alla sua stessa procedura tecnica? Se vogliamo aumentare il nostro grado di autonomia non faremmo meglio a lavorare sulle nostre reti sociali, sui gruppi di affinità, o anche sulla costruzione di comunità e sindacati di base? Certo costa impegno, ma così si dà vita a vero contropotere, con l’auto-organizzazione, il mutualismo. Anche la retorica della disintermediazione andrebbe osservata meglio. Se l’organizzazione di base viene sostituita da un insieme di procedure tecniche il tessuto sociale si arricchisce (di esperienze, di opportunità, di capacità) o si impoverisce?
Quando infine la crittografia incontra gli esperimenti sulle monete digitali, insieme alle criptomoneta Bitcoin, nascono anche tutta una serie di nuove affabulazioni su questa forma di sapere-potere specialistica. Ma al di là delle specifiche narrazioni salvifiche, l’utilità di questa tecnologia sembra essere soprattutto quella di sostenere la proprietà privata senza la garanzia dello stato e altre istituzioni. Organizzare la società senza un’autorità centrale tuttavia ha senso solo se siamo in grado di avviare un processo di formazione personale e sociale/comunitario, un processo al tempo stesso culturale, etico ed estetico.
L’esaltazione per le criptovalute quale possibile soluzione all’impoverimento diffuso è esagerata, ormai lo hanno capito anche i tombini. Soprattutto, svia dal problema: lo sfruttamento, le dinamiche di potere, la disuguaglianza sociale.
Pensare che i nostri problemi possano essere gestiti e risolti da una tecnologia informatica, vuol dire essere degli ingenui che sottovalutano il potere dei grandi capitali di avvantaggiarsi di qualunque avanzamento tecnologico. Vuol dire affidarsi a strumenti di gestione tecno-politica, orientati alla tecnocrazia, senza capire che la vita politica è l’esercizio stesso su cui si basa ogni autonomia e ogni autogestione. Vuole anche dire non aver compreso che i rapporti tra pari si basano sulla costruzione della fiducia reciproca, il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie e altrui differenze. Infine, vuol dire ignorare che il dominio del capitale si esercita come violenza epistemica quando il codice ideologico e il codice informatico sono tra loro connessi. Appena si gratta la superficie delle parole usate dagli entusiasti della crittografia emerge tutta la retorica anarco-capitalista.1
Abbiamo scritto diverse cose, in passato, sulle criptovalute e sulla blockchain in generale, molte sono riassunte nel nostro libro Tecnologie del dominio(1), al quale ci permettiamo di rimandare chi volesse saperne di più. In questa sede, invece, vorremmo dire ancora due parole sul suprematismo nerd e il soluzionismo tecnico.
L’idea che la soluzione a problemi complessi sia dietro l’angolo e sia di natura tecnica è intimamente connessa con l’opinione diffusa che di se stessi hanno coloro che detengono quella particolare forma di sapere-potere che è l’informatica, la scrittura di codice e, in questo ambito, la crittografia (non tuttx, eh!). Come già abbiamo detto altrove il problema non è la crittografia di per sé ma l’uso di una tecnologia pesante, che si sostituisce interamente alla riflessione culturale sulla fiducia, sull’etica delle soglie ed esclude altre forme di apprendimento non derivate dalla tecnica. L’idea che la crittografia sia la panacea è una forma di suprematismo nerd in cui il soggetto della rivoluzione digitale è l’hacker come eroe reazionario. Nessuna idea di giustizia sociale; solo una primula rossa che usa il proprio potere tecnico a vantaggio della propria élite.
La figura di chi scrive codice è ormai idealizzata, ma proprio per questo ci sembra avere senso iniziare a interrogarsi criticamente su questa pratica. Facciamo una prima osservazione. Per sommi capi, cosa succede quando si scrive codice? Che tipo di scrittura è? Possiamo essere tutti d’accordo nell’affermare che è una scrittura fortemente astratta, composta di istruzioni e funzioni, un esito straordinario della scrittura alfanumerica. Effettiva realizzazione della scrittura fattuale, la pratica del coding esprime pura potenza programmatica. Possiamo dire che è normativa, istituente, performativa? Forse sì, dopotutto la scrittura di codice è normativa tanto quanto la scrittura delle leggi dello stato. Il codice è legge, la legge è codice (non si diceva così una volta?). Lo è perché è un tipo di scrittura che si trasforma in realtà e incide nella vita delle persone. Detto altrimenti: un progetto diventa un programma grazie a una scrittura forte della propria eseguibilità.
Da questo punto di vista l’uomo politico e il tecnico informatico agiscono un potere analogo. Come il tecnico scrive il codice e con questa azione si rapporta alla macchina per farle svolgere un compito, così il legislatore, scrivendo un articolo di legge, si relaziona alla macchina burocratico-amministrativa. L’importante è seguire la procedura, passaggio dopo passaggio.
La macchina burocratica è come un compilatore, cioè il programma che si usa per «compilare il codice» e renderlo eseguibile dal computer. Entrambe queste pratiche di scrittura producono effetti sugli ambienti nei quali agiscono, e quindi sulla vita delle persone.
È qui, per effetto di questa potenza sotto (presunto) controllo, che il tecnico può subire una trasformazione e diventare un suprematista nerd. Subisce cioè la tentazione eterodirezionale. Consapevole o inconsapevole che sia, in buona o in cattiva fede, è chiamato a fare i conti con l’esercizio del potere (il suo).
Assistiamo a una parziale sovrapposizione di due figure apparentemente distinte ma non così diverse: il legislatore e l’hacker. Ma ci sono anche altre figure che si potrebbero affiancare a queste, estremamente prossima è, per esempio, quella del giudice e, a un altro grado di separazione, quella del medico o del manager.
Riconoscere il potere eterodirezionale della scrittura di codice non vuol certo dire rifiutarla, ma diventa indispensabile per cercare di comprendere una delle componenti fondamentali dell’ideologia tecnocratica del suprematismo nerd.
L’osservazione che qui abbiamo solo abbozzato potrebbe rivelarsi centrale per rendere possibile un’operazione ambiziosa: osare il codice, ossia usarlo a fini comunitari, non commerciali, secondo i propri bisogni.
Il passaggio ancora una volta è politico prima che informatico. Questo non è un appello alla semplice politicizzazione del coding, l’urgenza è semmai evitare la codificazione della vita. È una questione etica: con quale intenzione, obiettivo e interesse si mette in comunicazione il codice con il suo «fuori», ossia con il suo uso? E da quale posizionamento si fa codice? È con queste domande che il suprematismo nerd viene chiamato a interrogarsi sul proprio ethos, perché viene messo in relazione con altro da sé. Figurativamente, è un invito a trasformare il codice in un flusso, perché un flusso è sempre qualcosa che passa e che attraversa, un appello a uscire da sé (fuori dall’idios kosmos), rompendo il cerchio narcisistico del proprio ambito disciplinare, per relazionarsi con altre pratiche, altri saperi e altre forme, ossia con la vita in comune.
1. Ippolita, Tecnologie del dominio. Lessico minimo di autodifesa digitale, Meltemi 2017.

