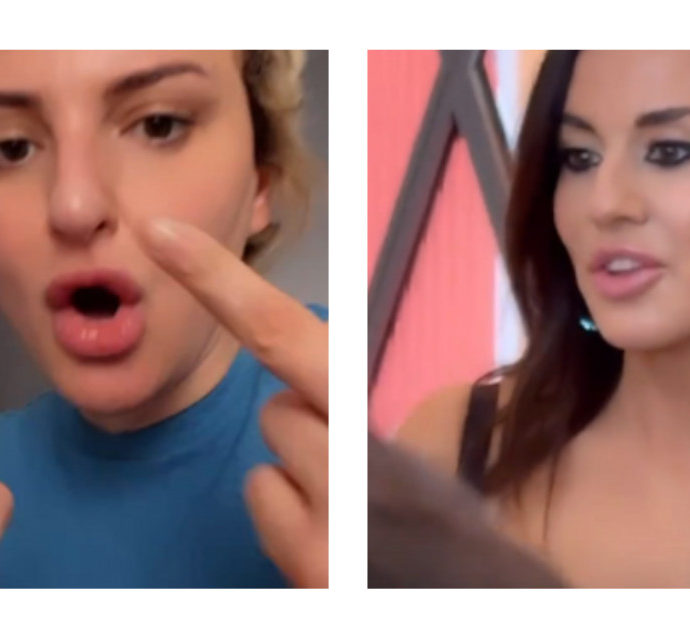“Andiamo al Cocco?!?”. Sarebbe bello iniziare il pezzo su Cocoricò Tapes, il documentario sulla celebre discoteca romagnola in anteprima al 59esimo Pesaro Film Festival, con questa richiesta vagamente vitelloniana. Il Cocoricò come il Rex felliniano che passa lontano nel mare dell’immaginario ogni sabato sera. Un’allegoria inafferrabile della trasgressione adolescenziale anni novanta che si staglia come conditio sine qua non di un irriducibile esistenzialismo dance techno. E i “tapes”, i nastri, i materiali d’epoca pubblici (Rete7, Teleromagna, Tg2, MatchMusic) e privati (i filmini con la data sottile in basso a sinistra) sono la materia, il senso, i lampi, con cui sono fatti i sogni e le nostalgie del passato.

Ma che cos’era il Cocco con quella sua “piramide”, antro delle energie ultraterrene, oltre l’infausta memorabilia degli incidenti del sabato notte? Trasgressione? Euforia? Sballo? O ancora: performance, teatro, installazione, travestimento? Scorrono rapide, per chi non le ricordasse, le iconografie e le scenografie del Cocoricò tra fotogrammi fissi e in movimento: tizi crocifissi, animali cattelaniani in mezzo o sospesi sul tetto delle tre piste da ballo, un cannone con sacchi di sabbia, un furetto a guinzaglio, accenni di burlesco sadomaso, la saletta con erba vera dove si entra scalzi e si beve acqua minerale.
Un frullare di idee disorganico, di scritte al neon, di parrucche colorate, di piercing, di minigonne, di giacche con le spalline. Cocoricò Tapes non è un film o un documentario, ma un mash up visivo e visionario alla ricerca di un senso esperienziale che probabilmente, oltre la spontaneità e l’audacia del momento, non esiste. Ma è proprio in questo raccapezzarsi del ricordo che il doc di Francesco Tavella prende forma, spazio, suono, anima, direzione narrativa in loop.
Intanto la dance di allora che sembrava orribile oggi lo sembra molto meno. Sarà che ci tocca ogni nefandezza hip hop in salsa qualunque, ma quegli “svalvolati ma veri”, quella dimensione “eversiva ma di qualità” anni novanta appaiono come punti stranamente saldi di uno dei decenni più bui e svuotati di valori che la storia dell’occidente ricordi. Il riflusso durante la settimana, il divertimento al sabato sera. Venivano da ogni dove per andare al Cocco: Genova, Roma, dalle lande anglosassoni. Il parcheggio invaso dalle macchine (quante Fiat Uno, santo dio) tutte ordinatamente in fila, le figurine dei calciatori, i videogame dentro la sala giochi, Franco Battiato nel privè, Enrico Ghezzi che mixa dischi, Grace Jones che esce a spalla dopo gli eccessi alcolici, il principe Maurice che defeca con le mutande calate su un cesso nero ai lati di una pista. E intanto sopra ad un ammasso di tv di oggi scorre la vocetta di Loris Ricciardi, art director, qualche chilo di droghe e un aneurisma in meno. “C’era un’armonia strutturale ma è stato il pubblico a fare quel posto”, dice lui. Cinquemila persone, un rito collettivo, una generazione e il suo luogo di elezione. Come eravamo discotecomani, come non lo siamo più adesso. Cocoricò Tapes val bene una messa nel Cocco sconsacrato. E fatecelo dire: ma quanto erano belle le ragazze di Match Music?