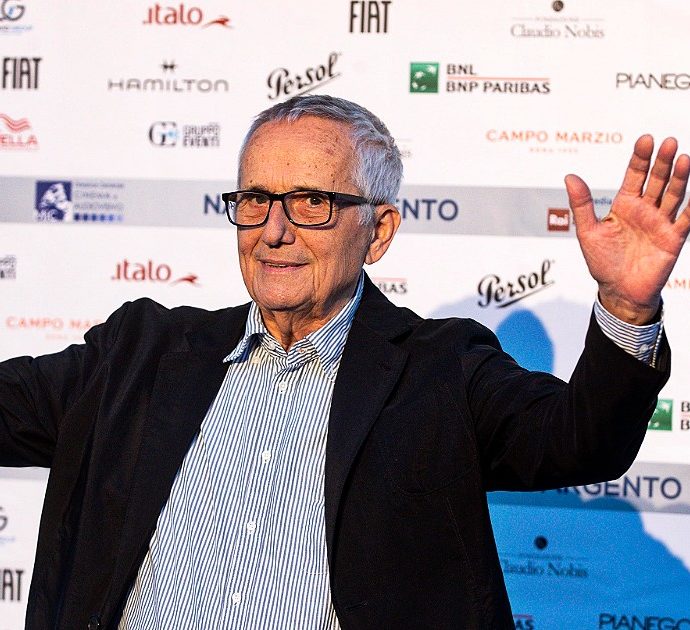Jerry Lee e i suoi cugini. Un paio di sequenze di Jerry Lee Lewis: Trouble in mind, film di chiusura del 19esimo Biografilm festival di Bologna, poteva averle girate Luchino Visconti. Anche se l’autore sublime del documentario si chiama nientemeno che Ethan Coen (Joel, da solo, si era dedicato a Macbeth, ça va sans dire) e tra i produttori sbuca pure Mick Jagger, la suggestione del parentado lewisiano è immediata e ballabile ad oltranza.
L’indimenticabile “the Killer”, morto ad 87 anni lo scorso ottobre, quello che suonava il pianoforte come elettrizzato da una corrente continua, rifilava pedate alla tastiera e ci si sedeva sopra, aveva due cugini che suonavano a loro volta il pianoforte. Roba da non crederci. Tralasciamo il predicatore Jimmy Swaggart, cugino di secondo grado, pianista ovviamente, che vediamo lanciare anatemi sotto un paio di occhialoni da sole marziani. Quando a metà documentario nel filmato di un live tv con Jerry Lee appare di fianco al piano il cugino Mickey Gilley, molto country Elvis nel vestire, sembra di ascoltare lo stesso musicista. E dio santo come ci danno dentro insieme. Scotennano la tastiera, picchettando i tasti, aumentando vertiginosamente il ritmo.
Jerry Lee Lewis fuori controllo, incendiario showman. Le gemme pressoché inedite, e integrali, che Coen recupera dagli archivi di mezza tv americana sono una bomba all’idrogeno di boogie-woogie, rock and roll (rockabilly no grazie, dice Jerry Lee)e venature estese di country. Ma anche l’anima bianca (con Elvis) della rivoluzione dei ’50 – Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard, ecc..– a cui Lewis è sopravvissuto, almeno fino a quando il doc è finito a Cannes nel 2022.
Coen e la moglie montatrice Tricia Cooke compiono il miracolo del divertimento genuino e del pas déjà vu. Niente collezione da Youtube, ma filmati di esecuzioni live spesso piovuti dal cielo degli dei degli arrangiamenti folli. Anche perché Jerry Lee di anime musicali ne ha attraversate parecchie, senza mai rinnegare nulla del proprio passato e delle personalissime trasformazioni (“no regrets”, dice). In smoking tipo Elvis a Las Vegas a gorgheggiare con Little Richard; in un set campagnolo con staccionata e paglia che nemmeno Hank Williams; con barba, camicia western e scarpe da tennis mentre presenta un film dove avrebbe dovuto interpretare Gesù (The Carpenter, ndr) poi mai visto, e forse nemmeno girato. Lewis ciclone inesauribile, abituato alla posa di tre quarti verso destra, con l’asta bassa del microfono che gli blocca le ottave alte del piano, e lui con la mano destra ci gira attorno più veloce della luce. Sembra andare come un razzo il documentario di Ethan Coen. In mezzo agli eventi di una rockstar capace di stare con quattro brani in un anno nella top chart USA, di avere uno show tv tutto proprio dove si muove velocizzato come Benny Hill e canta uno smorzone (ballabile lento ndr) romantico come Autumn Leaves.
Un uragano musicale e umano, spirituale e intimo. Sette matrimoni per Jerry Lee, tra cui il più chiacchierato e scandaloso, tanto da essere cancellato da molti cartelloni e tv, quello con Myra, quella ragazzina che nel film Greatballs of fire è interpretata da Winona Ryder (e Jerry Lee, Dennis Quaid). Si sposano nel ’57, lui 22enne, lei 12enne, “ma ne ha compiuti 13 il giorno dopo il matrimonio”, precisa serafico Lewis. Shake baby shake. Il ricciolo d’oro che cade sulla fronte. Le mani sul piano che saltano in aria. E tanti momenti spettacolari che costellano la via lattea di un successo infinito. Ci piace ricordare un duetto impossibile con Tom Jones, ma anche le trovate visive che Coen utilizza per la hit Greatballs of fire montata come una specie di prisma almeno con sette otto esibizioni diverse del brano, oppure inanellare le calorose epiche entrate sul palco lanciate da celebrità come Bruce Springsteen. Lewis come una sorta di inesauribile smargiasso: eccessi di droga e alcool (con tanto di infarti e rinascite), battute taglienti per chiunque, e quella strafottenza al pianoforte che lo fa scalciare, dimenarsi come un matto, senza cedere all’imitazione sexy di Elvis. Su tutto aleggia un senso di peccato disinibito e di un peccatore mai domo. Un esecutore dal vivo che nemmeno la vecchiaia, le malattie e la malasorte allontanano da quella tastiera ipnotica, tanto che Coen gli lascia un ultimo sprazzo di grazia con un gospel suonato ad 85 anni che dopo aver danzato e saltato per un’ora e un quarto obbliga lo spettatore a spiegare il fazzoletto e raccogliere le lacrime del mito.