‘L’anarchico’ di Soth Polin: un indimenticabile viaggio nella tragedia cambogiana

Perché la politica e i politici fanno schifo. Su questa terra e sotto questo cielo immenso la politica è dappertutto uguale, un interminabile inganno. Poiché il nostro cuore era puro, noi amavamo ciò che era netto, senza ipocrisia e artifici. Ma un regime politico che non sapeva comportarsi da brigante e mentire non poteva durare: era condannato alla distruzione. Si trattava dunque di disonestà, né più né meno.
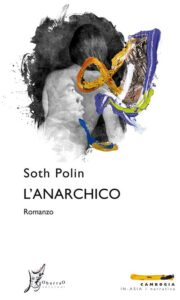 L’anarchico, di Soth Polin (traduzione di Alessandro Giarda, prefazione di Patrick Deville; ObarraO Edizioni), è uno sconvolgente, straordinario romanzo di uno dei pochi scrittori cambogiani sfuggiti alla furia omicida dei khmer rossi. Istruito alle scuole medie da Saloth Sar (più noto con lo pseudonimo Pol Pot, Fratello Numero 1), Soth Polin diventa, negli anni Sessanta, professore di filosofia, autore di romanzi e racconti che mescolano Freud, Nietzsche, l’esistenzialismo francese e antiche strofe buddiche, giornalista politico, editore di quotidiani e infine esiliato a Parigi (un anno prima della presa di Phnom Penh da parte dei khmer rossi) per aver denunciato le violenze e gli omicidi politici nella traballante repubblica del mellifluo generale Lon Nol (che in precedenza Soth Polin aveva appoggiato).
L’anarchico, di Soth Polin (traduzione di Alessandro Giarda, prefazione di Patrick Deville; ObarraO Edizioni), è uno sconvolgente, straordinario romanzo di uno dei pochi scrittori cambogiani sfuggiti alla furia omicida dei khmer rossi. Istruito alle scuole medie da Saloth Sar (più noto con lo pseudonimo Pol Pot, Fratello Numero 1), Soth Polin diventa, negli anni Sessanta, professore di filosofia, autore di romanzi e racconti che mescolano Freud, Nietzsche, l’esistenzialismo francese e antiche strofe buddiche, giornalista politico, editore di quotidiani e infine esiliato a Parigi (un anno prima della presa di Phnom Penh da parte dei khmer rossi) per aver denunciato le violenze e gli omicidi politici nella traballante repubblica del mellifluo generale Lon Nol (che in precedenza Soth Polin aveva appoggiato).
Sarà a Parigi che l’autore cambogiano scriverà la seconda parte de L’anarchico (nel 1979, due settimane prima che l’esercito vietnamita entrasse in Cambogia per sgominare i khmer rossi), che aggiungerà a quello che inizialmente era intitolato Senza pietà, le chiappe all’indietro, un romanzo breve pubblicato in Cambogia nel 1967, vietato dalle autorità e venduto clandestinamente.
Le due parti del libro, scritte a oltre dieci anni di distanza l’una dall’altra, hanno un filo conduttore nell’affrontare la sconfitta, la perdita, l’incapacità dell’uomo di non vedere, e denotano un pensiero politico e sociale affatto scontato nella scomposizione psicologica della voce narrante. Mescolando insieme l’autobiografia e la finzione, Soth Polin ha scritto un romanzo storico, politico e folle, dove il sesso, la morte e l’avidità la fanno da padroni.
Nella prima parte ci troviamo nella Cambogia degli anni Sessanta, durante la discutibile “terza via“ del principe Sihanouk. L’io narrante, stanco del decadimento politico e culturale della nazione, porta avanti un’esistenza da flâneur libertino nei bordelli della capitale e tra le mura della famiglia che lo ha accolto. Il protagonista è una specie di Henry Miller indocinese soltanto a tratti appagato dalle sue imprese sessuali, un misogino meticoloso nelle descrizioni anatomiche femminili che in qualche modo, tra visioni oniriche e realtà ovattata, cerca, suo malgrado, la tragedia che infine gli piomberà addosso.
La seconda parte si svolge a Parigi. L’io narrante è un tassista cambogiano che, seduto sul ciglio di una strada racconta la sua odissea (e del suo popolo) alla passeggera inglese morta a seguito di un incidente da lui provocato. Non c’è panico, non c’è dolore nel vedere una ragazza che muore, perché il dolore “nazionale” di Virak (il protagonista) è più grande della perdita di un singolo. Virak ha vissuto nella Cambogia attanagliata dalla furia cieca dei khmer rossi, delle bombe americane, dell’ortodossia vietnamita oltreconfine. I cambogiani hanno vissuto l’olocausto (con la benedizione dei cristiani marxisteggianti europei) e tutto il resto è insignificante dolore quotidiano. Poca cosa davanti a un popolo quasi totalmente annientato.
Doloroso, lirico, a tratti sgradevole, L’anarchico è un crudo atto di accusa scritto attraverso un punto di vista originale. Un libro bellissimo, che ci mette davanti alle nostre dimenticanze e alla nostra semplicistica visione mainstream del mondo.
Pensare ai figli oggigiorno non è di moda in questa nuova Bisanzio che scivola nel piagnucolio. Dove ci si intenerisce in modo spropositato per cani, topi, cuccioli di foca… gangster e terroristi. Ma non si scendeva mai in strada per quei bambini cambogiani a cui fracassavano la testa a bastonate durante la notte totale di questa rivoluzione dantesca.



