Due titoli tra realtà e magia che raccontano Malesia e Filippine

Non saprei valutare quanto durò quella discesa del fiume, quella traversata di grandi solitudini. Ma a poco a poco l’acqua verde si era intorbidata. Alcuni affluenti melmosi, provenienti dalle miniere di stagno, vi si mescolavano con lunghe scie ocra. C’era qualcosa di cinese in tutto ciò, pensavamo. Come se ovunque i cinesi portassero con sé il loro Fiume Giallo. Presto galleggiammo su una distesa d’acqua ogni giorno più ampia, ogni giorno più carica di limo, che si gonfiava, si spandeva, straripava fin nella vegetazione delle rive, poi alcune correnti languide si riformavano, la superficie si abbassava come il latte tolto dal fuoco. Allora emergevano i cespugli, si vedevano i rami degli alberi, i loro tronchi, le palafitte delle loro radici nude.
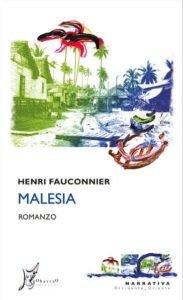 Malesia, di Henri Fauconnier (traduzione di Alessandro Giarda; ObarraO Edizioni), è l’unico romanzo scritto dall’autore francese, insignito del Premio Goncourt nel 1930. Fauconnier era stato un piantatore di caucciù in Malesia, dove si era stabilito nel 1905, ed era tornato nel Paese asiatico dopo la Prima guerra mondiale (durante la quale era stato soldato al fronte) per scrivere un testo ispirato in parte alla sua esperienza.
Malesia, di Henri Fauconnier (traduzione di Alessandro Giarda; ObarraO Edizioni), è l’unico romanzo scritto dall’autore francese, insignito del Premio Goncourt nel 1930. Fauconnier era stato un piantatore di caucciù in Malesia, dove si era stabilito nel 1905, ed era tornato nel Paese asiatico dopo la Prima guerra mondiale (durante la quale era stato soldato al fronte) per scrivere un testo ispirato in parte alla sua esperienza.
Lescale e Rolain si sono conosciuti nell’inferno delle trincee ed è qui che per la prima volta Rolain parla all’amico della Malesia. Lescale vi approda all’inizio degli anni Venti, con l’obiettivo di ritrovare l’ex compagno di sventura che non aveva risposto a nessuna delle sue numerose lettere. Lescale viene assunto per lavorare in una piantagione di gomma dove assiste alla ferocia razzista dei coloni inglesi nei confronti della popolazione locale. Quasi per caso rincontra Rolain e lo segue nel cuore della giungla per provare a carpire i misteri primigeni e l’anima malese.
In un rimando, probabilmente involontario, ai Marlow e Kurtz di Cuore di tenebra di Joseph Conrad, Malesia è un potente affresco dell’era del colonialismo, un viaggio lirico che cerca di far emergere lo spirito della Malesia e di chi la abita. Un testo che anticipa l’esistenzialismo francese (e anche Giorni in Birmania, di George Orwell, pubblicato nel 1934), e che è esempio riuscito di opera di formazione, capace di far porre domande al lettore sul senso dell’essere umano nel mondo in cui è catapultato.
Di questo si tratta. Barche, ciottoli, canali paludosi. Tutto uno sgranocchiare di noci da coni di carta, mentre si sta appoggiati al muro. Cacca di cavallo per le strade, pipistrelli sugli alberi. Cinesi con codini tipo code di aquiloni che vendono giornali a iosa. Mentre le donne puzzano di pesce ma che sembrano angeli (ci sono anche ragazze innocenti che è meglio non toccare). Sorci ovunque. Uno sputare, sputare, sputare ovunque, un carnevale, un torneo di sputi. Geniale! Sono stato colpito sulla tenda del carretto.
 La rivoluzione secondo Raymundo Mata, di Gina Apostol (traduzione di Alessandro Raveggi; Utopia Editore), è un caleidoscopico ritratto delle Filippine raccontato attraverso le pagine del diario di un giovane rivoluzionario protagonista nei moti di liberazione che scossero l’arcipelago sul finire dell’Ottocento.
La rivoluzione secondo Raymundo Mata, di Gina Apostol (traduzione di Alessandro Raveggi; Utopia Editore), è un caleidoscopico ritratto delle Filippine raccontato attraverso le pagine del diario di un giovane rivoluzionario protagonista nei moti di liberazione che scossero l’arcipelago sul finire dell’Ottocento.
L’operazione fatta dall’autrice è sorprendente: con l’utilizzo di un corposo paratesto, passando tra note, citazioni, prefazioni, glosse, il romanzo diventa esempio originale di metaletteratura contemporanea, dove le vicende generali della storia si uniscono alle vicende di formazione di Raymundo Mata, bizzarro e passionale studente giunto a Manila per partecipare a una rivoluzione incompleta ed essere spettatore di crimini efferati, passioni d’amore, cambiamenti sociali e culturali.
Richiamando a Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges e David Foster Wallace (quest’ultimo per ciò che riguarda l’abuso di note a piè di pagina), La rivoluzione secondo Raymundo Mata è un libro che si muove in modo inusuale, entra ed esce con disinvoltura nel mondo del realismo magico, del citazionismo e del concetto di libertà individuale e collettiva. Analizza a trecentosessanta gradi i sentimenti di un uomo apparentemente come tanti svelando un percorso tragicomico di storia filippina.



