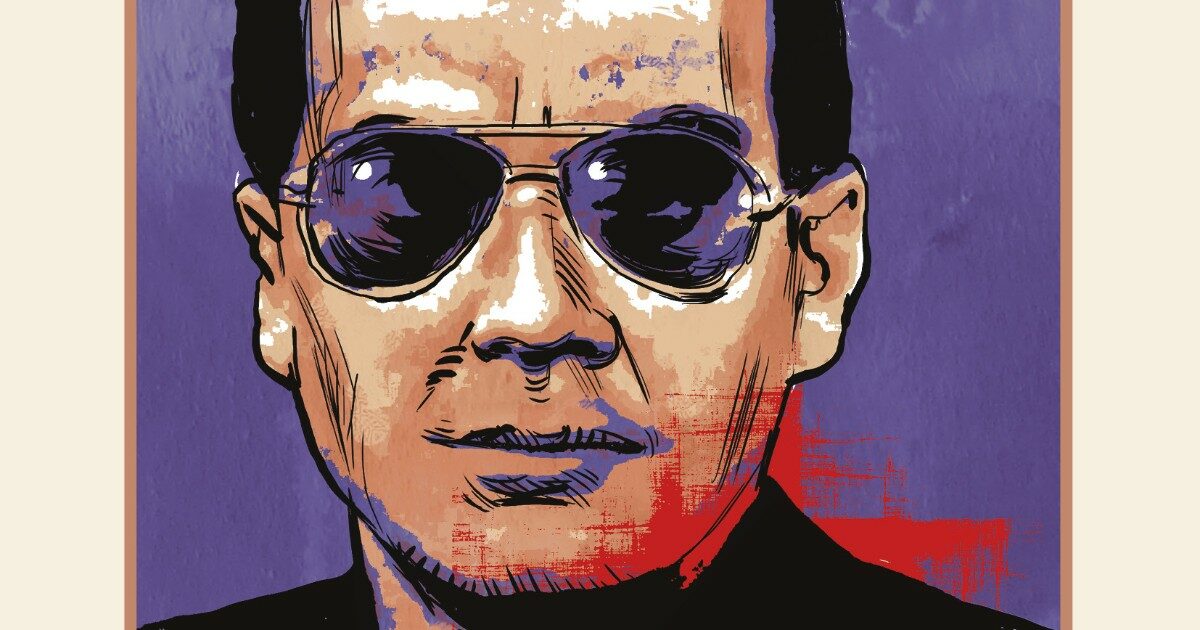Hanno ammazzato Messina Denaro si potrebbe definire “il primo romanzo distopico” sulla mafia. In un anno imprecisato del recente passato, il capo della mafia, ancora latitante e all’apice del suo potere, viene improvvisamente ucciso in maniere barbara. Da chi? E per quale motivo, con quali oscurissimi obiettivi, visto che il risultato dell’omicidio sarà sicuramente l’avvio di una nuova mattanza, una “terza guerra” di mafia? “Immagino come quella morte potrebbe essere stata in un mondo parallelo”, dice di questo libro edito dalla Compagnia Editoriale Aliberti l’autore, Benny Calasanzio Borsellino. Concittadino del boss Messina Denaro (Calasanzio è nato nel 1985 a Castelvetrano) Calasanzio Borsellino non è parente del giudice: e tuttavia la mafia è entrata nella sua vita con la stessa tragica brutalità. Suo zio e suo nonno, Paolo e Giuseppe Borsellino, piccoli imprenditori, sono stati uccisi da Cosa Nostra nel 1992, per essersi opposti alla vendita della loro impresa di calcestruzzi ai corleonesi. Dopo aver girato l’Italia per raccontare la storia della sua famiglia agli studenti, lo scrittore e giornalista Calasanzio oggi vive in un’isola del Mediterraneo, un po’ per scelta e un po’ per necessità di sicurezza.
Dal suo osservatorio distaccato, ma solo geograficamente, ha deciso di scrivere un romanzo di mafia molto particolare: quasi una sfida, nel panorama editoriale italiano di oggi. Perché intrecciare la storia e la cronaca con la fantasia e la fiction pura? Perché, secondo l’autore, il fenomeno mafioso resta, a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, ancora un profondo mistero. Chi tirava i fili, e chi li tira ancora? Dov’è finita la mafia oggi, una volta smesse le stragi e divenuta “bianca”? Sono tutti interrogativi ai quali, secondo Calasanzio, oggi un romanzo può rispondere forse meglio di un saggio di inchiesta, formulando ipotesi realistiche e scenari verosimili che forse un giorno si rileveranno più veri della verità ufficiale. La mafia esiste ancora, ed è forse più forte di prima. Solo è molto più nascosta, sfuggente come un fantasma, come il fantasma di Messina Denaro che si aggirava per la sua cittadina indisturbato. “Perché come mi disse con disprezzo un giovane del mio paese mentre appendevo dei manifesti antimafia, ‘lo vuoi capire o no che con la mafia mangiamo tutti’”.
L’ESTRATTO IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA
 Il casolare da dentro sembrava molto più grande. A ogni porta c’era qualcuno in divisa che gli indicava il percorso fino a un grande arco di pietra, delimitato dal tipico nastro bianco e rosso. All’interno c’erano una decina di tecnici della scientifica infilati nelle loro tute bianche. Il cadavere era esattamente di fronte all’entrata, sulla parete opposta. La faccia non c’era più. Il colpo di lupara aveva lasciato solo pezzi di cervello appiccicati sul muro dietro e un pirtuso grande quanto una mano. L’ispettore Lo Cicero tirò fuori dal taschino un fazzoletto bianco e lo portò al naso. Poi prese una specie di pomatina ai chiodi di garofano e se la spalmò sotto alle nasche. Anche quella pomata era figlia degli anni Ottanta e del tour giornaliero tra morti ammazzati in mille modi. L’odore di metallo, la carne bruciata nelle sparatine di lupara, la merda che la vittima lasciava andare quando crepava, erano sapori più che odori e non aveva voglia di mangiare.
Il casolare da dentro sembrava molto più grande. A ogni porta c’era qualcuno in divisa che gli indicava il percorso fino a un grande arco di pietra, delimitato dal tipico nastro bianco e rosso. All’interno c’erano una decina di tecnici della scientifica infilati nelle loro tute bianche. Il cadavere era esattamente di fronte all’entrata, sulla parete opposta. La faccia non c’era più. Il colpo di lupara aveva lasciato solo pezzi di cervello appiccicati sul muro dietro e un pirtuso grande quanto una mano. L’ispettore Lo Cicero tirò fuori dal taschino un fazzoletto bianco e lo portò al naso. Poi prese una specie di pomatina ai chiodi di garofano e se la spalmò sotto alle nasche. Anche quella pomata era figlia degli anni Ottanta e del tour giornaliero tra morti ammazzati in mille modi. L’odore di metallo, la carne bruciata nelle sparatine di lupara, la merda che la vittima lasciava andare quando crepava, erano sapori più che odori e non aveva voglia di mangiare.
Si avvicinò e iniziò a ispezionare il cadavere con attenzione. Due spessi tondini di ferro, uno nella spalla destra e uno in quella sinistra, inchiodavano l’ammazzato al muro di tufo tenendolo in piedi, con le braccia lungo il corpo e con quello che rimaneva della testa adagiato sulla spalla sinistra. Il corpo era completamente nudo, i vestiti piegati bene ma da un maschio, da uno che fa le cose “alla cazzo”. Sopra di essi le scarpe, una a fianco all’altra. Al collo gli avevano lasciato una collana d’oro con appizzatto un crocefisso grosso quanto un mandarino. La vittima, a occhio e croce, doveva avere al massimo cinquantacinque, sessant’anni. Mentre stava analizzando e catalogando tutte le informazioni nella sua testa, venne raggiunto da Francisci che rimase un metro dietro di lui per lasciargli terminare l’ispezione.
La macabra ipotesi del dottor Francisci era che l’appizzamento del cristiano fosse avvenuto mentre la vittima era ancora viva e che solo dopo fosse stato ammazzato con la fucilata, con un’arma caricata a lupara. «Peppe, vedi tutto questo sangue ai suoi piedi? Se fosse stato appizzato da morto non sarebbe qui o quantomeno sarebbe anche qui vicino. Invece è solo ai suoi piedi… sono abbastanza sicuro, lo hanno piantato al muro e solo dopo gli hanno sparato in faccia». Un’esecuzione spietata ed eloquente, di quelle che Lo Cicero in anni e anni non aveva ancora visto. Per terra c’era ancora la mazza che avevano utilizzato per piantare i chiodi su quel cristiano che di Cristo aveva poco. Manco la dignità di coprirgli le sue cose private gli avevano lasciato. Lo Cicero, con la benevolenza di Francisci, indossò dei guanti e toccò il petto del defunto in vari punti. Scosse la testa e si grattò ossessivamente la barba, cercando con lo sguardo quello di Francisci, che però guardava fisso per terra evitando abilmente di incrociare l’ispettore. Il sospetto che gli avevano comunicato non era più tale.
Lo avevano chiamato nel suo giorno libero e gli avevano detto di andare a Santa Margherita e di non parlare con nessuno. Pareva essere una cosa grossa e avevano chiesto esplicitamente di lui. Il Rolex Daytona e la croce tatuata sul petto, accanto al cuore, lasciavano pochi dubbi. Quella descrizione e quel tatuaggio coincidevano perfettamente con le rivelazioni dei pentiti. Era iniziata la terza guerra di mafia, e la prima testa a saltare era stata quella del re, Matteo Messina Denaro, ammazzato come un cane per una dichiarazione di guerra che non poteva essere fraintesa. Lo Cicero si sfilò i guanti e guardò il medico. Cercò nuovamente il suo sguardo fino a quando Francisci non poté più evitarlo e dovette cedere: «Che minchia hanno fatto, Pietro?» Il medico riabbassò lo sguardo. Per terra, ai piedi del cadavere, c’era un preservativo srotolato, un portachiavi Ferrari e una carta da cinquecento euro. Mentre Lo Cicero era chinato sugli oggetti e li rovistava con un pezzo di legno, da fuori si sentirono grida disperate e il pecoraio che piangeva senza tregua.
I due uscirono e trovarono, assieme agli uomini della Scientifica, il dottor Pietro Calabrese, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che continuava a chiedere al pecoraio cosa sapesse. Il povero cristiano si tirava i capelli piangendo e urlando che non sapeva niente, muovendosi in maniera ridicola come per dare mostra della assoluta innocenza. Pareva che fosse una marionetta mossa da un abile puparo. Continuava a dire che la moglie lo aspettava e continuava a non ricordare il nome del farmaco che la signora prendeva. «Lo lasci dottore, chissu non sa niente, lasciatelo stare, lasciatelo andare…», disse Lo Cicero. Il magistrato si ricompose subito e con una mossa istintiva si pulì le scarpe nere a punta con un fazzoletto di cotone. Poi si rivolse verso l’ispettore e gli chiese a muso duro: «È lui?»
«Sì, iddu è», rispose l’ispettore. Non aggiunse nulla. Calabrese bestemmiò ad altissima voce. «Puru iddu ci si mette…», sibilò Lo Cicero. «Cosa dici?», chiese Calabrese. «No, niente…», rispose l’ispettore che non poté evitare un sorriso. Perché in Sicilia il sorriso esce quando minchia gli pare, anche nei momenti meno opportuni.
Francisci e Lo Cicero aspettarono fuori che Calabrese finisse il sopralluogo senza dire una sola parola. La loro memoria tornava a quegli anni, che né l’uno né l’altro avrebbero mai voluto rivivere. Di lì a poco sarebbe arrivata la stampa, le televisioni, e una volta diffusa la notizia, si sarebbe scatenato l’inferno. La guerra.
Il giudice uscì con un ghigno sul viso: «Cani, sono tutti dei cani. Gli piacevano le buttane, le auto di lusso e il denaro e loro lo hanno salutato e mandato all’altro mondo con un profilattico, un portachiavi e i soldi. Sono stati i palermitani, sicuro, e sono venuti qui ad ammazzarlo, nel suo territorio facendolo soffrire come un cane prima di sparargli. Hanno scatenato la guerra questi, non hanno manco idea di quello che accadrà», disse Calabrese e mentre lo diceva con una mano si massaggiava la fronte. Lo Cicero si limitava ad ascoltare Calabrese, quando si sentirono arrivare dall’acchianata le auto e i mezzi dei giornalisti. Mentre gli uomini della Polizia costruivano un cordone di sicurezza, i tre si defilarono. «Sono dei pazzi, sono dei pazzi… se questi sanno il nome prima di domattina io vi faccio cacciare tutti», urlò il magistrato verso i tecnici e gli agenti presenti sulla scena dell’ammazzatina. «Chi cazzo ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Io ora chiamo il questore, perché lo trovo lo stronzo che ha chiamato i giornalisti, minchia se lo trovo».
«Dottore se qui non c’è altro torno a Palermo io, vado a parlare col questore, mi stanno aspettando…», disse Lo Cicero al magistrato che annuì svogliatamente e lo congedò. L’Alfa, che prima di incontrare la polvere era blu e ora color sabbia, era già pronta con il muso verso Palermo. Lo Cicero acchianò e Argento mise in moto. Alla transenna i giornalisti si misero davanti alla macchina di Lo Cicero senza farlo passare. «A chi hanno ammazzato, non potete non dircelo, stiamo facendo il nostro lavoro…», urlarono praticamente in coro i cronisti, mentre qualcuno azzardò un colpetto sul finestrino di Lo Cicero. Lui lo guardò e lo fulminò, e la sua mano andò direttamente sulla maniglia che stava per aprire, scendere e prendere a male parole lo stronzo. Argento lo fermò sul pensiero: «Lasci stare ispettore, andiamo».
«Sucate tutti», sussurrò Lo Cicero, che buttò la testa indietro mentre l’auto iniziava il viaggio in direzione Palermo.