Riforme e premierato, perché ciò che vuole fare il governo Meloni deve preoccuparci molto
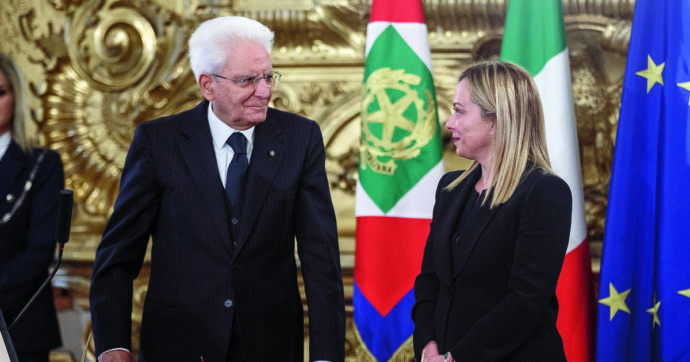
Ieri sera è trapelata la bozza del disegno di legge di revisione costituzionale che, salvo smentite, sarà approvato nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri. Il testo è breve, ma necessita di uno sforzo di chiarezza quasi didascalico, perché si cominci a formare sin da ora nell’opinione pubblica la coscienza di ciò che si vuole compiere da destra. Nel tempo che accompagnerà il dibattito di questa riforma, un’accorta divulgazione sarà imperativa.
Il disegno modifica il cuore della forma di governo parlamentare sapientemente disegnata dai costituenti.
Il proprio di tale forma, a distinguerla dalle altre, non è evidentemente il solo fatto che esista un Parlamento – che è condizione essenziale per qualsiasi sistema democratico, con qualunque forma di governo –, ma che il governo sia emanazione permanente del Parlamento. Il governo è, dunque, proiezione della maggioranza politica all’interno del Parlamento eletto dai cittadini: c’è una maggioranza che si fida del governo, che ascolta il suo programma politico e gli dà fiducia, sceglie cioè di mettersi a collaborare alla sua realizzazione.
Se un giorno tale fiducia dovesse venir meno, il governo smetterebbe di essere emanazione di quella maggioranza, ci sarebbe una discrasia, un mancato allineamento tra governo e maggioranza in Parlamento. In queste circostanze, il governo non potrebbe che dimettersi, e a quel punto delle due l’una: o la maggioranza in Parlamento è in grado di dare la fiducia ad un nuovo governo, con cui cominciare di nuovo a lavorare; o, se un nuovo governo di cui la maggioranza si fidi non si trova, bisognerà far ripartire tutto il circuito dal punto di avvio – con la regia del Presidente della Repubblica –, indicendo nuove elezioni, tornando agli elettori, e riprovandoci con un nuovo Parlamento (e una nuova maggioranza).
Il sistema così brutalmente sintetizzato ha alcuni difetti ma diversi pregi, e tra questi il principale è quello di bilanciare il ruolo del Parlamento e quello del governo, senza rovesciamenti o preminenze eccessive. Nella fase fisiologica, infatti, la maggioranza del Parlamento e il governo sono allineati – il secondo emanazione del primo, appunto. E così tutto fila nel migliore dei modi: il governo propone la sua agenda, e il Parlamento collabora approvando le misure necessarie. Il circolo virtuoso si interrompe quando la maggioranza del Parlamento non si fida più del governo, e a quel punto decide di metterlo con le spalle al muro. Se la si vuole individuare, dunque, una ultimativa prevalenza c’è, ed è del Parlamento, ma sul punto si tornerà tra un attimo.
La riforma che il governo presenterà alle Camere fa fondamentalmente due cose. La prima: introduce l’elezione diretta (anche) del Presidente del Consiglio. E, la seconda: assicura con un colpo di mano una maggioranza parlamentare certa al governo, prevedendo che il Parlamento sia eletto con un sistema che alle liste legate al Presidente del Consiglio eletto attribuisca sempre, di default, il 55% dei seggi, ben più della maggioranza semplice richiesta per il voto di fiducia. Un premio di maggioranza, peraltro, assegnato senza alcuna soglia minima di voti, con assoluto spregio di quanto la Corte costituzionale aveva chiarito nella sentenza n. 1 del 2014: “Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza (…) combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima (…) è tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto”. (E se l’eguaglianza del voto è principio supremo, come forse può considerarsi in quanto precipitato del principio di eguaglianza, neanche una riforma costituzionale potrebbe andargli contro). L’alterazione, peraltro, risulta ancora più mostruosa se si considera la scarsa affluenza elettorale delle ultime stagioni: si finirebbe per dare il 55% dei seggi ad una porzione di elettori spaventosamente esigua.
La combinazione delle due cose – elezione diretta e premio di maggioranza – blinda in maniera formidabile il governo, con un risultato inedito nel panorama delle forme di governo. Neanche in Germania, dove pure c’è la forma di governo più stabile nel panorama comparato, si arriva a tanto. Qui si è oltre la razionalizzazione del sistema parlamentare, cioè quell’insieme di strumenti volti a garantire la stabilità del governo. Qui forse si è proprio oltre il sistema parlamentare e basta.
E sì, perché, come si diceva prima, il proprio del sistema parlamentare è che tutto ruoti intorno al rapporto di fiducia, nei termini che si cercava di illustrare sopra. Ma se tu garantisci forzosamente che il capo del governo abbia sempre il 55% dei parlamentari dalla sua parte, la fiducia si svuota di significato, alla stregua di uno stanco rito parlamentare, “un atto di formale deferenza” come lo aveva chiamato qualcuno il 16 novembre 1922, quando si era recato a chiedere la fiducia alle Camere dopo l’incarico del re.
Nella denegata ipotesi in cui, nonostante il mostruoso premio di maggioranza, il Parlamento non dovesse dare la fiducia al governo – continua il testo della riforma – il Presidente della Repubblica dovrebbe insistere spedendo alle Camere di nuovo il Presidente del Consiglio eletto perché reiteri la richiesta di fiducia; e se dovesse esserci un secondo diniego, il Quirinale non potrebbe che sciogliere le Camere e indire nuove elezioni.
Ora, a parte che è veramente difficile immaginare uno scenario in cui il Parlamento non dia la fiducia ad un Presidente del Consiglio eletto dai cittadini – sarebbe un cortocircuito democratico non da poco, e neanche appetibile per i parlamentari, che andrebbero dritti a casa con lo scioglimento delle Camere – qui l’altra grande vittima è il Presidente della Repubblica. Tolta la nomina del Presidente del Consiglio, che è eletto direttamente, e tolta ogni discrezionalità nello scioglimento della Camere, non gli restano che le onorificenze.
Altri difetti e disfunzionalità della riforma emergeranno nel dibattito dei prossimi giorni, settimane, mesi. Non è da escludersi che le cose più gravi e pericolose siano altre rispetto alle criticità macroscopiche qui messe in evidenza: il diavolo, si sa, si nasconde nei dettagli. Resta una cosa importante ancora da precisare.
Come si diceva prima, la forma di governo attuale ha una regola di ultimativa prevalenza del Parlamento. La riforma, evidentemente, capovolgerebbe la situazione: la parola ultima ce l’avrebbe il governo, perché se il Parlamento non lo sostiene si va tutti a casa. Un po’ “muoia Sansone con tutti i filistei”.
Ma la regola a favore del Parlamento si giustifica in ragione della natura rappresentativa dell’organo, e non basta, per bilanciare, far eleggere anche il governo. Il Parlamento è più rappresentativo non soltanto perché è eletto direttamente (mentre il governo, al momento, non lo è), ma forse soprattutto perché è un organo che contiene al suo interno la rappresentanza delle minoranze. Al contrario, il governo, anche se eletto dai cittadini direttamente, sarà sempre espressione della sola maggioranza politica, che molto spesso è niente altro che la più ampia minoranza. In un certo senso, il governo non potrà mai dirsi politicamente rappresentativo in senso pieno, perché lascerà sempre al di fuori quelle parti che non coincidono con la maggioranza, e la cui presenza è invece garantita in Parlamento.
È (anche) per questo che un riforma così sbilanciata a favore del governo non può che preoccupare nel più forte dei modi.



