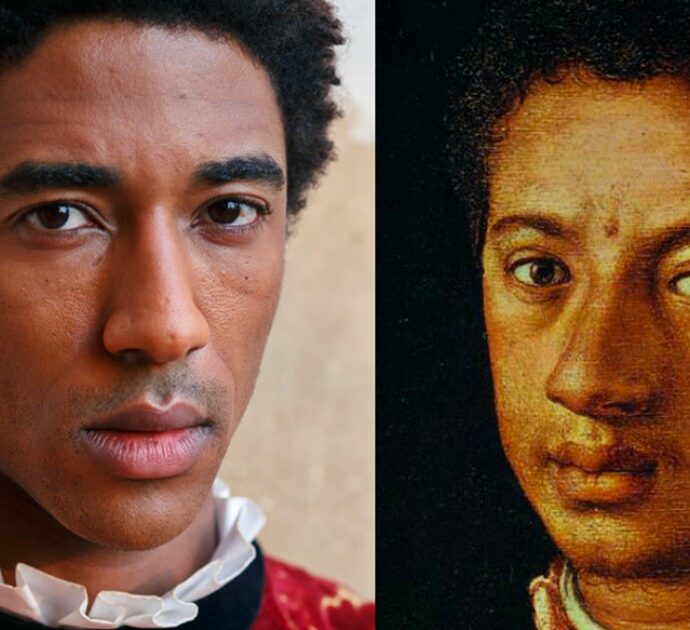Chiedersi perché qualcuno a Hollywood si prenda la briga di progettare un prequel sul personaggio di Willy Wonka, scavalcando e anticipando il corpus letterario di Road Dahl (La fabbrica di cioccolato), sarebbe la prima ragionevole domanda da porsi. Dopodiché tocca pure vedere il film che ne è uscito: Wonka, diretto da Paul King (quello dell’ottimo Paddington 1 e 2).
Wonka è un musical tradizionalista e zuccheroso, con un protagonista (Timothée Chalamet) che grazie alla sua inconsistente fluidità identitaria (solo Guadagnino in Bones and all l’ha fatto pulsare di sanguigna vitalità) appiattisce ogni possibile discorso sognante e fiabesco oltre le allappanti dosi di cioccolata e al patetico quid di schmaltz (vedere alla voce: mamme). Dio ce ne scampi e liberi da questo Wonka che sembra un composto e arguto Topolino. Diciamo che, da adulto, interpretato nella versione tratta da Dahl nel 1971 da Gene Wilder e nel 2005 da Johnny Depp, Wonka ce lo ricordavamo come un perfido e avido Paperon de Paperoni. Come sempre eravamo una generazione di persone sbagliate. Oggi il cinema ci vede e ci vuole correggere.
Così Wonka, per essere accettato nel pantheon dei personaggi più inconsistenti dei musical hollywoodiani, deve mondarsi la coscienza e apparire da ragazzino con le pezze al culo del migrante e il sogno di diventare cioccolataio, prima di trasformarsi in un business man senza scrupoli. In controluce pare la solita storia da cancel culture, qui con una perfidia in più: non mettiamo i pannelli in cui spieghiamo che il maturo Wonka che abbiamo conosciuto negli anni, e che seccava gettandoli in un buco nero i bambini antipatici e viziati, aveva un comportamento deprecabile.
Qui andiamo direttamente alle presunte radici del personaggio e gli andiamo a dare una energica ripulita. A partire dalla solita scopiazzatura della città mondo brutto, sporco e cattivo alla Dickens dove piomba, per piazzare i suoi invitanti cioccolatini, l’implume, anzi ancora con baffetti accennati adolescenziali, Timothée tutto cilindro e giacca di raso vinaccia. Raggirato da una coppia, marito e moglie (Olivia Colman in chiave gargantuesca è anche buffa), che affitta stanzacce facendo firmare clausole capestro, Wonka finirà costretto a ripagare i due loschi figuri incarcerato nei sotterranei del loro palazzo a lavare e stirare panni sporchi per un decennio. Con l’aiuto di Noodle (Calah Lane), una piccola orfanella, Wonka evaderà nottetempo (e rientrerà al lavoro) infilandosi e riemergendo dai tombini per poi improvvisare con successo la vendita di dolci leccornie in mezzo alla strada. Solo che nella città dickensiana spadroneggia l’oligopolio di tre milionari cioccolatai che per rimanere al vertice del mercato corrompono da tempo poliziotti e prelati.
Il raffinato acidissimo trio cercherà in ogni modo di impedire a Wonka di affermarsi commercialmente nell’ottagono del cioccolato firmato – King ha voluto ispirarsi nella riproduzione del set nientemeno che alla Galleria Vittorio Emanuele II di Milano – ma dovrà soccombere di fronte alle buone intenzioni dell’immigrato occasionale. Wonka, il film, è uno zibaldone insapore di anonime architetture fiabeggianti (un po’ Londra dell’800, qualcosa di Praga, e appunto Milano), vane incursioni tra i generi (c’è perfino l’heist movie), melodie e balletti anonimamente dimenticabili, e questa venatura di sorriso controllato a cui vengono limate le asperità scorrette e indigeste tanto da sublimare in una versione steampunk degli Umpa Lumpa: non più una popolazione immaginaria tropicale di pigmei circondata da bacche di cacao che liquidano canticchiando brufolose creature, ma minuti lord con faccia arancione, capelli verdi fosforescente e l’aplomb british di Hugh Grant. Insomma, Wonka è uno di quei cioccolatini dalla confezione lucidata che una volta scartati mostrano chiazze biancastre e tornano a farsi sentire qualche ora dopo averli mangiati. Su quanto sia lezioso e insopportabile Chalamet in tutte le sue mossette da piccolo genio della recitazione meglio soprassedere.