“I ricchi hanno abdicato al loro storico ruolo: non contribuiscono più con le tasse a pagare il conto delle crisi. Si rischia l’instabilità sociale”

Guido Alfani, docente di Storia economica alla Bocconi e autore di As Gods Among Men - A History of the Rich in the West (Princeton University Press), che esce in Europa il 30 gennaio: "Mi auguro che non si arrivi a un esito troppo violento, ma piuttosto alla comprensione che occorre fare qualcosa". E spiega perché la beneficenza non basta
I ricchi, nella storia delle società occidentali, sono sempre stati visti con un certo sospetto. Per giustificare la propria posizione, a partire dall’antichità classica hanno svolto un ruolo preciso: contribuire a integrare i bilanci pubblici nei periodi di difficoltà. Mettere mano al portafoglio, insomma, per aiutare le comunità in cui vivevano. Ma durante le crisi del XXI secolo, dalla grande recessione del 2008 al Covid fino alle conseguenze delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, questo equilibrio è saltato: i molto abbienti si sono ulteriormente arricchiti ma il loro contributo finanziario non si è visto. E la politica non ha voluto o potuto pretenderlo. Il contratto sociale che da centinaia di anni rende accettabile la concentrazione di grandi fortune in poche mani è stato rinnegato. È la conclusione a cui arriva Guido Alfani, professore di Storia economica alla Bocconi, nelle 440 pagine di As Gods Among Men – A History of the Rich in the West (Princeton University Press), in uscita in Europa il 30 gennaio. “Se le cose continuano così”, commenta il docente con Ilfattoquotidiano.it, “credo che i segnali di fermento in termini di instabilità sociale e politica non potranno che intensificarsi. Mi auguro che non si arrivi a un esito troppo violento, ma piuttosto alla comprensione che occorre fare qualcosa”.
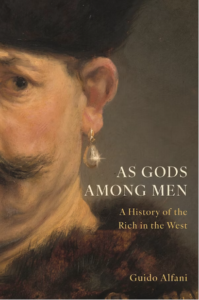
La guerra è un ottimo esempio: dal Medioevo fino alle guerre mondiali hanno accettato di concedere prestiti più o meno forzosi ai governi. Una sorta di “coscrizione del capitale”. Durante le crisi finanziarie, poi, i super ricchi erano spesso in grado di salvare da soli dalla bancarotta la propria città – penso al caso di Cosimo de’ Medici a Firenze – o impedire un collasso bancario – lo fece J.P. Morgan nel 1907 mobilitando anche le proprie relazioni nell’ambito delle élite di New York. In seguito il contributo di chi deteneva ingenti risorse è passato per la fiscalità, che a partire dal periodo delle Guerre Mondiali è diventata più intensa e fortemente progressiva. Questo, andando di pari passo con lo sviluppo del sistema di welfare, ha consentito fino all’inizio degli anni 70 di ridurre in maniera abbastanza evidente la disuguaglianza.
Durante le ultime crisi le cose sono andate diversamente. Gli aiuti a famiglie e imprese sono stati finanziati aumentando i debiti pubblici, destinati a pesare sull’intera collettività.
Dalla società è arrivata la richiesta che i ricchi contribuissero maggiormente, ma non se n’è fatto nulla. Pochissimi Paesi sono arrivati a imporre anche solo un’imposta di solidarietà temporanea. Durante la precedente campagna elettorale Usa, Joe Biden si è espresso per una maggiore tassazione sui più ricchi, poi non è riuscito a costruire un supporto politico sufficiente a introdurre una riforma del genere.
Perché?
C’è un grande paradosso: nonostante survey e studi sociologici ci dicano che c’è ampio consenso sulla necessità che i più abbienti paghino di più, questo non riesce a tradursi in politiche ad hoc. Forse gli stessi cittadini faticano ad accettare l’idea che per arrivarci serva un ripensamento importante del sistema fiscale. E la politica continua a nutrire la convinzione che a parlare di tasse si perdano le elezioni (a meno di non limitarsi a dire che verranno abbassate). Al contrario, credo che per i partiti di centrosinistra proprio il non parlarne pesi negativamente alle urne. Le riforme fiscali influenzano l’organizzazione della società.
Nel libro lei ricorda che in passato, quando i ricchi sono stati percepiti come indifferenti alle condizioni delle masse o sospettati di aver tratto beneficio dalle crisi, il risultato sono state rivolte e violenza. Rischiamo di arrivarci anche oggi?
In una società democratica possiamo augurarci che le richieste degli elettori portino alla costruzione di un consenso politico per cambiare le cose. Ma al momento non credo ci stiamo avvicinando a quell’esito. I segnali di fermento in termini di instabilità sociale e politica non potranno che intensificarsi.
Quelle di Reagan e Thatcher, con riduzioni delle aliquote più alte e abbattimento delle tasse sulle eredità, hanno favorito la concentrazione di ricchezza nelle mani di una ristretta minoranza. Quanto ha pesato l’influenza delle fasce più ricche sul potere politico?
L’impressione è che in quella fase i partiti di centrodestra stessero semplicemente cercando proposte nuove. Più avanti, negli anni ’90, l’aumento delle disuguaglianze potrebbe invece aver in effetti favorito una maggiore influenza della grande ricchezza sulla politiche e quindi anche sulle politiche fiscali. È difficile da dimostrare ma il sospetto è forte. E se fosse andata così la democrazia occidentale avrebbe un problema. Di sicuro, da quel momento in poi si è persa l’idea che l’imposizione dovesse essere molto progressiva e che le eredità dovessero essere tassate per livellare le condizioni di partenza.
Quali altri fattori hanno contribuito a farci arrivare a un punto in cui i ricchi sono spesso percepiti come “profittatori”?
C’entrano il ruolo molto maggiore della finanza nell’economia e nei percorsi per l’acquisizione di grandi ricchezze: dal punto di vista culturale, in Occidente arricchirsi scambiando titoli e facendo girare denaro è percepito come meno legittimo rispetto all’arricchimento legato a beni fisici. Pesa anche il fatto che, dopo la crisi del 2008, siano presto tornati in auge i grandi bonus per i manager e i maxi dividendi per gli azionisti: l’impressione è stata che, se c’erano dei responsabili, non abbiano pagato. C’è di più: tutte le crisi fanno vincitori e vinti, ma quando a chi si arricchisce non viene chiesto di contribuire più degli altri alle politiche necessarie per uscirne è normale che si diffonda lo scontento.
Molti super ricchi potrebbero rispondere che danno il proprio contributo attraverso la beneficenza. Quindi in via del tutto discrezionale e con l’effetto collaterale di pagare meno tasse, visto che i soldi donati sono detraibili.
Dal punto di vista storico la beneficenza è un modo per adempiere a una funzione sociale positiva. Ma se parliamo delle moderne società occidentali democratiche il discorso cambia. Mentre il prelievo fiscale comporta che la collettività decida attraverso le sue istituzioni come utilizzare le risorse, con il “giving” i ricchi si arrogano il diritto di decidere come impiegarle e in più ne traggono qualcosa in cambio. Anche nella forma di un’influenza in ambito culturale e politico da cui derivano potenziali benefici dal punto di vista economico. Torno alla storia: un tempo c’era una chiara distinzione tra “carità” e “magnificenza“. La seconda serviva anche a dimostrare di avere una sorta di diritto a governare. Quando Cosimo de’ Medici venne richiamato a Firenze per salvarla e iniziò a dispiegare la sua magnificenza, era chiaro a tutti che lo faceva anche per accompagnare la sua ascesa politica.
Campagne come In tax we trust, promosse da gruppi di molto facoltosi, chiedono un sistema fiscale giusto anche per correggere il giudizio della società nei confronti dei ricchi. Stando a un sondaggio commissionato da Patriotic Millionaires, tre quarti dei milionari sono a favore di maggiori tasse sulla ricchezza. Segnali di una possibile inversione di rotta o tentativi di migliorare la reputazione dello “0,1%”?
La mia impressione è che siano sinceri. Il fatto che si pongano il problema suggerisce che sta diventando ineludibile, soprattutto in un Paese come gli Usa in cui, come disse Warren Buffett, “la mia segretaria paga più tasse di me”. Dobbiamo però tener presente che quella campagna è animata da persone molto benestanti – milionari – ma non necessariamente super ricche. Diversi miliardari hanno invece aderito al Giving pledge, che è solo un impegno a fare beneficenza.
Perché in Italia anche un’ampia fetta di ceto medio tende a percepire le ipotesi di patrimoniale come una minaccia?
Come dicevo, si è diffusa l’idea che le tasse debbano essere riformate solo per ridurle. In più sospetto che il ceto medio non si renda conto che già oggi i patrimoni sono tassati e con modalità non necessariamente progressive, che possono avere nel loro insieme anche effetti perversi.
Qual è il suo giudizio sull’ipotesi di una tassa sui grandi patrimoni?
La mia opinione personale è che, visto l’impatto della trasmissione ereditaria nel creare dinastie della ricchezza, bisognerebbe partire dalla tassazione delle eredità. Ha una motivazione teorica molto forte: prelevare risorse con cui migliorare l’accesso all’istruzione e ad altri servizi, in modo da garantire a tutti le stesse opportunità di successo nella vita. In un secondo momento si potrebbe parlare anche di tassazione dei patrimoni, magari nell’ambito di una discussione su come reperire risorse per esigenze come la riduzione del debito.
—
Il Fatto è partner di Oxfam nella campagna di raccolta firme per chiedere l’introduzione nell’Unione Europea di un’imposta sui grandi patrimoni. Qui il link al sito La Grande Ricchezza da cui è possibile aderire