Giulio Deangeli, 29 anni, quattro lauree e un posto a Cambridge. L’intervista dopo il panel alla scuola del Fatto: “Studio come usare l’AI per curare malattie”
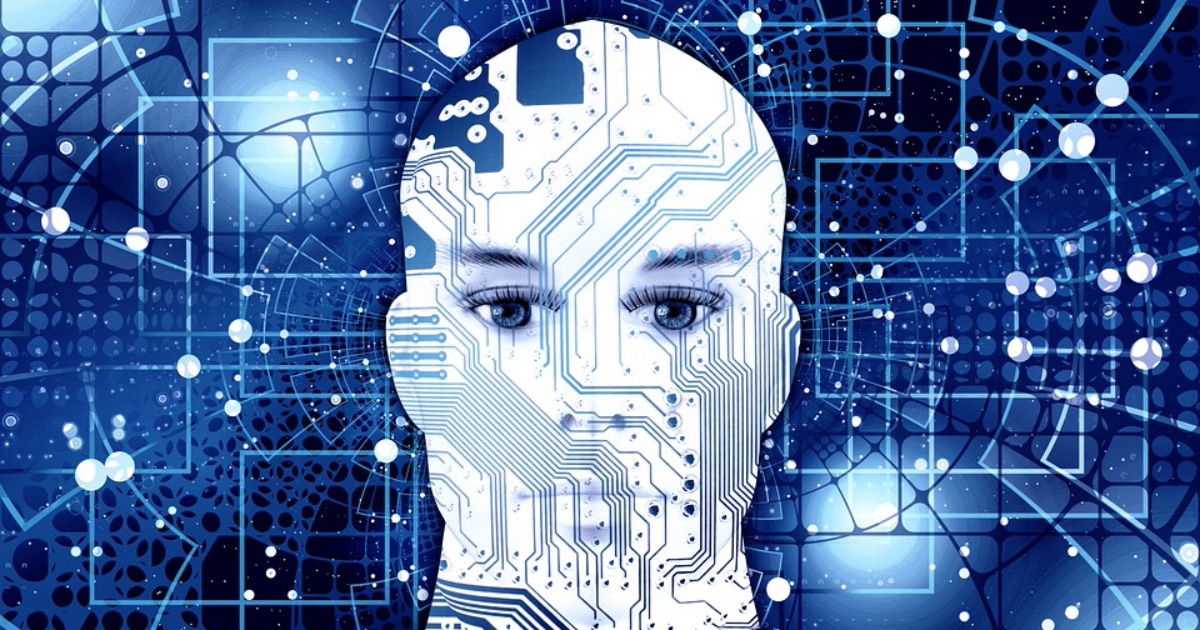
Giulio Deangeli è l’opposto del cervello in fuga. O almeno lui non intende esserlo: 29 anni, quattro lauree, di cui una in medicina, un master di secondo livello, volontariato, una non profit in via di formazione e attualmente ricercatore a Cambridge. E’ stato uno dei relatori del panel sull’intelligenza artificiale organizzato dalla Scuola del Fq all’università Roma Tre dove ha raccontato come l’innovazione possa essere applicata alla ricerca medica in ottica di ottimizzazione e identificazione dei campi da approfondire. Un’intelligenza straordinaria che, ora all’estero, punta in realtà a portare valore aggiunto all’Italia. “Proprio per questo – dice – Non sono un cervello in fuga”.
Deangeli, di dov’è?
Sono un mix di norditalia assortito, cresciuto tra Emilia, Piemonte, Lombardia, Svizzera, Veneto e Toscana.
E ha appena compiuto gli anni…
29 anni.
Come li ha festeggiati?
Partecipando al panel sull’Intelligenza Artificiale organizzato dalla Scuola del Fatto Quotidiano. Una esperienza molto bella. Ma a metà mese torno a Cambridge e festeggio davvero.
Cosa fa a Cambridge?
Sono lì da quasi tre anni, faccio ricerca, sono un Phd Student. Lavoro in due laboratori incredibili che sono diretti da Maria Grazia Spillantini e Pietro Liò. Spillantini è in pratica l’erede di Rita Levi-Montalcini, ha scoperto la la proteina centrale della malattia di Parkinson e ha rivoluzionato neurologia. Il suo laboratorio è specializzato proprio nelle malattie neurogenerative.
E Liò?
E’ uno dei massimi esperti al mondo di Ai, uno dei precursori del meccanismo di “attention”, per fare un esempio, fa funzionare Chat Gpt, ed e’ stato uno dei pionieri delle GNN, l’architettura che, per dirlo con semplicità, fa funzionare Google Maps.
E lei cosa fa?
Nel mio piccolo provo a studiare e realizzare strumenti che applicano l’intelligenza artificiale al problema dell’identificazione dei meccanismi molecolari della patologia, per fissare nuovi target che sono alla base della ricerca di nuove terapie.
Nel suo piccolo…
Mi piace moltissimo e sono facilitato dal mio background.
Quante lauree ha?
Quattro
Quattro a 29 anni: come è possibile?
Mi sono laureato in medicina, poi ho iniziato a dare esami di ingegneria, di matematica nello specifico. Medicina mi presentava il problema e la comprensione medica della patologia, ma sentivo l’esigenza di approfondire la parte degli strumenti d’indagine. Pensi, dopo il mio primo internato a Cambridge nel 2016, tornai a Pisa: la sera sono atterrato e il giorno dopo ho dato il mio primo esame di matematica. Mi sono divertito tantissimo e da allora non ho più smesso. E ho iniziato a dare esami di ingegneria.
Poi?
Da lì in poi ho deciso di fare la stessa cosa sul lato laboratoriale, quindi biotecnologie. Ho iniziato a dare esami e non ho più smesso. Ho insomma avuto la fortuna di avere una esposizione in entrambi i mondi, sia dell’Ai – con il mindset ingegneristico e quantitativo – sia del problema della patologia.
E questo aiuta nell’ambito Ai?
E’ una grande fortuna perché di solito chi fa ricerca in Ai arriva da un background di computer science puro e quindi non è sempre facile trovare applicazioni che siano utili dal punto di vista pratico.
E’ come se lei inglobasse un intero team di persone. Come ha fatto a ottenere questi titoli multipli?
Ho frequentato sei anni di medicina all’Università di Pisa. Ero anche allievo della scuola superiore Sant’Anna, dove ho preso il diploma di licenza magistrale in scienze mediche che è equiparato a un master di secondo livello. In parallelo ho seguito la laurea in ingegneria biomedica, poi in biotecnologie e infine la magistrale in biotecnologie molecolari. In parallelo facevo ricerca in estate all’estero, pubblicando vari paper.
Come ha fatto a fare tutto contemporaneamente?
Carlo Maria Rosati nel 2010 è stato un precedente. Non si poteva essere co-iscritti, perché era vietato dal famigerato Decreto Regio, però si potevano tenere esami extracurricolari acquisendo i crediti. E una volta finita una laurea, li si faceva riconoscere e ci si laureava in un’altra. Ora quel Decreto Regio è stato aggiornato e spero di aver dato il mio piccolo contributo.
In che modo?
Sono stato audito due volte al Senato e una alla Camera e la norma è stata poi aggiornato un anno fa con l’accordo di tutti i partiti. ora si può essere iscritti a più corsi di laurea contemporaneamente, agevolando notevolmente le procedure. Quel decreto era un relitto di una realtà che è cambiata. Al tempo del decreto, l’università aveva dieci corsi in tutto ed erano tutti altamente professionalizzanti. L’università oggi deve invece essere multidisciplinare. Per fare un esempio, si pensi a chi oggi deve disciplinare l’Ai: deve essere al contempo un politico in gamba e uno sviluppatore. Se non sa cosa fa l’Ai, infatti, non sa neanche cosa non fa e il rischio è che le attribuisca dei superpoteri o che abbia una lettura sbagliata del suo potenziale. C’è sempre più bisogno di questi background.
Poi il dottorato a Cambridge…
Sì.
Lei è un cervello in fuga, quindi?
No, non mi ritengo tale perché per me un cervello in fuga è chi va via con l’idea di non contribuire più al proprio Paese e non è quello che voglio. Il respiro della ricerca è mondiale, non ci si può esimere dall’esperienza all’estero. Ci sono posti in cui sono concentrate così tante risorse, sia economiche e quindi tecniche, sia intellettuali che non ci si può esimersi dal confrontarsi. Ho scritto anche un libro che appunto dimostra come non sia mia intenzione allontanarmi. Io voglio riportare una parte di tutto questo in Italia.
Libro?
Sì, fa parte di un progetto dal titolo “A choice for life”. E’ basato su una iniziativa di volontariato che porto avanti con altri ragazzi. Nasce nel 2017 come realtà locale a Este, in provincia di Padova, che è la città dove sono cresciuto, per aiutare i ragazzi e trasmettere loro informazioni che sono talmente pratiche ovvie e macroscopiche su come si vive nel mondo dell’università che poi alla fine nessuno insegna. Col risultato che nessuno le sa: si va da cosa misurano i ranking universitari (non la qualità della didattica ma della ricerca) alle convenzioni sul come rivolgersi ai professori, anche all’estero. Oppure cosa sono le scuole superiori universitarie (Sant’Anna, la Normale, e molte altre) che sono l’eccellenza e a cui si accede solo per merito, mettendo lo studente nelle condizioni di pensare solo allo studio. Lo Stato ci investe tantissimo e sono un unicum mondiale di assoluta eccellenza. Ed è una tragedia che così poche persone le conoscano. Diamo le istruzioni da fratelli maggiori, insomma.
Orientate?
Sì. E raccontiamo cosa si fa nelle varie professioni. Nelle scuole spesso chiedevo: “Cosa vuoi fare da grande?” e invece di avere come risposta “ingegneria meccanica” o “ingegneria elettronica” mi dicevano medico, astronauta, poeta. Le cose più diverse. Non per colpa loro, non sanno cosa si faccia concretamente nelle varie discipline. Insomma: cosa fa un project manager di giorno? Ecco, ho riunito una trentina di giovani per fare orientamento gratuito, dai giovani ai giovani, in cui raccontiamo le varie professioni con l’esperienza di chi ci è appena passato.
Ed è anche un libro, diceva.
Sì, “La facoltà di scegliere” (Mondadori). All’inizio facevamo eventi locali, poi siamo diventati nazionali anche con piattaforme interattive e sponsor fantastici, Barilla e Tucano. Agli eventi c’erano tavole rotonde per le domande, abbiamo incontrato 1.500 ragazzi da tutta Italia nel primo anno. Poi, siccome la forma online è meno efficace abbiamo deciso di fare il libro e un sito su cui ci sono tutte le risorse. Il libro è molto innovativo anche dal punto di vista del formato. E’ interattivo e alla fine c’è una pagina segreta, scritta in codice, dove c’è il consiglio finale che do ai ragazzi. Ho impiegato tre mesi a scriverla perché il rischio della frase da cioccolatino era dietro l’angolo…
La posso conoscere?
Eh no. No spoiler. Posso solo dire che per avere successo non bisogna essere geniali o ricchi o avere le idee chiare subito. Non c’è bisogno di pensarsi in una sola direzione…
Durante il panel ha detto che non sarà l’Ai a rubare il lavoro ma un uomo che usa l’Ai. Ma è vero che c’è possibilità per tutti? In alcune realtà questo tipo di contenuti è assente.
E’ il motivo per cui la nostra iniziativa è completamente gratuita. Se non si ha la fortuna di aver avuto genitori che hanno frequentato l’università – o comunque l’hanno frequentata trent’anni fa – come fa un ragazzo a capire se fa per lui se neanche sa cosa sia? Per questo servono più strumenti possibili di orientamento e che questo sia più pratico possibile, trasmissibile in poche ore di lezione.
Cosa pensa dell’istruzione italiana rispetto a quella oltreconfine?
Il livello italiano dell’istruzione è molto alto. Il confronto si può fare, ma senza che siano elogi o critiche. Solo constatazioni.
Va bene.
Iniziamo allora dicendo che ci sono differenze rispetto al resto del mondo. In Italia siamo un po’ eterni teoreti, facciamo la teoria di tutto mentre, per dire, gli anglosassoni sono puro empirismo. Forse una via di mezzo sarebbe utile per tutti.
Mi fa un esempio?
In fisica, mentre noi facciamo le dimostrazioni, nel mondo anglosassone vanno in giardino, prendono il metro e misurano quanto impiega la pallina a cadere. Noi siamo molto sistematici e certo serve molta fatica per fare la teoria e questo è a nostro merito. La differenza sta nel fatto che loro sono sì meno sistematici, ma escono dalla scuola che non odiano le materie.
Ed è un buon risultato?
La mia impressione è che spesso i ragazzi escano dalla scuola che già non ne possono più. Gli esami, poi, nel mondo anglosassone sono tenuti non dai docenti dello studente ma da docenti esterni. Questo significa che il docente diventa un allenatore, la persona con cui si è in un rapporto molto più di sinergia che di ostacolo. In questo preferisco il sistema anglosassone che è più sano e rilassato. Infatti le statistiche sui suicidi dei ragazzi la dicono lunga su come è percepito l’ambiente quotidiano. Se il docente è giudice aumenta lo stress.
E nelle università?
Nel sistema Europeo le risorse sono distribuite in maniera omogenea, non ci sono nell’Ue continentale picchi fortissimamente positivi e altri negativi, non ci sono Harvard per intenderci. Questo ha una implicazione sociale ottima perché significa che tutti hanno vicino una università buona e competitiva a livello internazionale. Nel mondo anglosassone il sistema è invece verticistico. Poche università in cui risorse e talento sono molto concentrate. Questo è socialmente meno efficace ma facilità la ricerca. In una sola università ci sono tanti soldi e tanto talento, con sinergie enormi. Due più due in questi casi non fa quattro ma dieci.
La sintesi?
Ognuna ha pro e contro. Non c’è una soluzione.
Il suo sogno?
Dare il mio piccolo contributo alla vita dei pazienti perché non si muoia con queste tremende malattie. Quelle neurodegenerative colpiscono in modo totalmente casuale, non possono essere previste, sono devastanti – l’ho vissuta con mio nonno che è morto per esse – e ci si sente impotenti.
Le sue ricerche in cosa consistono nel dettaglio?
Mi occupo sostanzialmente di biologia molecolare, quindi di meccanismi biologici della malattia. Un esempio è identificare nuovi target, cioè nuove proteine e geni che non sapevamo essere coinvolti nella malattia e che grazie all’Ai possiamo capire avere un ruolo che prima era ignoto.
Come?
Con i dati. Gran parte di ciò che si fa è “insegnare” all’Ai dando degli esempi, ma ovviamente non è facile da fare. L’Ai tradizionale dagli esempi estrae una regola e la applica. Ma qui c’è un piccolo problema: non è facile realizzare dataset in questo ambito. Quindi bisogna operare sul meccanismo, sull’identificazione dei target e quindi sulla creazione dei dataset. Per farlo esistono delle tecniche, le cosiddette “omiche” – in pratica tutto ciò che finisce in “omica” – che sono in grado di produrre big data da un esperimento biologico. Sono ovviamente costose e riflettono uno shift di prospettiva perché la biologia non è quasi mai galileiana.
Temo ci sia bisogno di spiegare con calma a questo punto.
L’esperimento galileiano classico consiste nello scienziato che osserva un fenomeno: gli viene in mente un modello e poi fa l’esperimento per verificare se quel modello è corretto o meno. E se lo è, allora è vero. Nella biologia abbiamo però più di 19mila geni, centinaia di migliaia di pseudogeni. Come li si fa a osservare tutti e a elaborare così tanti modelli? Bisogna trovare il modo di immaginare, con l’Ai, il risultato di un ipotetico esperimento senza farlo perché sono troppi con troppe variabili. In questo modo, si possono prioritizzare i più papabili, da affrontare con esperimenti in laboratorio. Per farlo, servono approcci nuovi.