Green Deal, il professor Chiti: “Equilibri nazionali e interessi economici minano il progetto europeo”

“Il Green Deal ha molti nemici. È sotto attacco da più versanti: da chi gli imputa di eludere il problema di fondo, ovvero il modello economico consolidato in Europa e nel mondo occidentale; da chi lo accusa di fare troppo poco, ad esempio rispetto alla tutela degli ecosistemi; da chi gli contesta di fare male, producendo costi sociali”. Edoardo Chiti è professore di Diritto amministrativo alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e, insieme a Dario Bevilacqua, autore del recente Green Deal. Come costruire una nuova Europa (Il Mulino Editore), nel quale fa il punto, alla vigilia delle elezioni europee, sul Green Deal, “una strategia che merita tutta la nostra attenzione, perché ridefinisce l’agenda politica dell’Unione e la direzione complessiva del processo di integrazione europea”. E che, però, rischia di essere messa in discussione, se non del tutto fermata, dal prossimo Parlamento, se dovessero vincere le destre.
Anzitutto, può spiegarci in cosa consiste il Green Deal?
Ci siamo accorti del Green Deal solo nell’ultimo anno. Ma la Commissione europea lo ha avviato nel dicembre 2019. A volte viene presentato come un singolo atto – ad esempio la Legge europea sul clima – ma il Green Deal è molto di più. È il modo con il quale l’Unione intende contrastare il problema del cambiamento climatico e interessa molti settori, dall’agricoltura all’energia, dalla politica industriale alla tutela degli ecosistemi. Utilizza una varietà di leve, dalle politiche pubbliche al mercato, dalla innovazione alla scienza.
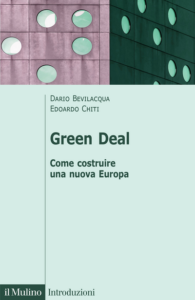 A vostro avviso però trovare un bilanciamento tra interessi economici e ambiente non è facile.
A vostro avviso però trovare un bilanciamento tra interessi economici e ambiente non è facile.
La logica delle politiche europee degli ultimi tre decenni è quella del bilanciamento tra interessi economici, sociali e ambientali. Il Green Deal non mette in discussione questo obiettivo. Anzi, lo conferma. Ma aggiunge anche un obiettivo ulteriore: quello della ‘salute degli ecosistemi’, ovvero la capacità degli ecosistemi di fornire i servizi che sono loro propri. Si tratta di un obiettivo ineludibile di ogni strategia contro il cambiamento climatico. Occorre evitare il collasso degli ecosistemi. E, in positivo, lavorare al loro ripristino. Ma questo impone di dare priorità alla salute degli ecosistemi rispetto agli interessi economici e anche sociali. Come far coesistere il cuore ecologico del Green Deal, il primato della salvaguardia degli ecosistemi, con la logica più tradizionale dello sviluppo sostenibile è una questione per molti versi ancora aperta. Ne sono un esempio le difficoltà che sta incontrando l’adozione della Nature Restoration Law, al momento bloccata da alcuni governi.
Un altro aspetto critico riguarda le perdite sociali derivanti dal Green Deal. Su questo fronte si gioca molta della sua credibilità?
Le varie iniziative che dovrebbero portare alla neutralità climatica dell’Unione hanno un costo sociale alto: incidono e incideranno su molti soggetti deboli, fanno sorgere nuove diseguaglianze. Non è sorprendente, in questo contesto, che il Green Deal sia il bersaglio di molte proteste. Quelle dei trattori, ad esempio. Ma anche, di nuovo, le critiche contro la proposta della Nature Restoration Law, della quale si dice che ridurrebbe la produzione dei prodotti alimentari, provocherebbe una crisi alimentare, farebbe perdere posti di lavoro. Alcune di queste critiche sono evidenti esagerazioni, ma il costo sociale del Green Deal è innegabile.
La risposta offerta dall’Europa è di tipo compensatorio. È sufficiente?
La Commissione europea ricorre a strumenti di compensazione, come il Fondo per la transizione giusta, del 2021, e il Fondo sociale per il clima, del 2023. Strumenti utili, ovviamente. Ma che non sono sufficienti, da soli, a gestire l’impatto sociale del Green Deal. Occorre riconoscere questo impatto e anticiparlo nella costruzione di regolazioni pubbliche in grado di limitare i costi sociali della transizione. Ma bisogna anche essere consapevoli del fatto che il cambiamento climatico ha già – e avrà in misura sempre maggiore – un forte impatto sociale. Dunque: non è ignorando il cambiamento climatico e preservando lo status quo che si evitano i costi sociali.
Esiste, rispetto al Green Deal, il rischio di greenwashing? Ad esempio, l’aver considerato fonti pulite nucleare e gas non è una contraddizione?
Come ogni strategia politica fortemente innovativa, il Green Deal innesca mille processi di normalizzazione e neutralizzazione. Il greenwashing è uno di questi processi. Può essere intenzionale o inconsapevole. E si svolge su più piani: quello politico e quello economico, anzitutto; ma anche quello culturale, come dimostra il ricorso sempre più acritico al lessico della sostenibilità. Non qualificherei come greenwashing, però, l’inclusione del nucleare e del gas tra le fonti sostenibili sul piano ambientale.
Perché?
Sottolineo due aspetti. Il primo è che nucleare e gas sono stati considerati fonti sostenibili nello specifico contesto della cosiddetta tassonomia europea, che è solo un tassello del Green Deal. Il secondo aspetto è che l’ordinamento europeo ha gli strumenti per discutere criticamente la questione più generale della rilevanza del nucleare nella strategia del Green Deal. Sin qui, abbiamo visto all’opera soprattutto i governi. Ma conosceremo presto il punto di vista della Corte di giustizia. E iniziamo a sentire la voce dello European Scientific Advisory Board on Climate Change, chiamato a portare nella discussione il punto di vista della scienza.
Come si pone il Green Deal europeo rispetto a quelli di altri Paesi?
Collaborazione e competizione si intrecciano in molti modi. Le esigenze di collaborazione sono ovvie, considerato che il cambiamento climatico è un problema globale. Allo stesso tempo, la competizione tra i diversi Green Deal è inevitabile, perché la diversità tra gli obiettivi può essere utilizzata strategicamente, per rafforzare un’economia nazionale a scapito delle altre.
Non esiste forse una contraddizione tra l’accentrare le decisioni a livello sovranazionale e l’affidarne la realizzazione agli Stati, che spesso fanno resistenza (basti vedere il nostro)?
Molte delle politiche e le regolazioni pubbliche elaborate dall’Unione europea camminano sulle gambe degli Stati. Lo strumento attraverso il quale le misure andrebbero individuato è quello dei piani nazionali. È una scelta ambivalente. Per un verso, è perfettamente ragionevole: la complessità delle politiche di contrasto al cambiamento climatico è tale da richiedere l’azione delle istituzioni politiche e amministrative nazionali. Per altro verso, la Commissione affida agli Stati un compito quasi impossibile. È la stessa Commissione a riconoscerlo.
Qual è infine la sua previsione per le elezioni europee? Si rischia che un piano così importante e anche visionario venga messa in discussione?
A mio avviso, il suo destino dipende essenzialmente dal nome di chi presiederà la prossima Commissione. L’altra grande variabile è la guerra in Ucraina e il moltiplicarsi dei conflitti. Il Green Deal è un progetto per tempi di pace.

