Restare vivi, il libro di Valentina Barile sulla Colombia è un piccolo dizionario di resistenza
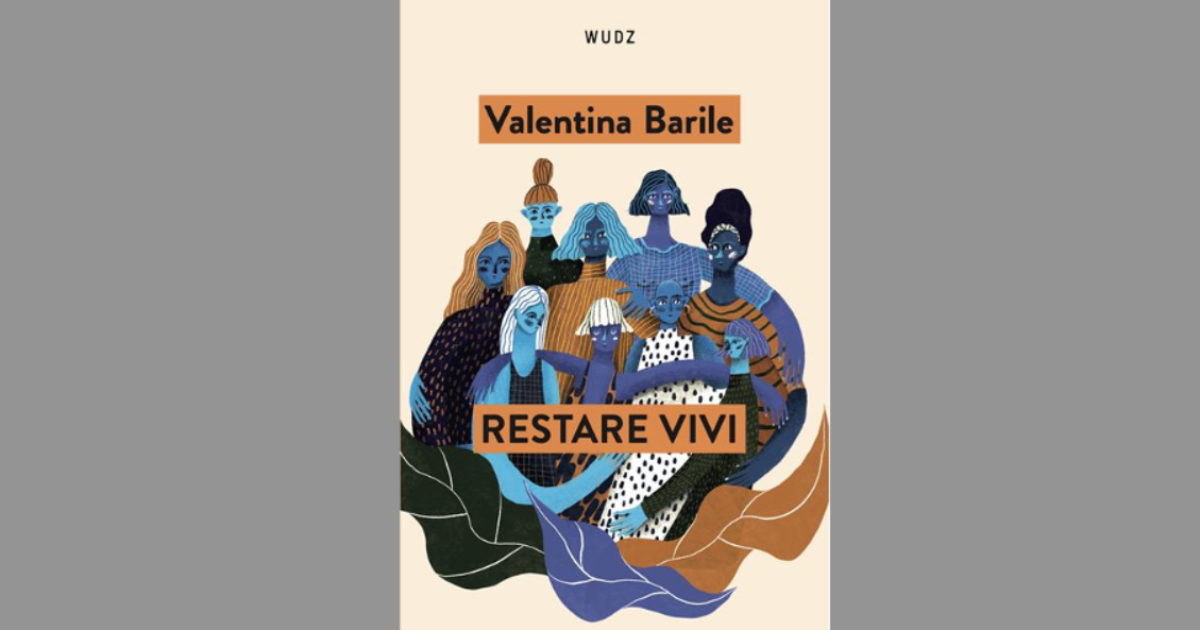
“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo”, ho pensato a questa frase di Che Guevara quando ho conosciuto la giornalista Valentina Barile, in libreria con Restare vivi, edito dalla neonata e combattente casa editrice Wudz.
Un “piccolo dizionario di resistenza”, come cita il sottotitolo, che non a caso vanta la premessa di Aleida Guevara March, prima figlia del Che, che a proposito del libro si domanda: “Saprete essere sensibili di fronte alla cruda verità raccontata in queste pagine? Spero di sì”. Questo perché “Restare vivi” ci costringe a mantenere lo sguardo proprio lì dove non vogliamo guardare e lo fa con la forza di una scrittura asciutta che sa raccontare la sofferenza senza mai indulgere nella disperazione.
Il libro è un viaggio nel “corridoio della droga”, una lingua di terra in Colombia dove contadini, femministe, sciamani, narcotrafficanti e guerriglieri sono in guerra da Sessant’anni. Una guerra che conta milioni di morti e milioni di desaparecidos. E come dice la stessa Barile, nel prologo del libro, ciò che resta di questo viaggio è la pervivencia, una parola che tiene insieme donne e uomini che “vivono combattendo per se stessi e per gli altri, in silenzio o a voce alta, contro lo Stato, la guerriglia e il narcotraffico”.
Una parola che rappresenta la determinazione a non abituarsi alle ingiustizie, in un paese dove si muore senza sapere nemmeno il perché, ma dove ci sono uomini che lottano ogni giorno per mantenere viva la memoria di chi non c’è più chiedendo verità e giustizia. La stessa verità e la stessa giustizia che stanno chiedendo per Mario Paciolla, trovato morto in Colombia il 10 luglio 2020, dove operava per l’Onu per far rispettare gli accordi di pace tra governo e guerriglieri delle FARC. Un caso che sembra interessare più ai colombiani che agli italiani, vista la nuova richiesta di archiviazione del caso da parte della procura di Roma.
Una parola forse racchiude il senso di questo lavoro: pervivencia.
Gli esseri viventi che ho incontrato in Colombia sono tutti dei pervivientes, e dico esseri viventi perché a resistere al conflitto armato e ai traffici illegali non sono solo gli umani, ma anche gli animali, gli alberi e tutte le creature viventi: i nativi traferiti in maniera forzata, deprivati dei propri territori, ammazzati, gli animali selvatici venduti insieme al legname di contrabbando, all’oro, al coltan, allo sfruttamento minerario più in generale. Il senso di pervivencia, che racchiude la lotta politica e sociale di resistenza compiuta da intere collettività, coinvolge dunque anche gli esseri non viventi.
L’ultimo capitolo del libro è dedicato a Mario Paciolla, cosa pensi della nuova richiesta di archiviazione?
Penso che dietro l’assassinio di Mario Paciolla in Colombia vi siano dinamiche, scelte, azioni che sono state purtroppo messe in atto perché il suo lavoro è stato efficace ma politicamente strumentalizzato, e l’Onu, organizzazione nata per costruire la pace tra paesi e popoli del mondo, con il passare del tempo ha evidentemente e praticamente perso la sua mission iniziale. L’Onu non ha protetto Mario dalla scacchiera macabra in cui si è ritrovato senza forse rendersene conto, o per meglio dire, lo aveva cominciato a comprendere molto bene qualche mese prima e ancor di più nell’ultima settimana angosciante che ha vissuto prima che il suo corpo fosse ritrovato senza vita.
Non sappiamo se sia stata l’organizzazione a metterlo nei guai, come sostiene Julieta Duque, la giornalista colombiana che sta indagando sul suo assassinio, o se l’organizzazione stessa non sia comunque riuscita a proteggerlo da qualcuno o qualcosa. Insomma, l’Onu c’entra in qualche modo. È fin troppo chiaro. E il fatto che in Italia, la procura di Roma abbia deciso per la seconda volta l’archiviazione del caso dopo poco più di sei mesi che ne era stata chiesta di nuovo la riapertura è davvero surreale, ma soprattutto avvilente perché si tratta di un caso internazionale che va trattato prima di tutto con serietà professionale.
Cosa ti manca di più di quei luoghi e di quelle persone?
I luoghi e le persone. La sintonia che esiste fra gli esseri viventi. L’attenzione, la cura, il sentire. Il tempo che sembra dilatarsi perché diventa fondamentale l’adattarsi all’imprevisto. Non è possibile rispettare i piani di lavoro, gli incontri, gli appuntamenti, le consegne perché non si sa se è possibile o meno raggiungere un villaggio o una città negli orari che prestabiliti, programmati, per infinite e svariate ragioni che possono essere meteorologiche, di sicurezza, diplomatiche fra società civile, istituzioni e gruppi armati. Quel restare vivi nonostante il dolore, quella speranza che si annida nella parola pervivencia, che è spiegata molto chiaramente da Aleida Guevara March, nella prefazione.
Cosa hai imparato da questo viaggio e cosa credi d’aver lasciato a queste persone?
Chi fa il mestiere di scrivere ha un compito molto importante, cioè quello di mettere da parte la propria personalità e diventare mezzo attraverso cui veicolare la realtà che osserva, ciò che accade davanti ai propri occhi o che lo sguardo e le gambe vanno a cercare. Come giornalista credo di aver lasciato nei loro cuori la speranza che quel loro dolore sarebbe stato condiviso a chilometri e chilometri di distanza; solo questo mi è possibile fare, purtroppo. Che il dolore raccontato e il riscatto e la giustizia che loro attendono possano arrivare dall’altra parte dell’oceano e raggiungere quella società occidentale così ancora tanto lontana, nonostante i social e la cittadinanza globale attiva.
Ciò che invece ho il privilegio di custodire sono la grazia e gli insegnamenti che mi hanno donato e che ho appreso dalle persone che ho conosciuto e che mi hanno guidato durante il viaggio.