Un femminicidio insabbiato dal fascismo svelato dopo 90 anni: l’ultimo libro del giornalista Palazzolo
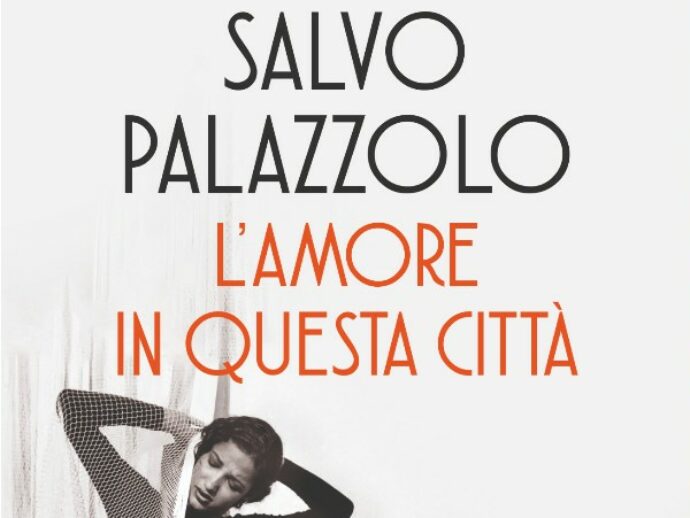
Un femminicidio commesso quando ancora quella parola non esisteva. Un duplice assassinio insabbiato dal fascismo, un’indagine depistata forse per ordine degli uomini rampanti del regime. È una storia dimenticata quella contenuta nell’ultimo libro del giornalista Salvo Palazzolo, inviato di Repubblica, autore di numerosi saggi e molti scoop su Cosa nostra e i suoi legami con la politica. Questa, però, non è una vicenda di mafia, anche se L’amore in questa città (Rizzoli) racconta comunque una storia esclusiva. Nonostante arrivi a quasi novant’anni dai fatti. Ma andiamo con ordine.

Il libro racconta la storia di Maria Concetta Zerilli, detta Cetti, vent’anni, studentessa universitaria, iscritta al secondo anno di Lettere. Viene trovata morta la mattina del 17 settembre del 1935 nelle stanze che oggi ospitano gli archivi della facoltà di Giurisprudenza di Palermo. La uccidono con tre colpi di pistola e accanto al suo corpo c’è anche un altro cadavere, in camicia nera e stivaloni: è quello del trentenne Vincenzo Mortillaro. Vicino ai due corpi, una pistola e alcuni bigliettini con scritto: “Fu la mia amante ma pazza. Mortillaro“. Insomma la scena del delitto sembra suggerire un quadro ben preciso. “La polizia si affrettò a dire che era un caso di omicidio-suicidio. E il regime impose ai giornali la censura sull’intera vicenda”, racconta Palazzolo, abile a mixare i risultati di una lunga indagine giornalistica alle sue capacità narrative.
Anche se la stampa dell’epoca non scrisse un rigo, infatti, quel caso era tutt’altro che chiuso. Più di qualcosa in quel duplice delitto non tornava. Nel corpo di Mortillaro, per esempio, c’erano due proiettili: chi è che si suicida sparandosi due volte? E ancora: in teoria l’omicidio-suicidio era avvenuto a tarda sera. Ma nei locali dell’armeria della Coorte universitaria, dove furono trovati i corpi, era buio: come si fa a spegnere la luce dopo essersi tolti la vita? Anche per questo il padre della ragazza non si rassegnò alla versione ufficiale e cominciò a inviare esposti su esposti alle autorità. Lettere rimaste inascoltate, che costarono al signor Zerilli l’antipatia del regime: nel 1937 l’uomo finirà addirittura in carcere durante la visita di Benito Mussolini in Sicilia.
Sulla vicenda cala il silenzio, ma un cronista del Giornale di Sicilia inizia a indagare, anche se è consapevole che non potrà scrivere nulla. Si chiama Nino Marino e anni dopo racconterà questa storia a uno dei suoi allievi, Aurelio Bruno. Nato nel 1922, aveva cominciato a fare il giornalista nel 1940 a L’Ora, il mitico quotidiano del pomeriggio. Anni dopo sarà l’autore dello scoop sull’avvelenamento in carcere di Gaspare Pisciotta, cugino e braccio destro del bandito Salvatore Giuliano. Nominato cavaliere della Repubblica dal presidente Giovanni Leone, Bruno era il decano dei cronisti di nera e giudiziaria a Palermo. Fino alla sua morte, avvenuta nel 2015 a 93 anni, era sempre disponibile con i giovani colleghi, dispensando consigli e aneddoti.
A Palazzolo, per esempio, ha raccontato dell’omicidio di una studentessa universitaria, insabbiato dal regime. “Vent’anni fa, è stato Bruno a raccontarmi il caso di Maria Concetta Zerilli. Ed è stato lui a sollecitarmi a riprendere le fila di una vicenda molto intricata”, spiega l’autore. In questo senso, si può dire che il libro è il frutto di un’inchiesta compiuta da cronisti di tre generazioni diverse nell’arco di quasi un secolo. Una sorta di staffetta giornalistica, con il testimone passato da Marino a Bruno e dunque a Palazzolo, che negli ultimi anni ha scandagliato gli archivi storici e i vicoli del centro di Palermo a caccia dei pezzi mancanti: uno spunto, una traccia da seguire.
Pezzo dopo pezzo, l’autore del libro ha rimesso insieme la storia dimenticata di Cetti Zerilli. Si è messo in contatto con gli eredi della vittima, ha trovato il vecchio fascicolo dell’indagine insabbiata e perfino le lettere della giovane sequestrate dall’autorità giudiziaria e mai restituite alla famiglia. La ragazza non aveva alcun legame sentimentale con Mortillaro, ma era l’amante di un alto gerarca che in seguito avrebbe fatto carriera. Quella non era la storia di un’indagine condotta male, ma di un’inchiesta depistata, un femminicidio insabbiato per ordini probabilmente arrivati dall’alto. “Bruno mi raccontò che a Palermo arrivò un esponente autorevole del Partito fascista per insabbiare definitivamente il caso”, spiega sempre l’autore del libro. Che durante le ricerche ha scoperto anche come un onesto giudice istruttore avesse provato a cercare la verità, ma poi si era dovuto arrendere ai risultati delle indagini depistate dalla polizia. Quel magistrato si chiamava Nicola Franco, lo stesso nome e cognome di un funzionario della Direzione investigativa antimafia che per trent’anni ha cercato la verità sulle stragi di Capaci e di via d’Amelio. “L’ho chiamato subito, per chiedergli di questa omonimia: Era mio nonno, mi ha detto”, scrive Palazzolo nel libro.
Alla fine di un lungo lavoro di ricostruzione e scrittura, il giornalista ha ancora un quesito da risolvere. “Mi sarebbe piaciuto raccontare al cavaliere Bruno che avevo trovato una traccia per seguire i passi del cronista Nino Marino, che fu testimone pure lui. E avevo ancora una cosa da chiedergli: perché Marino non scrisse mai di Cetti Zerilli? Questa domanda continua a tormentarmi”. Perché, infatti, la storia di quel delitto rimase segreta anche dopo la caduta del regime? “Forse – è un’ipotesi – perché i protagonisti di quella storia erano riusciti a restare a galla nell’Italia postfascista e contavano ancora?”, ipotizza Palazzolo. “Per certo – continua – uno dei funzionari di polizia che più si era impegnato per la versione del regime, bistrattando i familiari della giovane uccisa, divenne questore di Palermo nel dopoguerra. O forse il cronista Marino voleva solo lasciare in pace la povera Cetti, che aveva sofferto già troppo?”. Una risposta a queste domande probabilmente non arriverà mai. Ma del resto anche la storia del femminicidio di Cetti Zerilli sembrava perduta. Invece per avere la verità è bastato aspettare quasi un secolo, tre generazioni e un cronista accurato e tenace.

