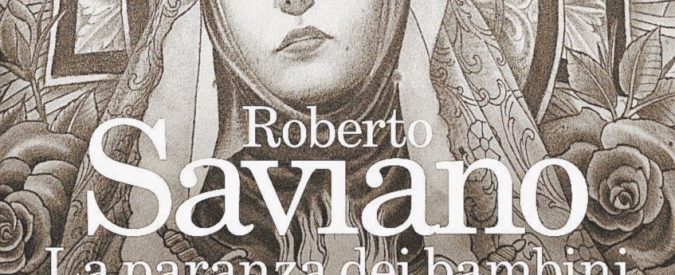Ma quale paranza, vorrebbero esse ’na paranza… ma sono piscitelli di cannuccia”. A Secondigliano i ragazzini, i bambini, hanno perfettamente idea di come si muore. E di com’è meglio morire. Lo raccontava Roberto Saviano nel libro che lo ha fatto diventare Roberto Saviano. Dieci anni – e milioni di copie – dopo il ragazzo di Gomorra è diventato grande e torna in libreria con altri ragazzini, una nuova paranza e soprattutto una maturità diversa.
La paranza dei bambini è un romanzo, dove l’io narrante “si leva da mezzo” e fa posto a un narratore in terza persona. Non è un ibrido tra fiction e cronaca, è un romanzo-romanzo in cui l’autore si prende (finalmente) la libertà di creare. Personaggi, situazioni, relazioni. Lo spazio è sempre Napoli, quartiere Forcella, il tempo tre anni della vita di dieci ragazzini che attraversano il guado tra infanzia ed età adulta e diventano una paranza. Cos’è? Tradurlo in baby-gang non rende l’idea. “Paranza” è il nome di una barca per la pesca a strascico e come i pescatori cacciano i pesci, questi ragazzini cercano soldi. E gente da ammazzare.
I suoi paranzini sono adolescenti normali, non sottoproletari, non hanno famiglie disastrate, esistenze già segnate. Eppure scelgono la parte oscura della forza.
Sul piano del metodo ho cercato di miscelare caratteri che avevo trovato in diverse inchieste giudiziarie. Per Nicolas, il capo, mi sono ispirato a due persone: il capo di una paranza di fuori Napoli ed Emanuele Sibillo, il vero fondatore della paranza dei bambini, morto a 19 anni. Il fratello è stato condannato giovedì: in udienza con altri imputati ha minacciato e insultato Henry Woodcock. Gli hanno detto cose pazzesche.
Fanno paura infatti.
Mentre nella cronaca sono definiti unicamente dai loro atti, s’identificano in ciò che fanno, nel racconto restano esseri umani. Sembrano belve, ma sono persone. Anche se è vero, sono violentissimi. Quando stanno per arrestare Emanuele Sibillo, lui manda un sms a quello che gli fa da palo dicendo: “Spara a qualcuno a caso”. Per fermare la pattuglia che stava andando da lui: una ferocia inaudita. Detto ciò, i paranzini sono ragazzi normali, che hanno desideri e pulsioni comuni. Quasi tutti sono piccolo-borghesi, dormono accanto ai genitori, vanno a scuola, hanno la ragazza a cui mandano cuoricini e messaggi amorevoli.
Gli adolescenti hanno sempre dei modelli e degli status symbol. Ma i paranzini fanno di tutto per una maglietta della Nike. A costo di ammazzare.
Il loro idolo è uno come Dan Bilzerian, il tizio che ha vinto 100 milioni a poker e si fa fotografare tra elicotteri e yatch, belle donne seminude e mitra. Loro vivono per avere soldi, bei vestiti, cose. Perché? Perché hanno una disperata consapevolezza: non arriveranno mai a quel livello di vita contando sul lavoro, sul talento, sul merito. Il merito è una messa in scena. Il mondo che vedono è quello dove con una app di trading on line in un minuto guadagni mille euro. O dove chi arriva al potere ha rubato, tradito, ingannato. Pensare che un obiettivo si raggiunge con l’impegno è impossibile. Nicolas “si leva” la droga, cioè spaccia, ma della droga non gliene frega nulla. Ogni tanto si fa una canna, ogni tanto una striscia. Ma è accidentale. Gli serve per fare cash, la droga è il bancomat.
Un personaggio si chiama 0 Briatò.
Quando vado nello scuole e chiedo agli studenti chi vorrebbero essere mi sento rispondere “Briatore”. Non hanno bene in testa cosa faccia, ma sanno che qualunque cosa faccia se la gode, magari fregandosene delle regole.
C’è un altro lato sconvolgente: nessuno pensa a se stesso da adulto.
Fanno tutto in fretta: Emanuele Sibillo a 19 anni si era già sposato, aveva già un figlio, aveva in mano mezza economia del lungo mare di Napoli. Tra questi ragazzini c’è anche grande talento, acume, intelligenza. Non sono geni del male: hanno le armi da guerra, ma mandano i cuoricini alle fidanzate. Sanno che vanno a morire o che faranno vent’anni di galera. Però i prossimi tre sono gli anni della gloria. Il premio è questo.
Non è facile maneggiare questi piccoletti cattivi senza sembrare tromboni o patetici.
Se conosci questi ragazzi resti immediatamente abbagliato dalla loro vitalità: crescono dovendo colmare dei vuoti con la creatività, la furbizia, la rapidità. Da un lato sei ammirato, dall’altro provi repulsione: loro cercano sempre di misurare la tua debolezza. La scelta del narratore in terza persona dipende da questo: non volevo puntare il dito contro i paranzini, ma nemmeno volevo prendere le loro parti. Ho fatto un passo di lato per poter tenere la complessità dei loro comportamenti.
Perché le piace così tanto il male?
Non credo nella possibilità di una giustizia. Cito sempre una frase di Vasilij Grossman, in Vita e destino: “Non credo nella giustizia perché in suo nome sono stati commessi i crimini peggiori”. Sono convinto che raccontando queste ferite si possa svelare la radice, credo che possa essere utile. La dinamica che così si svela serve a capire.
Non c’è speranza nel mondo che racconta.
Questi ragazzi non hanno avuto speranza. Oggi chiunque pensa di poter trasformare il mondo attraverso l’impegno viene deriso: vince chi ha i soldi, i soldi sono la meta. Non è vero che c’è una possibilità di emancipazione. Se c’è, è nella comprensione. Non credo che questi “colpevoli morti innocenti”, come li ho chiamati nella dedica, si salvino con le ricette di cui ogni tanto sentiamo parlare: intendo tenere le scuole aperte al pomeriggio o affidarsi al volontariato. Corrado Alvaro dice che la disperazione più grande di un popolo è quando si pensa che vivere onestamente sia inutile. I paranzini sono così: chi lavora è strunz, ammirano l’Isis, si tengono le barbe lunghe perché nel loro immaginario incutono timore. In un’Italia meno ossessionata dal dire che va tutto bene, questi segnali sarebbero analizzati. Invece questo racconto è una macchietta, è il cliché napoletano.
Su Repubblica il professor Asor Rosa ha scritto: “Le pagine più direttamente narrative del romanzo son dominate dall’uso pressoché assoluto del dialetto (lingua?) napoletano”.
Ho chiesto aiuto a due professori, Nicola De Blasi, di Napoli, e Giovanni Turchetta, di Milano. Il libro non poteva essere scritto in italiano e nemmeno in napoletano. Intendo: leggere Eduardo è difficilissimo perfino per un madrelingua. Così ho dovuto inventare una lingua accessibile e verosimile, un napoletano comprensibile che tenesse anche conto delle infinite contaminazioni del nostro presente: dalla tv ai social. Mondi che fanno parte del vissuto quotidiano dei ragazzini.
In un’intervista al Fatto, l’hanno scorso, aveva detto che si scrive per “perdere qualcosa. Sicurezze, stabilità, serenità, reputazione”. Qualche giorno fa ha precisato: “Scrivo per vendetta”. Contro chi?
Verso tutti quelli che credono ci sia stata da parte mia manipolazione, forzatura, esagerazione. Non mi avete fatto male, né mi avete fiaccato: continuo a guardare quella zona d’ombra. E la racconto.