Dietro la domanda di sovranità che costituisce il nucleo dell’attuale rinascita del populismo, in Europa e non solo, ci sono malesseri comprensibili e argomenti che perfino l’establishment contestato dai populisti ora riconosce: il disagio per le conseguenze della globalizzazione, l’uniformità di idee e programmi tra i partiti tradizionali, disuguaglianze crescenti non più giustificabili come necessità per garantire un aumento del benessere anche per le parti più deboli della società. Questa richiesta di “contare”, di avere un ruolo, si declina in varie forme nei diversi Paesi, ma non svanirà anche con qualche decimale di Pil in più e di disoccupazione in meno. Perché si alimenta di una sfiducia strutturale e profonda verso un sistema di partiti, Parlamenti, élite e istituzioni internazionali, considerato non riformabile, non importa quali promesse vengano fatte in campagna elettorale.
Domande e dubbi legittimi, che però hanno pericolosi effetti collaterali. Nel contestare i risultati delle procedure democratiche, i sovranisti si ritrovano spesso a rimettere in discussione le procedure stesse della democrazia rappresentativa: il meccanismo della delega, l’importanza del compromesso tra posizioni diverse, la separazione dei poteri, la complessità della politica e la necessità della competenza per garantire l’autonomia della decisione politica dagli interessi particolari. Questa sfiducia nella democrazia ha contagiato tutti i partiti. Il populismo è sempre piú “sovrano” non solo perché si alimenta della domanda di sovranità, ma perché ha vinto. Tutti sono diventati populisti, come dimostra la propensione crescente di leader espressi da partiti tradizionali a ricercare una legittimazione plebiscitaria nel ricorso al più populista degli strumenti decisionali, il referendum, che riduce tutto a una scelta tra Sì e No. Il fatto che poi questi leader disposti a giocarsi alla roulette del referendum la propria sopravvivenza di solito vengano sconfitti, sembra intaccare poco la loro convinzione che bisogna appagare la fame di sovranità del popolo dandogli almeno l’illusione di decidere.
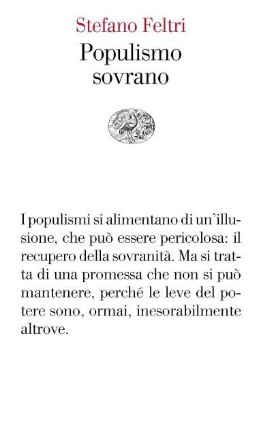 La tentazione di cancellare secoli di procedure costruite a garanzia delle minoranze, protette dallo Stato di diritto e non dalla mera decisione a maggioranza, si diffonde anche tra gli intellettuali. C’è sempre stato un filone di argomentato scetticismo nei confronti della capacità della democrazia di mantenere le proprie promesse, ma ora certe provocazioni iniziano a sembrare proposte in cerca di qualcuno abbastanza radicale da attuarle: il ritorno al sorteggio, come nell’Atene antica, per gli incarichi pubblici, la restrizione del suffragio universale (applicata per via burocratica, poiché non è percorribile per una esplicita modifica normativa) in modo da ridurre il peso degli elettori poco informati o viziati da pregiudizi, la realizzazione di una Repubblica dei filosofi come quella autoritaria immaginata da Platone, che prenda la forma contemporanea di esperti al potere che governano senza dover ottenere il consenso a essere eletti o rieletti. Oppure quella degli organismi tecnici che hanno il compito di approvare o bocciare le decisioni della politica: il Fiscal Compact sul pareggio di bilancio prevede, tra l’altro, l’istituzione di autorità indipendenti chiamate a validare i numeri e le politiche economiche dei governi dei singoli Paesi e la Germania chiede da tempo una struttura analoga a livello europeo, per punire in anticipo e in modo automatico i Paesi che adottano politiche giudicate irresponsabili.
La tentazione di cancellare secoli di procedure costruite a garanzia delle minoranze, protette dallo Stato di diritto e non dalla mera decisione a maggioranza, si diffonde anche tra gli intellettuali. C’è sempre stato un filone di argomentato scetticismo nei confronti della capacità della democrazia di mantenere le proprie promesse, ma ora certe provocazioni iniziano a sembrare proposte in cerca di qualcuno abbastanza radicale da attuarle: il ritorno al sorteggio, come nell’Atene antica, per gli incarichi pubblici, la restrizione del suffragio universale (applicata per via burocratica, poiché non è percorribile per una esplicita modifica normativa) in modo da ridurre il peso degli elettori poco informati o viziati da pregiudizi, la realizzazione di una Repubblica dei filosofi come quella autoritaria immaginata da Platone, che prenda la forma contemporanea di esperti al potere che governano senza dover ottenere il consenso a essere eletti o rieletti. Oppure quella degli organismi tecnici che hanno il compito di approvare o bocciare le decisioni della politica: il Fiscal Compact sul pareggio di bilancio prevede, tra l’altro, l’istituzione di autorità indipendenti chiamate a validare i numeri e le politiche economiche dei governi dei singoli Paesi e la Germania chiede da tempo una struttura analoga a livello europeo, per punire in anticipo e in modo automatico i Paesi che adottano politiche giudicate irresponsabili.
La richiesta di sovranità indica una crisi di fiducia nel sistema a cui bisogna rispondere partendo dal presupposto che certi valori fondamentali non sono più così condivisi, come dimostra la ricorrente tentazione in vari Paesi di affidarsi all’“uomo forte” (il modello è Vladimir Putin) o la disponibilità di larghe parti dell’elettorato ad accettare sostanziali limitazioni dello Stato di diritto in nome di una presunta maggiore sicurezza (è il caso della Francia, dove lo “stato di emergenza” seguito agli attentati islamisti è diventato la nuova normalità).
Non è facile rispondere a questo scetticismo strutturale, perché la democrazia rappresentativa si fonda su una serie di illusioni condivise, da quella sull’eguale importanza di ogni singolo voto alla teorica possibilità paritaria di competere per ogni carica elettiva, alla tutela delle minoranze, alla possibilità di decidere davvero nelle urne chi governerà. L’unico modo per rispondere all’attacco sovranista alla democrazia rappresentativa è usare quello che il filosofo americano David Estlund chiama “l’approccio epistemico”: il valore della democrazia non sta soltanto nel reggersi su un principio che tutti possono accettare (le decisioni si prendono a maggioranza), ma nella sua capacità di produrre risultati migliori rispetto ad altri sistemi. Decidere a maggioranza, in fondo, è un metodo come un altro: tutti percepiscono una certa equità perché sanno che se oggi possono trovarsi in minoranza su una certa decisione, domani magari invece faranno parte della maggioranza. E quindi non c’è una discriminazione, prevale l’opinione più condivisa. Però, osserva David Estlund, anche decidere lanciando una moneta è un metodo che garantisce a tutti equità: nessun gruppo organizzato può influenzare il processo decisionale, nessun lobbista può interferire. L’Italia deve uscire dall’euro? “Testa” rimane, “croce” se ne va. Se vogliamo sostenere che la democrazia rappresentativa fondata sulla delega e il Parlamento è meglio del lancio della moneta – o di un referendum consultivo – dobbiamo dimostrare che produce decisioni di una qualità superiore, che il dibattito e la mediazione che solo i partiti e il Parlamento possono garantire permette di approdare a un risultato di maggiore soddisfazione per tutti. Finora i partiti tradizionali non hanno neppure provato a impegnarsi in questo difficile compito che richiede modifiche delle procedure parlamentari, una maggiore apertura alle proposte della società civile, grande trasparenza.
L’approccio è stato, in Italia come in Europa, l’arrocco: usare regolamenti e tattiche parlamentari per minimizzare le conseguenze dell’improvvisa presenza massiccia di deputati eletti da schieramenti populisti o comunque di protesta. Il prevedibile risultato è stato quello di aumentare lo scetticismo sulla capacità di questa politica di rinnovarsi da sola. Ma senza affrontare i sovranisti con l’approccio “epistemico”, cioè cercando di dimostrare che pratiche e istituzioni screditate possono garantire risultati decisionali migliori rispetto alle scorciatoie sovraniste, la battaglia in difesa della democrazia rappresentativa sarà persa.
