Quando ero bambina la notte era più scura, e in particolare lo era nel vicolo dietro casa mia: l’ultimo lampione del parcheggio e il primo della piazza non riuscivano a illuminarlo e il buio lì diventava di un nero quasi liquido. Arrivavo davanti a quella stradina ogni sera, la dovevo attraversare per forza se volevo tornare a casa, e ogni sera avevo la stessa paura, anzi, forse ogni volta un po’ di più. Ma attraversarlo era l’unico modo, quindi era necessario. Allora mi fermavo nel parcheggio, ancora nella luce del lampione, e prendevo un grande respiro. Poi iniziavo a correre. Stringevo le braccia al corpo, respiravo veloce mentre il cuore mi batteva fortissimo, e socchiudevo gli occhi attraversando il buio. In quei pochi passi, infiniti, immaginavo i mostri dell’orto vicino che si risvegliavano dalle loro tombe, cadaveri con la pelle decomposta che si arrampicavano sul muro basso per allungare le loro mani putrescenti su di me, per afferrarmi e portarmi nel buio, con loro.
 All’epoca non lo sapevo, ma quello che stavo vivendo era il meccanismo combatti-o-fuggi. La reazione a un segnale di pericolo, infatti, stimola una parte molto antica del nostro cervello: l’amigdala, che attiva una cascata di risposte fisiche (aumenta il ritmo del respiro e del battito cardiaco, siamo in generale più vigili e pronti a scattare). Ma prima di prendere una decisione, il nostro cervello codifica lo stimolo anche tramite l’ippocampo e la corteccia prefrontale, che costituiscono il circuito “razionale”, e che analizzano il contesto in cui ci troviamo, integrando la realtà con lo stimolo emotivo. Nel caso in cui stiamo guardando un film o stiamo leggendo un libro, questo sistema inibirà l’amigdala, trasformando la paura in eccitazione.
All’epoca non lo sapevo, ma quello che stavo vivendo era il meccanismo combatti-o-fuggi. La reazione a un segnale di pericolo, infatti, stimola una parte molto antica del nostro cervello: l’amigdala, che attiva una cascata di risposte fisiche (aumenta il ritmo del respiro e del battito cardiaco, siamo in generale più vigili e pronti a scattare). Ma prima di prendere una decisione, il nostro cervello codifica lo stimolo anche tramite l’ippocampo e la corteccia prefrontale, che costituiscono il circuito “razionale”, e che analizzano il contesto in cui ci troviamo, integrando la realtà con lo stimolo emotivo. Nel caso in cui stiamo guardando un film o stiamo leggendo un libro, questo sistema inibirà l’amigdala, trasformando la paura in eccitazione.
Questa esperienza, prima di studiarla all’università durante il mio percorso di laurea in Neuroscienze, l’ho vissuta in prima persona e soprattutto è stata uno dei motori della mia infanzia: da piccola era ossessionata dai luoghi spaventosi del paese in cui passavo le estati – posti che se vedessi adesso non mi farebbero alcuna paura – e il terrore era una sfida aperta e costante, che nutrivo e coltivavo con film e libri.
Il primo film horror che sono riuscita a vedere, a dieci anni – sfruttando l’evidente difficoltà di mio padre di rimanere sveglio davanti alla televisione – è stato Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez, in cui Quentin Tarantino e George Clooney interpretano i fratelli Gecko, due criminali in fuga dalla polizia che devono raggiungere il loro contatto in Messico al Titty Twister, un locale per camionisti che in realtà è un covo di vampiri. E credo che sia stato quello a far sbocciare una volta per tutte il mio amore per i mostri.
Dopo quella visione – che assume nella mia memoria una dimensione mistica – sono andata alla ricerca dei vampiri anche nei libri. E il primo incontro letterario è stata Carmilla di Le Fanu, un racconto in cui la protagonista, Laura, viene affascinata da una ragazza eterea e bellissima, che chiede ospitalità nella sua casa – in cui la ragazza vive con il padre – finché la madre non sarà tornata a prenderla. In questa storia è chiarissimo il fascino del Male, dell’oscuro, che ci attrae ma allo stesso tempo ci respinge (e in questo gioca un ruolo fondamentale la paura: che è un meccanismo conservativo, una difesa naturale che abbiamo contro il pericolo). Eppure, è impossibile non essere attratti da questa bellezza così oscura.
E tra i mostri che ho incontrato nel mio cammino nell’horror è impossibile non citare Dracula che, oltre a essere terribilmente affascinante come figura letteraria, è particolarmente bello anche nella sua forma umana – Gary Oldman nel film di Coppola –; e ancora i vampiri di Anne Rice, nella saga che inizia con Intervista col vampiro e costruisce una rete di personaggi, tormentati e oscuri, che sono molto più vicini all’umano che al mostruoso.
Ma la chiave di volta è stato Frankeinstein di Mary Shelley, che è l’emblema della solitudine e del disagio che provoca il rifiuto altrui. Ed è qui che per me il mostro ha cambiato segno: la creatura non è più il Male assoluto, l’oscurità, ma è un essere che è venuto al mondo nella mancanza dell’amore di chi lo ha creato. Come si può non provare pena per lui? E come non amarlo?
Sono andata, quindi, alla ricerca di questo lato incompreso dei mostri e, inaspettatamente, l’ho trovato in Cujo, il libro di Stephen King. Quando viene morso da un pipistrello, Cujo inizia la sua trasformazione, causata dal virus, ma la cosa più commovente è la sua consapevolezza del cambiamento: lui sa che sta diventando un “CANECATTIVO” e pur di non fare del male si allontana dal BAMBINO, l’essere umano per cui tempo prima avrebbe dato la vita. Ed è la discesa verso la follia, vissuta tramite il pensiero di un cane, che è uno degli ingredienti che mi fa amare così tanto questo libro.
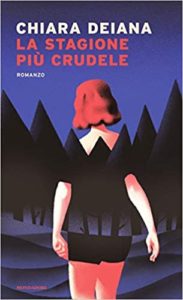 Mentre scrivevo La stagione più crudele, mi sono interrogata moltissimo sul fascino che il Male e i mostri esercitano su di me, e mi sono domandata quanto questa ossessione per l’oscuro non sia in realtà un meccanismo per capire alcuni lati della mia personalità. Perché se è vero che i mostri possono essere umani, allora è vero anche il contrario: non sappiamo dove si nasconderà il Male, se addirittura dentro di noi. E su questo si interroga la Maestra dell’horror, Shirley Jackson, che in Abbiamo sempre vissuto nel castello costruisce la storia horror perfetta, senza mai dover alzare la voce. È nelle atmosfere della casa vuota, nel rifiuto del paese verso la famiglia protagonista, nella voce stessa di Mary Kathrine – elusiva, a tratti infantile ma estremamente maliziosa – che si gioca il ribaltamento e l’orrore. Eppure, anche conosciuta la verità, è impossibile non amare questa ragazza, che avrebbe potuto nascere lupo mannaro.
Mentre scrivevo La stagione più crudele, mi sono interrogata moltissimo sul fascino che il Male e i mostri esercitano su di me, e mi sono domandata quanto questa ossessione per l’oscuro non sia in realtà un meccanismo per capire alcuni lati della mia personalità. Perché se è vero che i mostri possono essere umani, allora è vero anche il contrario: non sappiamo dove si nasconderà il Male, se addirittura dentro di noi. E su questo si interroga la Maestra dell’horror, Shirley Jackson, che in Abbiamo sempre vissuto nel castello costruisce la storia horror perfetta, senza mai dover alzare la voce. È nelle atmosfere della casa vuota, nel rifiuto del paese verso la famiglia protagonista, nella voce stessa di Mary Kathrine – elusiva, a tratti infantile ma estremamente maliziosa – che si gioca il ribaltamento e l’orrore. Eppure, anche conosciuta la verità, è impossibile non amare questa ragazza, che avrebbe potuto nascere lupo mannaro.
Quello che so per certo è che da piccola, quando tornavo a casa, avevo mille altre strade per arrivare al mio portone. Avrei potuto scegliere quella centrale, che correva lungo la piazza. Oppure la stradina in cui c’era un luminosissimo lampione, proprio al centro. Ma io preferivo correre in quel vicolo buio, con i mostri attaccati addosso, nascondendo nella paura la speranza che un giorno mi avrebbero presa davvero.

