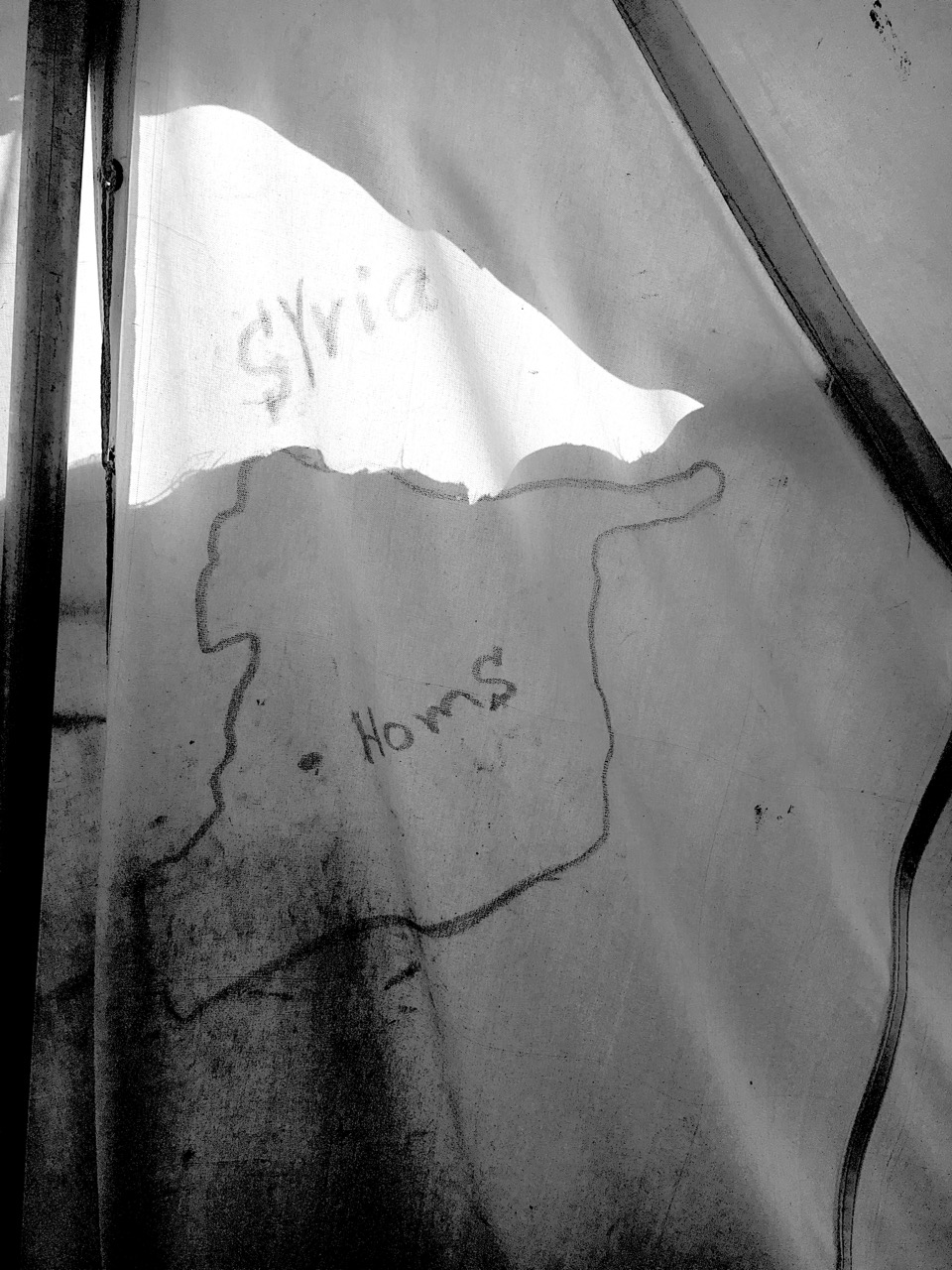filo spinato dei militari o le torri di fumo delle fabbriche di periferia. Le indicazioni per i campi dei migranti in Grecia sono tutte uguali. Che sia Petra , 1231 persone accampate sul monte Olimpo nel nord del Paese, o Skaramangas , 3200 migranti dentro container nella spianata di cemento di un porto a 45 minuti di autobus dal centro di Atene.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>New Gallery 2017/1/17</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 482</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0002859594</span><span>dir</span>:<span> 60</span><span>alt</span>:<span> 107</span><span>lat</span>:<span> 41.094669</span><span>long</span>:<span> 22.769247</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 9:41:26 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 727</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0001950078</span><span>dir</span>:<span> 84</span><span>alt</span>:<span> 109</span><span>lat</span>:<span> 41.095036</span><span>long</span>:<span> 22.769231</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 9:40:23 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 636</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0002600104</span><span>dir</span>:<span> 23</span><span>alt</span>:<span> 109</span><span>lat</span>:<span> 41.094933</span><span>long</span>:<span> 22.769278</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 9:40:38 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 713</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0003640335</span><span>dir</span>:<span> 39</span><span>alt</span>:<span> 109</span><span>lat</span>:<span> 41.095322</span><span>long</span>:<span> 22.769356</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 9:39:46 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 790</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000454959052</span><span>dir</span>:<span> 9</span><span>alt</span>:<span> 109</span><span>lat</span>:<span> 41.095322</span><span>long</span>:<span> 22.769356</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 9:39:49 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000324991881</span><span>dir</span>:<span> 313</span><span>alt</span>:<span> 109</span><span>lat</span>:<span> 41.095275</span><span>long</span>:<span> 22.769133</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 9:39:08 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:42:30 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 26</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:42:34 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 45</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:55:32 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 24</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 3:11:34 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 506</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00022099448</span><span>dir</span>:<span> 265</span><span>alt</span>:<span> 109</span><span>lat</span>:<span> 41.095269</span><span>long</span>:<span> 22.769136</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 9:39:02 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:42:21 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000845308532</span><span>dir</span>:<span> 276</span><span>alt</span>:<span> 136</span><span>lat</span>:<span> 40.256328</span><span>long</span>:<span> 22.367264</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 11:37:45 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00512820529</span><span>dir</span>:<span> 119</span><span>alt</span>:<span> 130</span><span>lat</span>:<span> 40.255783</span><span>long</span>:<span> 22.366589</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 10:00:45 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000403063284</span><span>dir</span>:<span> 27</span><span>alt</span>:<span> 124</span><span>lat</span>:<span> 40.255733</span><span>long</span>:<span> 22.366603</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 10:07:36 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 896</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000610873569</span><span>dir</span>:<span> 128</span><span>alt</span>:<span> 134</span><span>lat</span>:<span> 40.255669</span><span>long</span>:<span> 22.367628</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 10:40:31 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.01</span><span>dir</span>:<span> 226</span><span>alt</span>:<span> 129</span><span>lat</span>:<span> 40.255825</span><span>long</span>:<span> 22.366536</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 10:00:25 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 1280</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00584795326</span><span>dir</span>:<span> 243</span><span>alt</span>:<span> 131</span><span>lat</span>:<span> 40.255775</span><span>long</span>:<span> 22.366556</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 10:00:33 PM</span><span>width</span><span> 960</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000494071166</span><span>dir</span>:<span> 141</span><span>alt</span>:<span> 124</span><span>lat</span>:<span> 40.255689</span><span>long</span>:<span> 22.366789</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:54:55 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000324991881</span><span>dir</span>:<span> 187</span><span>alt</span>:<span> 127</span><span>lat</span>:<span> 40.255689</span><span>long</span>:<span> 22.366789</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:55:01 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 900</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00239234441</span><span>dir</span>:<span> 265</span><span>alt</span>:<span> 129</span><span>lat</span>:<span> 40.255817</span><span>long</span>:<span> 22.367225</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:41:50 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00952381</span><span>dir</span>:<span> 51</span><span>alt</span>:<span> 129</span><span>lat</span>:<span> 40.255811</span><span>long</span>:<span> 22.367206</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:41:59 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 834</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00106609811</span><span>dir</span>:<span> 128</span><span>alt</span>:<span> 130</span><span>lat</span>:<span> 40.255878</span><span>long</span>:<span> 22.366983</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:47:05 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 956</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000299043051</span><span>dir</span>:<span> 248</span><span>alt</span>:<span> 110</span><span>lat</span>:<span> 40.255650</span><span>long</span>:<span> 22.366969</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:50:28 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000545851537</span><span>dir</span>:<span> 232</span><span>alt</span>:<span> 130</span><span>lat</span>:<span> 40.256081</span><span>long</span>:<span> 22.367100</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:37:46 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 954</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 306</span><span>alt</span>:<span> 135</span><span>lat</span>:<span> 40.256067</span><span>long</span>:<span> 22.367286</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:05:48 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.05882353</span><span>dir</span>:<span> 290</span><span>alt</span>:<span> 126</span><span>lat</span>:<span> 40.256042</span><span>long</span>:<span> 22.367242</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:06:33 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 854</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 203</span><span>alt</span>:<span> 127</span><span>lat</span>:<span> 40.256236</span><span>long</span>:<span> 22.367336</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:14:24 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00877193</span><span>dir</span>:<span> 169</span><span>alt</span>:<span> 124</span><span>lat</span>:<span> 40.256233</span><span>long</span>:<span> 22.367297</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:25:39 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.05882353</span><span>dir</span>:<span> 273</span><span>alt</span>:<span> 114</span><span>lat</span>:<span> 40.256022</span><span>long</span>:<span> 22.367125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 8:28:21 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 920</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.01</span><span>dir</span>:<span> 124</span><span>alt</span>:<span> 132</span><span>lat</span>:<span> 40.256225</span><span>long</span>:<span> 22.367328</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 8:48:26 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.01</span><span>dir</span>:<span> 209</span><span>alt</span>:<span> 125</span><span>lat</span>:<span> 40.256306</span><span>long</span>:<span> 22.367275</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/16/2016 9:03:26 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.05882353</span><span>dir</span>:<span> 346</span><span>alt</span>:<span> 133</span><span>lat</span>:<span> 40.255742</span><span>long</span>:<span> 22.367050</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/15/2016 10:50:08 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.01</span><span>dir</span>:<span> 8</span><span>alt</span>:<span> 148</span><span>lat</span>:<span> 40.255794</span><span>long</span>:<span> 22.367036</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/15/2016 10:50:22 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 871</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0007930214</span><span>dir</span>:<span> 213</span><span>alt</span>:<span> 145</span><span>lat</span>:<span> 40.255794</span><span>long</span>:<span> 22.367031</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/15/2016 10:50:41 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 129</span><span>alt</span>:<span> 148</span><span>lat</span>:<span> 40.256092</span><span>long</span>:<span> 22.367439</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/15/2016 9:53:58 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.01</span><span>dir</span>:<span> 44</span><span>alt</span>:<span> 144</span><span>lat</span>:<span> 40.255547</span><span>long</span>:<span> 22.367436</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/15/2016 10:20:36 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 939</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.05882353</span><span>dir</span>:<span> 16</span><span>alt</span>:<span> 125</span><span>lat</span>:<span> 40.255525</span><span>long</span>:<span> 22.367353</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/15/2016 10:49:51 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span>
Cherso è a due chilometri da Salonicco: per arrivarci solo campi e un distributore dimenticato in mezzo alle sterpaglie. Il confine con l’Albania dista poche ore in macchina, giorni infiniti di cammino se sei a piedi.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>New Gallery 2017/1/17</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 896</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000740740739</span><span>dir</span>:<span> 163</span><span>alt</span>:<span> 185</span><span>lat</span>:<span> 38.387444</span><span>long</span>:<span> 23.504811</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 8:30:22 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000572082354</span><span>dir</span>:<span> 205</span><span>alt</span>:<span> 193</span><span>lat</span>:<span> 38.387803</span><span>long</span>:<span> 23.505097</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 8:27:48 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00111856824</span><span>dir</span>:<span> 232</span><span>alt</span>:<span> 184</span><span>lat</span>:<span> 38.387378</span><span>long</span>:<span> 23.505019</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 8:29:29 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0004810005</span><span>dir</span>:<span> 125</span><span>alt</span>:<span> 188</span><span>lat</span>:<span> 38.387761</span><span>long</span>:<span> 23.504400</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 8:08:39 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 1280</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000545851537</span><span>dir</span>:<span> 2</span><span>alt</span>:<span> 189</span><span>lat</span>:<span> 38.387981</span><span>long</span>:<span> 23.505494</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 8:24:48 PM</span><span>width</span><span> 960</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000246974552</span><span>dir</span>:<span> 109</span><span>alt</span>:<span> 207</span><span>lat</span>:<span> 38.387908</span><span>long</span>:<span> 23.504486</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 8:07:44 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 923</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.001222494</span><span>dir</span>:<span> 111</span><span>alt</span>:<span> 181</span><span>lat</span>:<span> 38.387650</span><span>long</span>:<span> 23.504331</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 8:06:30 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span>
Ritsona giace addormentato sotto alberi altissimi sulla strada che porta a Vathy, 70 chilometri a Nord di Atene: qui ci stanno in 1200 e le condizioni sono buone fino a quando non si mette a piovere. Allora le tende diventano pesanti tonnellate e i sentieri che separano i giacigli come fossi di fango che inghiottono tutto.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>New Gallery 2017/1/17</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 816</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0009099181</span><span>dir</span>:<span> 200</span><span>alt</span>:<span> 250</span><span>lat</span>:<span> 38.239875</span><span>long</span>:<span> 23.780078</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:51:28 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 908</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 207</span><span>alt</span>:<span> 246</span><span>lat</span>:<span> 38.240008</span><span>long</span>:<span> 23.780300</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:06:26 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 944</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 276</span><span>alt</span>:<span> 258</span><span>lat</span>:<span> 38.240039</span><span>long</span>:<span> 23.780133</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:15:22 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 838</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000312012475</span><span>dir</span>:<span> 290</span><span>alt</span>:<span> 255</span><span>lat</span>:<span> 38.239886</span><span>long</span>:<span> 23.780139</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:51:17 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span>
Malakasa dista solo un’ora da Ritsona: è uno spazio ricavato dentro un campo militare e nessuno può entrare o fare foto. Da fuori sembra la pista di un aeroporto abbandonato, dentro c’è solo la puzza di escrementi che non se ne va nemmeno dopo le pulizie. La tende allestite possono accogliere fino a 1500 persone, ma il numero varia continuamente durante l’anno.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>New Gallery 2017/1/17</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 977</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0007800312</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 6:45:28 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 825</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 171</span><span>alt</span>:<span> 162</span><span>lat</span>:<span> 40.710689</span><span>long</span>:<span> 22.959514</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 6:09:39 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 913</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 61</span><span>alt</span>:<span> 174</span><span>lat</span>:<span> 40.710675</span><span>long</span>:<span> 22.959892</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 6:15:18 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00184842886</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 6:45:24 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 953</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.02</span><span>dir</span>:<span> 72</span><span>alt</span>:<span> 161</span><span>lat</span>:<span> 40.710750</span><span>long</span>:<span> 22.959611</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 5:45:38 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 924</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 114</span><span>alt</span>:<span> 161</span><span>lat</span>:<span> 40.710822</span><span>long</span>:<span> 22.959619</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 5:45:45 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 947</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 136</span><span>alt</span>:<span> 161</span><span>lat</span>:<span> 40.710686</span><span>long</span>:<span> 22.959508</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 5:52:53 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 948</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 221</span><span>alt</span>:<span> 162</span><span>lat</span>:<span> 40.710750</span><span>long</span>:<span> 22.959253</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 6:09:20 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.02</span><span>dir</span>:<span> 242</span><span>alt</span>:<span> 162</span><span>lat</span>:<span> 40.710800</span><span>long</span>:<span> 22.959586</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 5:45:25 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span>
Elpida è nato l’estate scorsa: costruito dentro lo scheletro di una fabbrica di jeans che non c’è più. Si affaccia sulla strada provinciale di Salonicco: da lì si vede solo cemento e macchine sparate a 100 chilometri all’ora. I corridoi sembrano quelli di un ospedale e dentro vengono accolti i casi più disperati: sono fortunati.
A pochi chilometri di distanza, a Mygodnia , hanno risolto il problema alla radice. Mettono le tende dentro i capannoni di fabbriche abbandonate così quando piove sembra solo che crolli il soffitto sotto le mitragliate di gocce di pioggia. Il caldo è un gas letale, che si solleva dal pavimento e rimbomba come un tuono: toglie l’aria. Il freddo è un coltello, trapassa i vestiti e punge le costole: non dà pace. I bambini giocano nei vialetti su cui si affacciano le baracche, a volte alzano la testa e guardano l’orizzonte che sembra non finire mai.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>New Gallery 2017/1/17</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 945</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0005070994</span><span>dir</span>:<span> 95</span><span>alt</span>:<span> 8</span><span>lat</span>:<span> 40.645569</span><span>long</span>:<span> 22.824181</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 4:26:12 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 7</span><span>alt</span>:<span> 2</span><span>lat</span>:<span> 40.645906</span><span>long</span>:<span> 22.823008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 4:02:29 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 815</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0007147963</span><span>dir</span>:<span> 297</span><span>alt</span>:<span> 11</span><span>lat</span>:<span> 40.645528</span><span>long</span>:<span> 22.824119</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 4:20:22 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000727802049</span><span>dir</span>:<span> 66</span><span>alt</span>:<span> 10</span><span>lat</span>:<span> 40.645314</span><span>long</span>:<span> 22.824106</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 4:21:01 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 892</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00080580177</span><span>dir</span>:<span> 63</span><span>alt</span>:<span> 12</span><span>lat</span>:<span> 40.645356</span><span>long</span>:<span> 22.824147</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 4:23:59 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 952</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 340</span><span>alt</span>:<span> 39</span><span>lat</span>:<span> 40.645828</span><span>long</span>:<span> 22.822361</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 3:16:37 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 259</span><span>alt</span>:<span> 8</span><span>lat</span>:<span> 40.645844</span><span>long</span>:<span> 22.822917</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 3:28:39 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 10</span><span>alt</span>:<span> 2</span><span>lat</span>:<span> 40.645875</span><span>long</span>:<span> 22.823186</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 4:01:43 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span>
Se chiedi informazioni lungo il tragitto per arrivare ai campi profughi la risposta è sempre la stessa: “Dicono che siano laggiù, ma noi non li vediamo quasi mai”. Balbettii, braccia che si aprono al cielo e sospiri. “Ma li cercate davvero? Li hanno messi da qualche parte ma non sappiamo dove”. Gli oltre 60mila migranti che arrivano in Grecia sognando l’Europa trovano l’oblio in campi dispersi in posti perduti, lembi di terra che tutti hanno dimenticato e che diventano perfetti per nascondere tragedie agli occhi del mondo. Di solito basta girare una curva e si aprono comunità, piccole cittadine cresciute all’ombra degli abitanti del posto con camionette dell’esercito o della polizia a fare la guardia. Sono distese di tende o container: il cibo che arriva da fuori almeno una volta al giorno, i bagni in strutture esterne per provare a garantire livelli minimi di igiene e l’assistenza medica a giorni alterni, sperando di sentirsi male all’ora giusta quando è aperto l’ambulatorio.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>New Gallery 2017/1/17</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000896860962</span><span>dir</span>:<span> 45</span><span>alt</span>:<span> 14</span><span>lat</span>:<span> 40.586747</span><span>long</span>:<span> 22.939344</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 11:00:26 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 924</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000246974552</span><span>dir</span>:<span> 64</span><span>alt</span>:<span> 7</span><span>lat</span>:<span> 40.669614</span><span>long</span>:<span> 22.875192</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 7:59:33 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000233972853</span><span>dir</span>:<span> 69</span><span>alt</span>:<span> 7</span><span>lat</span>:<span> 40.669578</span><span>long</span>:<span> 22.875186</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/12/2016 7:59:16 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span>
Il buio è un burrone che si apre ogni notte puntuale e inghiotte le vite di chi sta dentro alloggi di fortuna aspettando che passi il dolore. La sicurezza è la prima preoccupazione: da Elleniko nel cuore di Atene a Sofitex vicino a Salonicco i casi di violenze si ripetono uguali nei mesi. I report non diventano mai ufficiali, ma sono storie che con lo stampino vengono riportate da volontari e abitanti dei campi. “Non ci sono abbastanza forze dell’ordine”, spiegano, “e spesso le violenze riguardano donne e bambini che poi non hanno il coraggio di raccontare quello che succede”. I campi sono piccole città con le loro regole: se non ci sono abbastanza controllori, sarà la comunità a scegliere autonomamente i suoi. E non sempre sono quelli giusti.
Per raggiungere Petra servono due ore di viaggio se parti da Katerini , tre se arrivi da Salonicco . Quando passi il campo da basket abbandonato sulla sinistra e cominci a vedere il monte Olimpo solo se ti sporgi sul volante, allora sei nella direzione giusta. Poi sono sentieri che si fanno sempre più stretti, tornanti e un cancello in mezzo alle foglie. Il campo di tende color ocra si apre all’improvviso quando giri l’ultima curva e rimane solo lo strapiombo. Lì, in cima, fino agli anni ’50 c’era una clinica per i malati psichiatrici. Di quel tempo di fantasmi e dolori sono rimasti i corridoi scrostati di un edificio color mattone e una pagina della bibbia scritta in italiano e appiccicata contro il muro.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>no name</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 1280</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.008064516</span><span>dir</span>:<span> 243</span><span>alt</span>:<span> 373</span><span>lat</span>:<span> 40.197614</span><span>long</span>:<span> 22.320714</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 5:22:59 PM</span><span>width</span><span> 895</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0006238303</span><span>dir</span>:<span> 222</span><span>alt</span>:<span> 382</span><span>lat</span>:<span> 40.197983</span><span>long</span>:<span> 22.320975</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:57:04 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 863</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000766871148</span><span>dir</span>:<span> 221</span><span>alt</span>:<span> 379</span><span>lat</span>:<span> 40.197839</span><span>long</span>:<span> 22.320722</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 5:18:37 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 869</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.000871080148</span><span>dir</span>:<span> 332</span><span>alt</span>:<span> 393</span><span>lat</span>:<span> 40.197706</span><span>long</span>:<span> 22.320739</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:26:05 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 900</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0303030312</span><span>dir</span>:<span> 155</span><span>alt</span>:<span> 391</span><span>lat</span>:<span> 40.197772</span><span>long</span>:<span> 22.320764</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:05:13 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 4.15</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> Apple</span><span>height</span><span> 960</span><span>fnumber</span><span> 2.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.00080580177</span><span>dir</span>:<span> 336</span><span>alt</span>:<span> 389</span><span>lat</span>:<span> 40.197586</span><span>long</span>:<span> 22.320522</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 4:16:15 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> iPhone 6s</span><span>focallength</span><span> 55</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:05:52 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 36</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 8</span><span>exposuretime</span><span> 0.004</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:05:57 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 24</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:04:33 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 8</span><span>exposuretime</span><span> 0.004</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:04:53 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 55</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 807</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:05:08 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 24</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 6.3</span><span>exposuretime</span><span> 0.005</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:04:16 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 55</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 8</span><span>exposuretime</span><span> 0.004</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:04:23 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 24</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 846</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:03:54 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 55</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 7.1</span><span>exposuretime</span><span> 0.005</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:03:29 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 28</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 752</span><span>fnumber</span><span> 10</span><span>exposuretime</span><span> 0.0025</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:03:05 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 55</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 8</span><span>exposuretime</span><span> 0.004</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:01:05 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 732</span><span>fnumber</span><span> 10</span><span>exposuretime</span><span> 0.0025</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:01:41 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 832</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:01:47 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 50</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 9</span><span>exposuretime</span><span> 0.003125</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 1:00:38 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 48</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:56:11 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 52</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:58:48 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 36</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:53:58 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 48</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 7.1</span><span>exposuretime</span><span> 0.005</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:36:53 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 40</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 7.1</span><span>exposuretime</span><span> 0.005</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:38:17 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 6.3</span><span>exposuretime</span><span> 0.00625</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:23:52 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 48</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 791</span><span>fnumber</span><span> 8</span><span>exposuretime</span><span> 0.004</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:36:49 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:23:27 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 29</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 7.1</span><span>exposuretime</span><span> 0.005</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/11/2016 12:21:14 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span>
Nella Grecia dell’emergenza migranti qualcuno ha pensato che quello era il posto giusto per mettere 1231 rifugiati yazidi , minoranza religiosa perseguitata dai musulmani in patria ma pure nei campi migranti. “Qui saremo al sicuro”, dice una volontaria. “Fino a quando non arriverà l’inverno”. Parla al plurale perché lei, che è biondo platino e viene dall’Austria, rimarrà fino alla fine. Ci vorrà la neve di inizio dicembre per convincere il governo che deve spostare i migranti in strutture provvisorie per evitare che muoiano di freddo. Nel frattempo tutti aspettano. “Le persone possono andarsene quando vogliono, ma come?” Se per lasciare un posto hai bisogno dell’autorizzazione, allora è come stare in una prigione. Gli adulti vagano inquieti chiedendosi fino a quando durerà, fino a quando resisteranno. I bambini saltano la corda, cantano filastrocche in attesa che inizi la scuola. “Quella è casa mia”, dice Iona mentre indica una delle tende della spianata. “Ma non quella vera”.
La vergogna di Atene invece è nascosta nell’ex aeroporto della città, quello dove nel 2004 hanno costruito i campi sportivi per le Olimpiadi. Si chiama Elleniko ed è sulla strada per Glifada . Il tassista dice che quella è come la Los Angeles dei greci, con la strada che dà sul mare e le palme e le spiagge che se chiudi gli occhi sembra di stare in un film. Da qualche anno i bar hanno chiuso e gli hotel hanno meno stanze. Passano ragazzini a vendere ciambelle e patatine per i turisti coraggiosi che si arrampicano fino alla Grecia che non c’è più e scelgono ancora di passare qui le vacanze. “Perché sembra l’America con il cibo più buono”, dice il tassista girandosi verso il sedile passeggeri e aspettando un segno di approvazione. Elleniko non lo vede nessuno. E’ dietro un cavalcavia e la fermata del tram è rivolta verso la spiaggia, così che se proprio non volti la testa non sei costretto a incontrarlo. L’ingresso è un cancello con le baracche intorno. Dentro il recinto ci stanno tre palazzetti di cui due allestiti per ospitare i migranti. Fuori, accampati sul cemento tra i tuoni dei camion di passaggio, ci sono trenta famiglie. I bambini giocano con i ciottoli davanti alle guardie, due, che presidiano una zona con migliaia di persone.
A Elleniko non entra quasi nessuno, al massimo qualche associazione di volontariato e solo quando è proprio necessario. Un giorno è scoppiata una rissa e nessuno ha potuto fare niente. I militari hanno aspettato che se la sbrigassero da soli perché erano pochi e sarebbe successa una rivoluzione. “Lì dentro è pericoloso”, dicono i volontari. “Non abbiamo le forze per gestire da soli la zona”. La spianata di Elleniko è lunga chilometri di vuoto. Fa stanchezza solo a guardarla, quando devi prendere la forza di uscire dalla tua tenda raffazzonata sul campo sportivo e trascinarti da qualche parte. Poco distante c’è il palazzetto che fu costruito per giocare a basket . Oggi è il magazzino più grande della Grecia e raccoglie gli aiuti che arrivano da tutto il mondo. Al centro il campo abbandonato con le retine dei canestri che penzolano come rami di salici piangenti. Intorno, sugli spalti e le gradinate, scatoloni di maglie, scarpe, passeggini, accessori per la scuola, pantaloni, sciarpe, guanti, giocattoli.
Powered by Cincopa <a href=’https://www.cincopa.com/media-platform/html-slideshow’>Slideshow HTML</a> for Business solution.<span>New Gallery 2017/1/17</span><span>focallength</span><span> 20</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 752</span><span>fnumber</span><span> 8</span><span>exposuretime</span><span> 0.004</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/9/2016 12:31:37 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 36</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 776</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/9/2016 12:39:42 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 20</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 789</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.008</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/9/2016 12:41:30 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.01</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/9/2016 4:09:26 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 24</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 625</span><span>fnumber</span><span> 7.1</span><span>exposuretime</span><span> 0.005</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/9/2016 4:36:57 AM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 52</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 5.6</span><span>exposuretime</span><span> 0.025</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:59:29 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 799</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.02</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 11:53:06 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.05</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 11:53:12 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 26</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 4.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.02</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:57:34 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 812</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:58:26 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 637</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:58:34 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 26</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 1280</span><span>fnumber</span><span> 4.2</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:58:47 PM</span><span>width</span><span> 1278</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 816</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:55:29 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 900</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:55:49 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 824</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:56:02 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 18</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 3.5</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:56:12 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span><span>focallength</span><span> 24</span><span>flash</span><span> 16</span><span>cameramake</span><span> NIKON CORPORATION</span><span>height</span><span> 853</span><span>fnumber</span><span> 4</span><span>exposuretime</span><span> 0.0166666675</span><span>orientation</span><span> 1</span><span>camerasoftware</span><span> Adobe Photoshop CS6 </span><span>originaldate</span><span> 8/8/2016 10:57:00 PM</span><span>width</span><span> 1280</span><span>cameramodel</span><span> NIKON D3100</span>
C’è pure una scala della vergogna con gli oggetti poco appropriati: tacchi alti e scarpe dai colori fosforescenti, poi minigonne e vestiti scollati. I volontari sospirano ogni volta che ci passano a fianco: “Forse il mondo non ha capito bene cosa succede qui”. Gli scatoloni arrivano con i container del mattino, se ne vanno con i furgoni dei volontari. Dentro le formiche che li smistano e li ordinano secondo qualità e forma, secondo le stagioni. Chi comanda è Katalina , ex dipendente dello Stato in pensione. Ha un foglio scarabocchiato dove cerca di dare ordine a quello che entra ed esce. Non ci riesce quasi mai. Il risultato è un caos di ingressi ed uscite, la frustrazione del non fare mai abbastanza. Poi succede che gli afghani si organizzano e rompono il vetro della palestra. Si intrufolano di notte e rubano i vestiti. E c’è da cominciare da capo. Un giorno hanno scoperto che qualcuno prendeva gli scatoloni e li rivendeva al mercato nero. Katalina ha pianto, ma era nascosta dentro il bagno e non se ne è accorto nessuno.
Rita arriva dopo le sei, quando ha chiuso le ultime pratiche al lavoro e chiamato la figlia per chiederle di stendere i panni in lavatrice. Entra nel magazzino con il suo sorriso di realtà, di chi sa che va tutto male, ma continuerà a tirare pugni all’aria finché non avrà finito le energie. “La verità è che l’Europa si è dimenticata di noi”. Il giorno che è scoppiata l’emergenza dei migranti, quando sono iniziati gli sbarchi ad Atene, lei era a letto con una spalla ingessata. “Guardavo quel flusso di persone e mi chiedevo, e adesso?”.
<span>New Gallery 2015/2/19</span><span>test test</span>
Ha fatto quello che hanno fatto decine di greci: si è messa a dare una mano. “Lottiamo per piccoli scampoli di speranza, ma è sempre meglio che stare a guardare. Il problema è che manca un coordinamento degli aiuti. Arrivano vestiti, ma qui scarseggia il cibo. Servono medicine e più controlli. Senza il lavoro dei volontari, i migranti sarebbero allo stremo”. Non è una minaccia la sua: “Non dico che ce ne andremo. Saremo qui domani e anche il giorno dopo domani. Ma non basta”. Sorride sotto quella testa di ricci così pesante e il trucco sbavato.
Un giorno soltanto, Rita ha pensato di mollare. E’ stato quando ha conosciuto tre fratelli siriani che aspettavano la sorella ancora bloccata ad Aleppo . Quando ha chiesto informazioni per aiutarla ad arrivare in Grecia e quando nel cuore della notte è squillato il suo cellulare personale. C’era un uomo, in viaggio su quello stesso gommone, che aveva un numero per avvisare chi la stava aspettando. “I migranti partono e si mettono d’accordo con i compagni di viaggio perché avvisino chi li sta aspettando nel caso in cui non riescano ad arrivare all’altra sponda”. Quella notte è andata così. Uno sconosciuto le ha detto: “Rita, Alia non ce l’ha fatta”. E lei ha dovuto comunicare ai fratelli che la sorella non sarebbe mai arrivata in Grecia. “Mi hanno chiesto di andare a cercarla, di fare il giro dell’isola di Lesbo in macchina per vedere se il cadavere fosse arrivato sulla riva”, dice con la voce che va e viene. “Li ho convinti a fare il funerale senza il corpo. Ci sarebbe voluto troppo tempo, sarebbe stato troppo doloroso”. Poi Rita, chiusa in macchina a ingoiare le lacrime come fosse una ragazzina, ha telefonato a sua figlia: “Resta lì dove sei, torno a casa”.
Powered by Cincopa Slideshow HTML for Business solution.New Gallery 2017/2/24 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1280 height 793 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1280 height 796 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1280 height 737
Come se la vita fosse un uccello rapace che porta via le cose all’improvviso e ti aggredisce alle spalle. “Da quel giorno non riesco più a dormire. E faccio di tutto per aiutare chi arriva disperato sulle sponde della mia terra”.
 1 /38
IMG_6281
1 /38
IMG_6281

 1 /7
IMG_5788copy
1 /7
IMG_5788copy

 1 /4
IMG_5807
1 /4
IMG_5807

 1 /9
IMG_6137
1 /9
IMG_6137

 1 /8
IMG_6037
1 /8
IMG_6037

 1 /3
IMG_6146
1 /3
IMG_6146

 1 /29
DSC_0104
1 /29
DSC_0104

 1 /17
1 /17

 1 /3
DSC_0089
1 /3
DSC_0089